Pensare per immagini. Il principio drammaturgico del montaggio
A partire dall’Abicì della guerra di Bertolt Brecht*
Daniela Sacco
English abstract
D’accordo con Arnold Hauser si può affermare che il ‘Novecento’ comincia dopo la Prima guerra mondiale, cioè fra il 1920 e il 1930, come l’‘Ottocento’ era cominciato solo con il 1830, ossia con quella che è stata nominata ‘la rivoluzione di luglio’, o seconda rivoluzione francese (Hauser [1955/1956] 1967, 451). Le guerre, in forma diversa rispetto al frangente storico in cui si collocano, registrando profonde crisi sociali, dischiudono quindi una cesura rispetto al passato e corrispondono alla nascita di una nuova visione del mondo.
Il ‘pensare per immagini’ sembra essere il tratto saliente della visione del mondo che permea la trasformazione della coscienza nel XX secolo a seguito della fine della modernità illuministicamente intesa. La Prima e la Seconda guerra mondiale – le tragedie del Novecento – segnano infatti una frattura nel passaggio dalla visione del mondo della modernità a quella che è stata definita ‘postmodernità’. Si è assistito cioè alla crisi della forma metafisica di pensiero che improntata sulla supremazia del logos sul mythos ha predominato come paradigma concettuale nella cultura europea dall’antichità fino al XIX, e, di seguito all’emersione di un pensiero diversamente improntato all’immagine: un ‘pensiero per immagini’ appunto, che, in una terminologia ancora influenzata da un’ottica evoluzionistica, indica l’ambito del ‘prelogico’ o del ‘prediscorsivo’, come ad esempio è stato definito da Olaf Breidbach e Federico Vercellone (Breidbach-Vercellone 2010).
La fine del pensiero metafisico è accompagnata alla crisi del concetto di identità e unità trascendentale che lo ha governato nelle sue declinazioni filosofiche e religiose e nell’episteme della scienza moderna. Nel passaggio tragico dalla distruzione di un ordine – il caos – alla creazione di un nuovo ordine – il cosmos – attraverso un inedito o rinnovato paradigma gnoseologico dell’immagine, ad essere stravolto è anche il modo di intendere il rapporto tra le parti e l’intero, a sua volta riflesso in un diverso modo di percepire lo spazio e il tempo. Il rapporto tra particolare e universale, unità e molteplicità si ridefinisce rispetto all’approccio consolidato dal pensiero logico filosofico tendente a ridurre il molteplice nell’unità e nell’identità. Nel pensiero improntato all’immagine, il rapporto tra l’uno e i molti è rovesciato: non è l’unità che contiene il molteplice ma il molteplice che contiene al suo interno l’unità e l’identità. E questo avviene di riflesso a una ricollocazione dell’uomo nel mondo che si smarca dall’impostazione dualista moderna secondo cui il rapporto uomo - mondo è basato fondamentalmente sulla frattura cartesiana tra io e non io, res cogitans e res extensa.
La forma del pensare eminentemente visiva, attraverso cui si articola questo mutato rapporto tra uomo e mondo e tra particolare e universale risulta essere leggibile strutturalmente attraverso il meccanismo compositivo del montaggio. Termine novecentesco preso a prestito dal cinema – nuova arte che significativamente inaugura il XX secolo – e traslato a significare un dispositivo più generale, il montaggio appare allora come il principio costruttivo e il dispositivo compositivo del pensare per immagini. Nella misura in cui il Novecento risolve il dualismo moderno è affine a quel pensiero che viene prima del dualismo: il pensiero antico, per cui la conoscenza è profondamente veicolata dal paradigma visivo ed è nella sua natura tragica e mitica, come tragica è la cifra del secolo scorso.
Si potrebbe tracciare una costellazione molto ampia di intellettuali e artisti che nel secolo scorso, in ambiti disciplinari diversi, hanno denunciato la crisi della modernità introducendo una visione del mondo alternativa a quella che la modernità stessa sottende, permeata da un rinnovato valore gnoseologico attribuito all’immagine. È però nel contesto teatrale che è possibile riconoscere il pensare per immagini – e il meccanismo che lo informa, il montaggio – nella sua peculiarità profondamente drammatica, e quindi tragica. Questa riflessione parte nello specifico da un’opera che ha preso forma nella temperie tragica della Seconda guerra mondiale: la Kriegsfibel di Bertolt Brecht, ossia il ‘sillabario’, l’Abicì della guerra, come è stato tradotto nella prima edizione italiana pubblicata da Einaudi nel 1972. Si tratta di un’opera significativa per molteplici aspetti: oltre che per il frangente storico in cui viene creata, anche per la forma che la contraddistingue e per il fatto che, pur non essendo un lavoro teatrale, è rivelativa del metodo teatrale del suo autore. È inoltre un’opera interessante da considerare alla luce delle riflessioni teoriche e al mutato atteggiamento di Brecht nei confronti dei classici e del mito dopo l’esperienza dell’esilio avvenuto durante la Seconda guerra mondiale.
Come ha argomentato Georges Didi-Huberman, l’Abicì della guerra può essere considerato a tutti gli effetti un caso di ‘forma Atlante’ se posto a confronto con l’esemplare supremo del Bilderatlas Mnemosyne di Aby Warburg (Didi-Huberman 2009). Il sillabario composto da Brecht è di fatto un atlante fotografico sul tema della guerra che nella struttura tematica sembra seguire cronologicamente lo svolgimento del conflitto mondiale: dalla guerra di Spagna alla controffensiva degli Alleati al ritorno dei prigionieri. Pubblicato per la prima volta nel 1955 nella Berlino Est, dopo una serie di rimaneggiamenti e non poche battaglie contro tentativi di censura, l’Abicì della guerra viene invero composto molto prima, nel contesto tragico dell’esilio che tiene Brecht lontano dall’impegno attivo ed esclusivo in teatro per ben quindici anni, dal 1933 al 1947. L’esilio, cominciato il 28 febbraio del 1933, il giorno dopo l’incendio del Reichstag, a seguito dell’avvento al potere di Hitler e del partito nazionalsocialista in Germania, durerà fino al 1947 e lo porterà a vivere per periodi di tempo diversi a Praga, Parigi, Londra, Mosca, in Danimarca, a Stoccolma, in Finlandia, a Leningrado, di nuovo a Mosca e infine negli Stati Uniti, passando da Los Angeles a New York, per poi tornare a Zurigo e infine a Berlino. Rientrato in Germania, nel 1948 Brecht si stabilisce definitivamente nella Berlino Est dove riprende a lavorare e fonda il Berliner Ensemble.
La struttura compositiva di questo particolare atlante segue il meccanismo dell’assemblaggio associativo di immagini e testi e risulta fatto secondo lo stesso metodo dell’Arbeitsjournal (Diario di lavoro), a cui si dedica Brecht durante tutto il periodo dell’esilio (Brecht [1938-42; 1942-55] 1976). Il Diario di lavoro, a cui Brecht ricorrerà in modo più programmatico anche per studiare e costruire alcune messe in scena, è un montaggio di testi di varia natura e di immagini altrettanto varie che ritaglia e incolla seguendo il flusso associativo del suo pensiero. Nel considerare l’Abicì della guerra un’opera significante nell’orizzonte del ‘pensare per immagini’ tre sono gli aspetti su cui posare l’attenzione: l’appartenenza al contesto della guerra; la sua peculiarità formale; il legame metodologico e insieme poetico e compositivo con il lavoro drammaturgico dell’autore.
Il lavoro sul singolare abbecedario è quindi il frutto della condizione di esiliato in cui è costretto Brecht, per lo più senza la possibilità di lavorare in teatro, senza denaro e in contesti culturali e linguistici estranei, ovvero in una condizione assolutamente precaria in cui “non era in grado di fare altro che ritagliare immagini della stampa e comporre qualche ‘piccolo epigramma’ di quattro versi” (Brecht 1940, cit. in Didi-Huberman 2009, 31). Brecht è ‘esposto alla guerra’, con tutta la fragilità e i limiti che questa esposizione comporta, ma anche, per converso, con il guadagno dell’accentuazione di facoltà di pensiero diverse da quelle utilizzate in condizioni di normalità; questa ‘esposizione alla guerra’ ha infatti rappresentato per Brecht “un sapere, una presa di posizione e un insieme di scelte estetiche assolutamente determinanti” (Didi-Huberman 2009, 13).
Assieme alla riduzione del testo in frammenti in cui si riflette anche una certa fragilità del logos, della capacità razionale di fare ordine sugli eventi tragici che lo investono, si accompagna dall’altra un ‘acutizzarsi della vista’ che, nel pathos del momento, si esprime nella necessità di parlare per immagini. L’epigramma è la forma poetica che Brecht desume dall’antichità classica per commentare la selezione di immagini apposte nell’Abicì della guerra, e che nell’insieme andranno a formare quello che ha definito un “Fotoepigramm”. Il fatto che storicamente in origine l’epigramma sia un’iscrizione legata per lo più a contesti funebri rende la scelta obbligata ancora più pertinente rispetto alla tragicità degli eventi su cui riflette. Il montaggio è il meccanismo compositivo con cui Brecht tesse le relazioni tra gli elementi, testi e immagini, e si rivela “un metodo di conoscenza e una procedura formale nata dalla guerra, che prende atto del ‘disordine del mondo’” (Didi-Huberman 2009, 86).
Brecht è ‘esposto’ alla guerra così come lo era stato, e con modalità forse ancora più destabilizzanti, Aby Warburg. Sono numerosi i “sismografi sensibilissimi”, per riprendere un’espressione di Warburg (Warburg [1927] 2002), che direttamente o indirettamente hanno sofferto sulla loro pelle la tragedia dei due conflitti mondiali e hanno restituito tale sofferenza al mondo in forma di creazioni artistiche o intellettuali in cui l’immagine ha un valore gnoseologico profondo. Volendo rimanere nella metafora del ‘sismografo sensibilissimo’ che accomuna per affinità elettive Warburg, Jacob Burckhardt e Friedrich Nietzsche si potrebbe aggiungere ai tre anche Carl Gustav Jung – virtuosamente legato sia al pensiero dello storico dell’arte che del filosofo – per cui la composizione di Das rote Buch, Il libro rosso, un libro in forma di scrittura drammatizzata e immagini di creazione dello stesso autore, è profondamente segnata dallo scoppio della Prima guerra mondiale (Sacco 2011, in “La Rivista di Engramma” 89, aprile 2011). Ma si potrebbe aggiungere anche Ernst Jünger, autore di un ‘sillabario per immagini’, composto da foto relative alla Prima guerra mondiale, che significativamente titola Il mondo mutato. Sillabario per immagini del nostro tempo: Die Veränderte Welt: eine Bilderfibel Unserer Zeit (Schultz-Jünger 1933). Anche in questo caso la scelta della parola sillabario o abbecedario, associata all’evento della guerra, risulta essere rivelatrice di un azzeramento della sintassi, quindi del raggiungimento di un punto zero della significazione del mondo a cui segue una rinominazione elementare.
Il disordine del mondo come effetto della conflagrazione della guerra è colto nel segno dall’immagine della ‘guerra cubista’ tratteggiata da Gertrude Stein in Picasso. La riflessione sul cubismo condotta dalla scrittrice è l’occasione per distinguere la cultura ottocentesca da quella novecentesca: la differenza essenziale tra i due mondi è compresa nel fatto che se i pittori dell’Ottocento avevano bisogno di un modello da guardare, quelli del Novecento si sbarazzano del modello, perché “l’assioma secondo cui le cose vedute con gli occhi sono le sole cose reali aveva perso ogni significato” (Stein [1938] 1959, 19). Ciò che cambia nelle generazioni, osserva Stein, è “il modo di vedere ed essere veduti”, la gente rimane la stessa ma a cambiare è la “composizione della generazione”; ossia il cambiamento, leggibile nel mondo, ad esempio delle strade, del modo di essere trasportati nelle strade, del modo in cui le strade sono frequentate, è questo che determina la ‘composizione’.
Allora, riflettendo sulla Prima guerra mondiale, Stein osserva come: “la composizione della guerra 1914-1918 non era la composizione delle guerre precedenti. Questa composizione non era una composizione in cui c’era un uomo al centro, circondato da una massa di altri uomini; era una composizione senza né capo né coda, una composizione in cui un angolo contava quanto un altro angolo: la composizione del cubismo, insomma” (Stein [1938] 1959, 21). Il cubismo è la forma artistica capace di riflettere il fenomeno di distruzione proprio dell’evento guerra, così come alla fine degli anni ’10 il dadaismo berlinese usava i fotomontaggi per mettere in scena “il disordine di una cultura ridotta in frantumi dalla catastrofe della Prima guerra mondiale” (Somaini 2011, XIII). La frantumazione corrisponde al decoupage che è sempre sotteso al montage: il meccanismo del montaggio utilizzato nella creazione pittorica dei cubisti come in quella fotografica dei dadaisti implica intrinsecamente la sua operazione inversa, ossia lo smontaggio, la scomposizione in parti, in frammenti che vengono successivamente ricomposti, montati appunto.
L’immagine della “guerra cubista” di Stein è raccolta da Stephen Kern per leggere nella Prima guerra mondiale un sintomo dei radicali cambiamenti che, complici le nuove tecnologie, hanno investito i modi di pensare e di esperire lo spazio e il tempo tra Ottocento e Novecento (Kern [1983] 1988). Nell’impossibilità di individuare una tesi unica che racchiuda tutti questi cambiamenti, Kern riconosce tra le nuove idee emergenti: “l’idea della simultaneità”, “l’affermazione di una pluralità di tempi e spazi”, e in particolare “l’affermazione della realtà del tempo privato” e “il livellamento di gerarchie spaziali tradizionali”, a cui segue una rivalutazione fondamentale dello spazio non più inteso come semplice contenitore ma significante in ogni sua parte. La filosofia di Bergson (la durata – durée – che implica un rapporto continuo tra passato e presente e dischiude al tempo personale) e il cubismo (la non gerarchia tra i piani rappresentati) sono soltanto due tra i molti esempi che esprimono queste novità. Kern pone questo livellamento delle gerarchie tradizionali in parallelo con il progressivo sgretolamento della società aristocratica, l’ascesa della democrazia e la dissoluzione della distinzione tra lo spazio sacro e lo spazio profano della religione. Con il livellamento delle gerarchie tradizionali è messo in discussione il fondamento metafisico implicito che le sosteneva, e le istituzioni sociali, politiche e religiose fondate su di esso. Di riflesso, le immagini della frontiera, della trincea e della ‘terra di nessuno’, proprie del vissuto della guerra mondiale, restituiscono la frammentazione e la distruzione dell’idea di unità e identità che l’evento tragico rende tangibile: “La frammentazione psicologica sperimentata nella terra di nessuno durante la guerra non era altro che una serie di forme ridotte a pezzi – confini nazionali, sistemi politici, classi sociali, vita familiare, relazioni sessuali, sensibilità umane” (Kern [1983] 1988, 383). Sono immagini della frammentazione del vecchio mondo, immagini che registrano la frantumazione della sintassi tradizionale e aprono alla nuova sintassi che trova il suo meccanismo compositivo nel montaggio, nella costruzione a partire da frammenti. Kern osserva ad esempio l’impressionante analogia tra un cambiamento strutturale della strategia delle battaglie, ossia ‘la difesa in profondità’ anziché il mantenimento della ‘linea del fronte’ (dove “l’intero esercito incalzava in unità ammassate sotto un unico comando”) e lo spostamento in pittura dal singolo punto di fuga prospettica alle prospettive molteplici del cubismo: “In guerra e in pittura l’idea della linea perse la sua inviolabilità come una frontiera che separa due regni distinti. Le due arti assunsero una composizione nuova che incorporava le ambiguità e i contorni irregolari della realtà. I cubisti avevano cercato una nuova unificazione del valore estetico dell’intera superficie pittorica; la guerra riunì elementi disparati di classe, rango, professione e nazione livellando le distinzioni gerarchiche tradizionali” (Kern [1983] 1988, 388). Osservazione che potrebbe stimolare una riflessione sul montaggio come ‘forma simbolica’ del pensiero della ‘postmodernità’, così come lo è stata, nella definizione che ne ha dato Panofsky (Panofsky [1924/1932] 1999), la prospettiva nel Rinascimento per la modernità (Splinder 1978, 197-198).
Ma sono molti gli autori che, alla pari di Kern, hanno prediletto una lettura della guerra come fenomeno da osservare dal punto di vista degli effetti mentali: assieme a Hereward Carrington (1918), Charles Carrington (1929), Eric J. Leed (1979), per fare qualche esempio, più di recente Antonio Gibelli (Gibelli [1991] 1998) che, in un contesto storicistico, a partire dalle testimonianze di medici, psichiatri e psicologi, ha studiato la trasformazione delle strutture mentali come conseguenze degli effetti traumatici provocati dalla guerra. Il vissuto della guerra suscita, attraverso l’esperienza percettiva disgregata e scomposta, la moltiplicazione e la frammentazione delle immagini visive e sonore del mondo. E ciò avviene con il concorso delle tecnologie e di nuove forme di comunicazione, di rappresentazione, nuove forme di riproduzione e manipolazione delle immagini, assunte anche dalle correnti artistiche dell’avanguardia, dalla pubblicità e in generale nella comunicazione sociale. In quest’ottica discontinuità e dissociazione sono associate all’esperienza della guerra sia come effetto che come sintomo di un diverso rapportarsi dell’uomo alla realtà.
Quindi, come anche l’Abicì della guerra di Brecht mostra, la risposta formale al conflitto della guerra è il montaggio, ossia un dispositivo creativo che implica in sé il principio del conflitto, della discordia, della disgregazione e della composizione per frammenti.
Dal punto di vista formale a strutturale le pagine dell’Abicì della guerra sono nel complesso un montaggio di frammenti poetici, immagini tratte dalla stampa e didascalie, di modo che ciascun ‘quadro’ è composto da una foto che può avere o meno la relativa didascalia, e da un epigramma posto a commento. Come ha osservato Didi-Huberman, il meccanismo compositivo è regolato da rapporti dialettici tra le componenti in gioco, così come, pur nella diversa articolazione compositiva, accade nelle tavole warburghiane. Perciò nel testo si condensano e interagiscono dialetticamente piani differenti: l’evento storico che il drammaturgo intende riportare, l’immagine fotografica del giornale che lo immortala, assieme alla didascalia esplicativa, che di per sé rappresenta già una interpretazione, e il suo commento poetico. L’effetto che ne consegue è una visione assolutamente inedita degli accadimenti in corso durante la guerra. Accade quindi che il montaggio, strumentale alla composizione di tutti questi elementi, disarticola la percezione abituale dell’evento, o la percezione che passa la cronaca o il dettato storico e costruisce un nuovo ordine di senso. Interviene cioè una comprensione nuova che attraverso il montaggio smonta l’ordine spaziale e temporale delle cose che vengono così sottratte alla loro ‘origine’, al loro primo contesto di appartenenza, poste in una nuova collocazione, rispetto a un nuovo contesto e così inserite in un “reticolo di relazioni”, come lo ha definito Didi-Huberman, con gli altri elementi in cui si intrecciano dialetticamente.
Brecht legge la polarità spesso già espressa intrinsecamente nell’immagine e la rende esplicita o amplifica nel testo di commento giustapposto alla didascalia. Si potrebbero fare molti esempi: tra le immagini più cariche di ambiguità tra quelle scelte da Brecht certamente è da considerare quella che compare nel quadro n. 52.
Si tratta di una foto apparsa su “Life” che ritrae soldati dormienti all’interno in buche scavate nella terra. La didascalia del giornale descrive “soldati esausti” (“Erschöpfte Soldaten”) che “colgono l’occasione di farsi un sonnellino al sole” (“ein kurzes Schläfchen in der Sonne zu machen”) all’interno di tane scavate con le loro stesse mani e, noncuranti del fuoco tedesco, dormono a terra “senza nessun riparo” (“schlafen ungeschützt auf dem Erdboden”). Brecht coglie l’evidente risvolto macabro dell’immagine, un aspetto che appare totalmente ignorato dalla didascalia: le pose più o meno naturali dei soldati, infatti, pur appartenendo a delle persone dormienti, stimolano immediatamente l’idea della morte. Le tane scavate somigliano piuttosto a delle fosse e i corpi stesi a terra sembrano dormire un sonno di morte. L’epigramma infatti parla di tombe, e l’ultimo verso condensa in una frase il destino di morte dei soldati in guerra: “Ma se non dormissero, non sarebbero svegli lo stesso” (“Doch wären sie, nicht schlafend, auch nicht wach”).
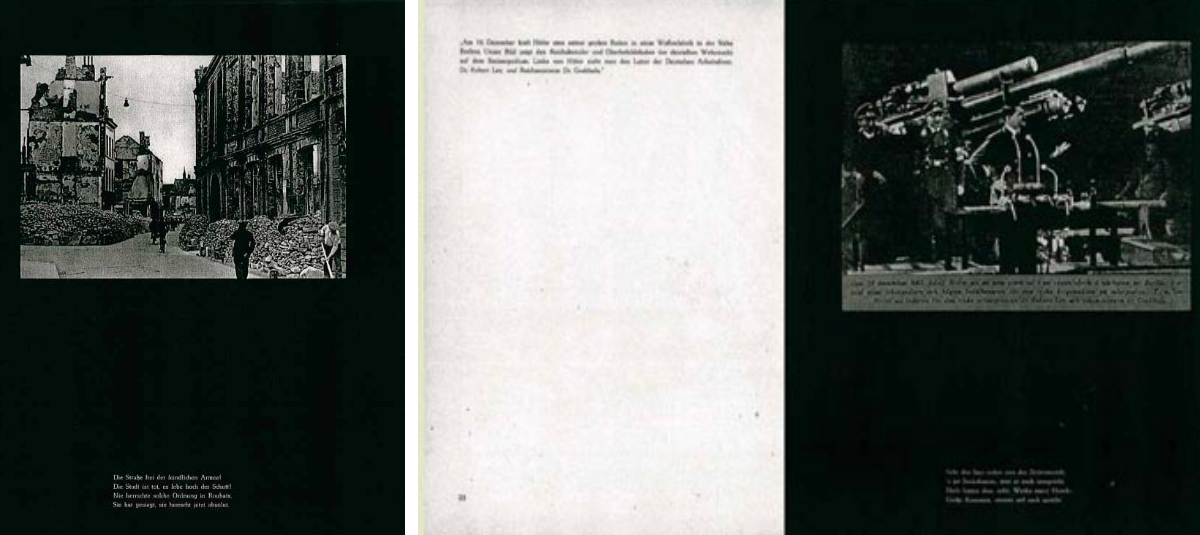
a sinistra: Bertolt Brecht: Kriegsfibel, quadro n. 9; a destra: Bertolt Brecht: Kriegsfibel, quadro n. 23.
Il quadro n. 9 è composto con un’immagine senza didascalia e come si legge dall’epigramma si tratta di una foto della città di Roubaix scattata dopo un bombardamento. La ragione della scelta appare evidente nel profondo contrasto che trasmette l’immagine e nel commento che lo esplicita: si tratta di una città devastata dal bombardamento ma le rovine, i frammenti sono composti nel massimo ordine; l’immagine della deflagrazione e della ricomposizione sono sovrapposte polarmente. Per questo l’epigramma recita: “Non ci fu mai tanto ordine a Roubaix. Ha trionfato, assoluto è il suo potere” (“Nie herrschte solche Ordnung in Roubaix. Sie hat gesiegt, sie herrscht jetzt absolut”).
Il quadro n. 23 si compone di una foto che ritrae Hitler durante un discorso tenuto “in una fabbrica di armi vicino a Berlino”, così infatti è indicato il luogo nella didascalia in cui sono citati anche i personaggi che compaiono al suo fianco. Il riferimento alla fabbrica di armi è giustificato dalla presenza di enormi cannoni alle spalle del dittatore ed è da questo dettaglio – innocuo nella didascalia – che scaturisce l’epigramma di commento. Qui rispetto al parlare del Führer, “uno dei suoi grandi discorsi” (“eine seiner großen Reden”) – come è scritto nella didascalia della foto – e al “parlare di tempi nuovi” (“reden von der Zeitenwende”), come scrive Brecht nel primo verso, fa da contrappunto la minaccia muta dei cannoni dietro di lui; i cannoni muti, come si legge nella composizione, sono idealmente puntati su chi guarda: “puntati su di voi: sono le opere delle vostre mani che vedete” (“Doch hinter ihm, seht, Werke eurer Hände: Große Kanonen, stumm auf euch gericht”). Assieme alla minaccia per quello che verrà è comunicato anche il senso di responsabilità per chi condivide il destino di guerra: le armi sono il frutto del lavoro del popolo.
La composizione dell’Abicì della guerra rivela come per Brecht la Polarität è un elemento fondamentale (Didi-Huberman 2009, 51-59) così come per Warburg la polarità e la polarizzazione sono il fulcro del suo approccio morfologico all’immagine (Pinotti 2001, 177). Nella dialettica tra testo e immagine è quest’ultima a catturare per prima lo sguardo e a direzionare la vista stimolando l’attenzione tanto per il dettaglio quanto per la visione d’insieme. È proprio la peculiarità del darsi visivo dell’immagine a imporre la necessità di considerarla mai irrelata ma continuamente connessa al contesto: l’immagine apre alla relazione, e alla multidirezionalità della prospettiva. A direzionare il movimento di lettura del quadro è la polarità semantica provocata dalla giustapposizione degli elementi in gioco, riconoscibile proprio dallo sguardo d’insieme capace di cogliere visivamente immagine e testo in modo sinottico.
Didi-Huberman, in riferimento al Bilderatlas Mnemosyne, riprendendo una affermazione di Saxl secondo cui nell’Atlante si avrebbe una “dimostrazione ad oculos”, osserva come questa dimostrazione non ha “la forma di un sillogismo classico: non riduce il diverso all’unità di una funzione logica” (Didi-Huberman [2002] 2006, 424). Quindi è il primato della vista, non dell’argomentazione logico discorsiva, che guida il senso e il significato della disposizione e della lettura di tale disposizione. E attraverso la vista si configura propriamente la forma di conoscenza mediata dal montaggio: in esso si dispiega la complessità, la molteplicità non riconducibile a univocità che la tensione polare continuamente rifrange.
Ponendo una proporzione esplicativa si potrebbe affermare che il montaggio sta al pensiero fantastico/immaginale come la logica sta al pensiero razionale. Nel primo caso le particelle elementari che vengono composte dal montaggio sono immagini che, intese come frammenti, rinviano sempre ad altro, accostate tra di loro per giustapposizione, secondo legami associativi guidati da un principio di polarità semantica di modo da creare una rete di rapporti non univoci. Nel secondo caso le particelle elementari sono concetti, quindi astrazioni che sussumono una molteplicità sensibile in una unità di segno, legati tra loro secondo rapporti univoci di consequenzialità logica, tali da garantire la non equivocità del senso.
L’associazione tra immagini e testi avviene quindi in virtù di un rapporto di giustapposizione permesso da una dimensione e collocazione spaziale. Significativamente Jean Luc Nancy, introducendo il concetto di ‘spaziatura’ (Nancy [1996] 2001), usa la giustapposizione di parole per indicare il rapporto tra “essere singolare e plurale” che si può pensare solo dopo la fine di ogni ontologia metafisica, svelando però in questo modo quale sia il limite della significazione discorsiva rispetto alla potenza della collocazione spaziale, visiva. La giustapposizione di parole riproduce il meccanismo di segmentazione dell’immagine in inquadrature semplicemente poste l’una accanto all’altra – senza che vi siano quindi segni interpuntivi o congiunzioni – come è proprio del linguaggio cinematografico. “Essere singolare plurale” è a tutti gli effetti un montaggio di parole accostate, dove l’intervallo, lo spazio tra le parole è fondante, perché l’assenza di determinazione sintattica garantisce il significato che il filosofo francese intende comunicare: “‘essere’ può essere verbo e sostantivo, ‘singolare’ e ‘plurale’ possono essere aggettivi o sostantivi, si può scegliere la combinazione che si vuole – marcano al tempo stesso un’equivalenza assoluta e la sua articolazione aperta, impossibile da racchiudere in un’identità”. Qui in discussione è l’essere che agli albori della filosofia ha fondato il principio di identità e non contraddizione, e che è stato posto come sostanza preesistente all’esistenza; l’essere che intende svelare Nancy è “singolarmente plurale e pluralmente singolare” e “non preesiste al suo singolare plurale”. Nella spaziatura c’è allora la co-essenzialità dell’essere, quella “spartizione in guisa di assemblaggio”, dove la relazione è fondante, il ‘con’ fa essere, non è semplicemente aggiunto all’essere.
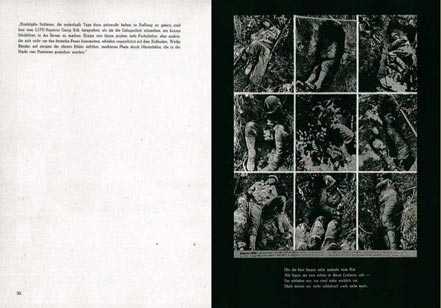
Bertolt Brecht, Kriegsfibel, quadro n. 52.
Significativamente è in riferimento a Brecht che è stato introdotto per la prima volta da Roger Planchon nel contesto teatrale il concetto di ‘scrittura scenica’, indice del mutato rapporto con lo spazio proprio del teatro novecentesco. Ossia lo spazio inteso non come semplice contenitore ma come campo di segni; secondo Planchon per Brecht “la rappresentazione forma al contempo una scrittura drammatica e una scrittura scenica; ma questa scrittura scenica – ed è stato il primo a dirlo […] – ha una responsabilità uguale alla scrittura drammatica e, in definitiva, un movimento sulla scena, la scelta di un colore, di una decorazione, d’un costume, etc., impegna una responsabilità totale” (Planchon [1961] 2003). E la nuova spazialità auspicata in realtà già dalle Avanguardie Storiche – per non parlare di Artaud – è riflesso di una trasformazione della visione del mondo che coinvolge tutti gli ambiti disciplinari. Come ha osservato Michel Foucault – tra i primi a mettere l’accento sulla questione negli anni ’60 – se “la grande ossessione che ha assillato il XIX secolo è stata la storia […] forse quella attuale potrebbe essere considerata l’epoca dello spazio” (Foucault [1967/1984] 2001, 19).
Nel metodo di composizione per montaggio che dà forma all’Abicì della guerra si può leggere il portato sovversivo del teatro che Brecht, fondando, ha definito ‘epico’. Collocandosi a metà strada tra la prima e la seconda riforma del teatro novecentesco, il regista e drammaturgo riforma il teatro a partire dalle stesse premesse poste dall’Avanguardia Storica.
A essere messo in discussione è, come per Artaud, la distanza accumulata dal teatro rispetto alla vita, l’incapacità di parlare del e al tempo presente, e quindi l’attaccamento a stilemi obsoleti per quanto alla moda. Sotto accusa è l’estetizzazione del teatro, il suo vuoto formalismo, e l’obiettivo è resuscitarne la forza politica, la capacità di impatto sulla società appiattita a una fruizione neutralmente disinteressata e finalizzata semplicemente allo svago e al divertimento. Di qui, in nome di un realismo socialista, le accuse di Brecht al teatro decaduto – di cui fanno parte anche le messe in scena dei classici – che nella bellezza formale della facciata nasconde un contenuto stantio e riflette delle immagini falsate della vera realtà. Il teatro per il regista e drammaturgo tedesco ha il potere e il dovere di trasformare il pubblico e con il pubblico il mondo. Brecht però, a differenza di Artaud che parte dalle stesse premesse critiche per rovesciare il sistema che vuole combattere, fa i conti con il sistema che cerca di trasformare convivendoci, standoci dentro e operando in esso. Quindi non intende negare la ‘rappresentazione’ – quella estrinsecazione della violenza del pensiero metafisico occidentale che Derrida ha letto nel tentativo della sua destituzione fatto da Artaud (Derrida [1966] 2002, 301) – ma la mette in scena e così la svela, la smaschera attraverso il meccanismo di straniamento proprio del teatro epico.
Brecht, alla drammaturgia che provoca l’immedesimazione dello spettatore nei personaggi imitati dagli attori, oppone una drammaturgia in cui il meccanismo dell’immedesimazione viene annullato nell’effetto di ‘straniamento’: il ‘Verfremdungseffekt’ teorizzato negli scritti sul teatro ed elemento fondante del teatro epico. La finzione nel teatro secondo Brecht deve essere dichiarata ed esplicitata per stimolare la distanza critica dello spettatore. Quindi, differentemente da Artaud la rappresentazione non è negata con l’intenzione di recuperare uno stato che la precede – quella “Parola prima delle parole” che è poi la voce del mito e della tragedia – ma è esibita, messa in scena, esplicitata, dimostrata e messa in crisi attraverso l’effetto dello straniamento. Brecht attua proprio quello “spezzare il linguaggio” che si era proposto Artaud (Artaud [1935] 1997, 132) per riformare la cultura occidentale attraverso il teatro e lo fa scegliendo i drammi storici come trame privilegiate delle sue messe in scena. Artaud e Brecht, come eredi delle Avanguardie Storiche, sembrano spartirsi i domini rispettivamente del mito e della storia, come orizzonti di senso del teatro che intendono riformare, sostenendo il primo l’ipotesi tragica e il secondo l’ipotesi epica (Longhi 1999, 2001).
Così facendo, Brecht, con la consapevolezza di non poter parlare alla sua epoca prescindendo da essa, rivoluziona il teatro a partire dal sistema, lo mette in scena e lo spezza al suo interno. L’esito ultimo di questa operazione sarà scoprire la natura eminentemente dialettica del teatro, e della vita che nel teatro trova espressione. Allora la Storia, come una delle principali forme di rappresentazione, come narrazione che nel sistema occidentale più di altre ha preso il posto della narrazione del mito e che ha il suo momento culminante nello storicismo ottocentesco, è condotta da Brecht sulla scena nella forma epica, ed è spezzata per essere ricondotta al presente del dramma. A permettere questo spezzettamento, la frantumazione della narrazione storica nella forma dello straniamento è il meccanismo del montaggio.
L’operazione epica del teatro di Brecht consiste da un lato nello spezzare lo svolgimento cronologico dei fatti, quindi nel creare delle interruzioni nello svolgimento storico, e dall’altro nel mettere in crisi l’effetto illusionistico della finzione rappresentativa. Rispetto a queste due operazioni, il montaggio ricolloca gli eventi tra loro secondo un ‘reticolo di relazioni’ che ne stravolge totalmente la connotazione. La trama portata sulla scena, come vede bene Benjamin nello scritto sul teatro epico, è sottoposta all’atto dello “snodare le articolazioni fino al limite estremo” (Benjamin [1939] 1966, 128). La sua interruzione crea discontinuità e anacronismi funzionali a una visione differente, nuova e inusuale, delle vicende che devono provocare stupore, non immedesimazione. Attraverso questa percezione straniata dell’evento si afferma il paradigma eminentemente politico del montaggio che mette in crisi la visione abituale del dato di fatto per stimolare non tanto una identificazione dello spettatore ma una “presa di posizione” (Brecht [1931] 1975). Allo stesso modo Benjamin intende “adottare nella storia” (Benjamin [1927-1940] 1986, 515) il montaggio per spezzarla, per interromperne la cronologia, per operare una rottura rispetto all’ordine temporale dello storicismo.
Rispetto ai primi scritti sul teatro epico, permeati di pensiero storicistico, andrebbe in verità osservato il risvolto dialettico e tragico di cui si colora la teoria di Brecht di ritorno dalla guerra, aprendosi a uno sfondo più tragico e mitico che epico e storicistico. Il valore dialettico dell’operazione di straniamento è infatti un’acquisizione più matura nella teoria di Brecht e risulta così fortemente improntata all’esperienza dell’esilio e della guerra. A seguito di questa acquisizione il montaggio allora, anche rispetto all’uso che Brecht ne fa nell’Abicì della guerra così come nel Diario di lavoro, appare in tutto il suo portato di “gesto drammaturgico fondamentale”, come lo ha definito Didi-Huberman (Didi-Huberman 2009, 79). È il riconoscimento dell’elemento dialettico, che Brecht matura significativamente solo dopo l’esperienza della guerra, a rendere pienamente il senso della drammaturgia brechtiana, e a caricare di un ulteriore senso il teatro definito epico che è eminentemente dialettico nella misura in cui il suo processo compositivo avviene attraverso il montaggio.
Il teatro dialettico intende mostrare quindi i conflitti e le contraddizioni, e la tecnica utilizzata per la scena sarà tutta finalizzata alla loro resa. Ad esempio Brecht osserva come nel lavoro dell’attore devono comporsi procedimenti contrari: “L’attore ottiene i propri effetti ricavandoli dalla tensione, come pure dalla profondità, dei due elementi in contrasto” (Brecht [1948] 1975a, 120), elementi che quindi non devono sintetizzarsi o annullarsi tra di loro, ma mostrare il loro intersecarsi. Secondo questo principio ad esempio un ruolo femminile sarà reso meglio da un attore uomo, come il ruolo di un vecchio sarà reso meglio da un attore giovane o il ruolo di un borghese da un attore abituato a recitare il ruolo del proletario. La tensione polare tra gli elementi contrastanti che rende l’effetto dello straniamento emerge dal conflitto degli stessi elementi che è mantenuto in scena. La contraddizione, l’ambiguità, la tensione polare, la complexio oppositorum definiscono la dialettica del montaggio con cui vengono composti gli elementi in scena, e però colorano di senso tragico e mitico il teatro epico che, rispetto a questi elementi, può essere compreso pienamente nella sua accezione propriamente drammatica.
La definizione di montaggio che troviamo in uno scritto di Ejzenštejn del ’29 (Ejzenstejn [1929] 1992), per prendere le distanze da quella dei suoi predecessori, rende il senso dello scarto tra epico e drammatico e permette di riconsiderare il valore ‘epico’ del teatro che Brecht rivendica rispetto al teatro drammatico. Secondo Ejzenštejn infatti il montaggio non implica “un pensiero composto da pezzi che si succedono bensì un pensiero che trae origine dallo scontro di due pezzi indipendenti l’uno dall’altro (principio drammatico)”. Il principio epico implica quindi il rapporto di ‘successione’, e rende il montaggio ‘descrittivo’, il principio drammatico invece implica il rapporto conflittuale, lo scontro tra le parti e la loro ‘sovrapposizione’ che genera lo scontro.
Nello scarto tra successione e giustapposizione si condensa quindi lo scarto tra epico e drammatico e, si può evincere, di riflesso tra storico e mitico; e quindi tra un tempo lineare che implica la successione cronologica di un prima rispetto a un poi e un tempo in cui si ha la giustapposizione di due tempi diversi: in cui presente e passato sono considerati contemporaneamente. Nello stesso scritto inoltre l’arte intesa nel complesso, coerentemente a una visione filosofica dialettica che si riconduce esplicitamente al pensiero di Marx ed Engels, è intesa da Ejzenštejn come frutto di un conflitto: “l’arte è sempre conflitto, per la sua missione sociale, per la sua natura essenziale, per la sua metodologia”. E, qualche pagina dopo, il montaggio è considerato proprio come il meccanismo che quella metodologia è chiamato a regolare.
Se accettando la definizione di Ejzenštejn si considera la dialettica, il conflitto, come la cifra del drammatico e non dell’epico, allora, nella misura in cui la dialettica è strumento del teatro epico, questo teatro è nel fondo drammatico. Di fatto “la forma drammatica del teatro” rispetto alla quale Brecht, in uno schema stilato in un saggio del 1931 (Brecht [1931] 1975), contrappone “la forma epica del teatro”, è da riferirsi al dramma che ha dominato fino alla modernità come forma decaduta di tragedia e contro cui si impone la rivoluzione del teatro novecentesco dalle Avanguardie Storiche in poi. In altre parole si comprende come il teatro epico di Brecht sia profondamente drammatico nella misura in cui è tragico e dialettico. Se di ritorno dall’esilio Brecht utilizza l’accezione di dialettico per qualificare ulteriormente il teatro epico, allo stesso tempo cambia anche l’atteggiamento nei confronti dei classici e, rispetto all’adesione al realismo socialista, muta in favore di un recupero della funzione artistica del godimento estetico, che non è più vista in contrasto con la funzione eminentemente politica del teatro, ma si presenta come un suo importante complemento.
In uno scritto del 1928 in cui, in forma dialogata riporta una discussione radiofonica con il critico e amico Herbert Jhering a proposito del contributo di quest’ultimo sui classici, Brecht si domanda: “Se sono [i classici] morti, quando sono morti? La verità è questa: sono morti in guerra – sono anch’essi vittime della guerra” (Brecht [1929] 1975, 85). I classici sono tacciati di essere inattuali, e, evidentemente, nella sua prospettiva, la guerra ha cambiato il mondo, e il teatro che ripropone i classici alla maniera classica, secondo i dettami e l’ideale che ha predominato fino all’Ottocento con la ragione illuminata, sembra essere ignaro di questo cambiamento. I classici non sono più efficaci e la critica a essi è perfettamente in linea con la critica al naturalismo, al finto illusionismo, all’estetismo, al teatro di cui si può fare solo un “uso culinario”. Il mutato atteggiamento nei confronti dei classici e delle loro messe in scena è leggibile nella scelta artistica fatta da Brecht nel 1948, di ritorno dall’esilio americano, di cimentarsi subito con un classico, e in particolare una tragedia greca: l’Antigone di Sofocle con traduzione di Hölderlin, andata in scena il 15 febbraio del 1948 in Svizzera presso lo Staddtheater di Coira con il titolo Antigone des Sophokles.
Senza entrare nello specifico dell’opera, interessa qui parlarne come segno del mutato approccio di Brecht dipendente dal vissuto di guerra, e come esperienza fondante anche per la più matura teorizzazione del teatro epico come teatro dialettico. Come ha osservato Olga Taxidou, è il concetto di frammento, di rovina che connota la nuova attitudine di Brecht nei confronti dei classici (Taxidou 2007, 171). Nella Prefazione all’Antigone-Modell-Buch (Brecht [1948] 1975b), il ‘libro-modello’ relativo alla messa in scena di Antigone, costruito con bozzetti e foto delle prove secondo la modalità di montaggio di testi e immagini propria sia dell’Abicì della guerra che del Diario di lavoro, la rovina è pensata come quel che rimane del vecchio con il pericolo sempre in agguato della sua restaurazione, ma è anche il principio della possibilità della ricostruzione, ne catalizza la sfida, oltre che rappresentarne la memoria storica. E significativamente, a simbolizzare questo valore della rovina come frammento, sullo sfondo della scena dello spettacolo, Brecht fa apporre “una grande fotografia di città ridotta in macerie”.
L’idea del frammento è intrinsecamente legata a quella di montaggio. Ne è parte costitutiva, la particella elementare, e però allo stesso tempo rimanda alla composizione. La frantumazione è tutto quello che rimane del mondo precedente distrutto, e i frammenti tratti dalle macerie possono trovare nella ricomposizione una nuova combinazione, la promessa della possibile ricostruzione di un nuovo mondo. Il teatro che è sopravvissuto alla guerra deve secondo Brecht rispondere a quella ‘sete di novità’ che “il completo sfacelo materiale e spirituale ha indubbiamente prodotto nel nostro paese sventurato e provocatore di sventura” (Brecht [1948] 1975b, 237). Ed è, però, una sete di novità che deve fare i conti con il passato: “Il guaio delle rovine non è solo che va distrutta la casa, ma anche che il posto non c’è più; e i progetti degli architetti, a quanto sembra, non si cancellano mai del tutto; sicché con la ricostruzione riappaiono le vecchie infiltrazioni e i focolai di malattia. Quella che è vita febbricitante afferma di essere vita sprizzante di energia: nessuno muove passi più decisi del tisico che ha perso ogni sensazione dalla pianta dei piedi. […] Può darsi perciò che, proprio in tempo di ricostruzione, fare dell’arte progressiva sia tutt’altro che facile. Ma questa dovrebbe essere la sfida” (Brecht [1948] 1975b, 238, traduzione modificata).
Quindi l’Antigone che Brecht mette in scena di ritorno dall’esilio, a guerra conclusa, sembra avere la funzione e il valore di un phármakon come ha osservato Taxidou leggendo un’affinità con l’idea di teatro veleno/rimedio di Artaud. La scelta di questa tragedia greca in particolare è dettata dalla convinzione che Antigone incarni “la funzione della violenza al momento del crollo dell’autorità statale” (Brecht [1948] 1975b, 238), quindi l’argomento che solleva è percepito come attuale. E però non c’è alcun intento filologico e alcuna intenzione di “evocare lo spirito degli antichi” ma lo scopo è “di far fare ad essa [l’opera] qualcosa per noi” (Brecht [1948] 1975b, 238-239). Lo studio e la preparazione dell’Antigone è significativamente contemporaneo alla scrittura del Breviario di estetica teatrale (Brecht [1948] 1975°), il primo testo teorico in cui sia espressa in modo maturo una accezione dialettica di teatro, e dove si coglie la peculiarità del metodo capace di rendere la contraddittorietà dei processi sociali e umani in continua trasformazione. Le idee di contraddizione, polarità, di dialettica tra passato e presente sono ricorrenti in tutto lo scritto. Allo stesso modo, nell’Antigone Brecht non intende mettere in scena l’affermarsi di un potere su di un altro, o di una violenza su di un’altra, ma la compresenza dialettica, irrisolta di due sistemi differenti che sussistono contemporaneamente in uno stato di guerra (Taxidou 2007, 174).
Anche rispetto alla contraddizione tra imparare, quindi mantenere la distanza dallo spettacolo, e divertirsi, ossia lasciarsi immedesimare nella scena, Brecht ha in questi anni mutato atteggiamento, la definisce infatti una contraddizione “da conservare come un elemento importante” (Brecht [1948] 1975a,186). Quindi, anche questa mutata posizione è indice di una ricollocazione del significato epico del teatro in una accezione propriamente drammatica, perché ciò che fa dramma nel teatro epico di Brecht è il meccanismo dialettico reso possibile con il metodo del montaggio.
Assieme alla comprensione della natura intimamente dialettica del teatro, nell’Antigone-Modell-Buch, Brecht chiarifica anche il senso di intendere il rapporto con il modello, e quindi di conseguenza anche il rapporto da intrattenere con i classici, intesi nella nuova accezione. Modello è quanto c’è di “imitabile e inimitabile” al tempo stesso, quindi quanto viene proposto per essere violato; il suo tradimento instaura il rapporto dialettico con esso che è auspicabile di contro a un’epoca “che sa applaudire solo l’‘originale’, l’‘incomparabile’ il ‘mai visto’: che non ammette altro che l’‘unico’”. E aggiunge inoltre che “perché qualcosa possa essere utilmente imitato, bisogna che si faccia vedere ‘come si fa’”: quindi è il meccanismo creativo, il metodo, a dover essere imitato, non la creazione, il prodotto. I classici, rispetto alla precedente presa di posizione, non sono negati ma accolti diversamente.
Rispetto alle riflessioni sulla natura dialettica del teatro e alla scelta di mettere in scena l’Antigone – una tragedia greca, un mito – il teatro epico di Brecht non risulta quindi riconducibile tout court all’orizzonte della narrazione storica, come la denominazione epica intende significare. Il teatro epico del regista e drammaturgo tedesco è quindi tragico nella misura in cui è dialettico e interrompe attraverso il montaggio la narrazione storica. Ed è tragico e quindi mitico, nella misura in cui si smarca dal teatro drammatico inteso come forma decaduta di tragedia. Significativamente, la consapevolezza della natura dialettica, e quindi tragica, del teatro epico avviene come conseguenza della messa in scena di una tragedia greca. La scelta è dettata dall’esperienza della guerra che, come ha riconosciuto James Hillman, è un fatto intellegibile solo con categorie mitiche, con categorie i cui strumenti interpretativi si compongono in immagini e trascendono l’ordine esclusivamente razionale del discorso. La terribilità della sua natura richiede un salto di prospettiva, le categorie della storia non sono sufficienti a renderne conto: allora “l’immaginazione diventa il metodo di elezione” (Hillman [2004] 2005, 19). Anche per questo si spiega il fatto che molti artisti e intellettuali ne abbiano cercato la comprensione o il contenimento con dispositivi composti in immagini. Il montaggio – meccanismo che plasma il metodo artistico di Brecht – può essere riletto quindi alla luce di un pensare per immagini. E si rivela così un meccanismo mitopoietico per eccellenza.
*Il presente articolo è stato pubblicato precedentemente ne “La Rivista di Engramma” 100 (ottobre 2012)
Riferimenti bibliografici
- Artaud [1935] 1997
A. Artaud, Prefazione: Il teatro e la cultura, in Il teatro e il suo doppio, Torino 1997. - Benjamin [1939] 1966
W. Benjamin, Che cos’è il teatro epico?, in Id., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, Torino 1966. - Benjamin [1927-1940] 1986
W. Benjamin, Parigi, capitale del XIX secolo, Torino 1986. - Brecht [1929] 1975
B. Brecht, Conversazione sui classici, in Scritti teatrali, vol. I, Torino 1975. - Brecht [1931] 1975
B. Brecht, Il teatro moderno è il teatro epico. Note all’opera “Ascesa e rovina della città di Mahagonny”, in Scritti teatrali, vol. I, Torino 1975. - Brecht [1948] 1975a
B. Brecht, Breviario di estetica teatrale, in Scritti teatrali, vol. II, Torino 1975. - Brecht [1948] 1975b
B. Brecht, Prefazione al “Modello per l’Antigone 1984”, in Scritti teatrali, vol. III, Torino 1975. - Brecht [1938-42; 1942-55] 1976
B. Brecht, Diario di lavoro, Torino 1975. - Brecht [1955] 1972
B. Brecht, L’Abicì della guerra. Immagini della seconda guerra mondiale, Torino 1972. - Breidbach-Vercellone 2010
O. Breidbach, F. Vercellone, Pensare per immagini. Tra scienza e arte, Milano 2010. - Derrida [1966] 2002
J. Derrida, La scrittura e la differenza, Milano 2002. - Didi-Huberman [2002] 2006
G. Didi-Huberman, L’immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte, Torino 2006. - Didi-Huberman 2009
G. Didi-Huberman, Quand les images prennent position, Paris 2009. - Eizenstein [1929] 1992
S. M. Ejzenštejn, Drammaturgia della forma cinematografica, in Il montaggio, a c. di P. Montani, Venezia 1992. - Foucault [1967/1984] 2001
M. Foucault, Spazi altri, in Spazi altri, a c. di S. Vaccaro, Milano 2001. - Gibelli [1991] 1998
A. Gibelli, L’officina della guerra. La grande guerra e le trasformazioni del mondo mentale, Torino 1998. - Hauser [1955/1956] 1967
A. Hauser, Storia sociale dell’arte, vol. II, Torino 1967. - Hillman [2004] 2005
J. Hillman, Un terribile amore per la guerra, Milano 2005. - Jung [2009] 2010
C.G. Jung, Il libro rosso. Liber Novus, a c. di S. Shamdasani, Torino 2010. - Kern [1983] 1988
S. Kern, Il tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento, Bologna 1988. - Longhi 1999
C. Longhi, La drammaturgia del Novecento tra romanzo e montaggio, Pisa 1999. - Longhi 2001
C. Longhi, Tra moderno e postmoderno, la drammaturgia del Novecento, Pisa 2001. - Mango 2003
L. Mango, La scrittura scenica. Un codice e le sue pratiche nel teatro del Novecento, Roma 2003. - Nancy [1996] 2001
J.-L. Nancy, Essere singolare plurale, Torino 2001. - Panofsky [1924/1932] 1999
E. Panofsky, La prospettiva come ‘forma simbolica’ e altri scritti, Milano 1999. - Pinotti 2001
A. Pinotti, Memorie del neutro, morfologia dell’immagine in Aby Warburg, Milano 2001. - Sacco 2011
D. Sacco, Sulla via di quel che ha da venire. Presentazione di C. G. Jung “Il ibro rosso”, Bollati Boringhieri, Torino 2010, in “La Rivista di Engramma” 89, aprile 2011. - Schultz-Jünger [1933] 2007
E. Schultz, E. Jünger, Il mondo mutato. Un sillabario per immagini del nostro tempo, a c. di M. Guerri, Milano 2007. - Somaini 2011
A. Somaini, Ejzenštejn. Il cinema, le arti, il montaggio, Milano 2011. - Spindler 1978
G. Spindler, a c. di, The Making of Psychological Anthropology, Berkeley 1978. - Stein [1938] 1959
G. Stein, Picasso, Milano 1959. - Taxidou 2007
O. Taxidou, Modernism and performance. Jarry to Brecht, New York 2007. - Warburg [1927] 2002
A. Warburg, Burckhardt e Nietzsche, in Jacob Burckhardt, Friedrich W. Nietzsche, Carteggio, a c. di M. Ghelardi, Torino 2002 [sempre a c. di M. Ghelardi, il testo di Warburg si legge anche in “Aut Aut” 199/200, gennaio-aprile 1984].
This text examines how the aftermath of the two World Wars has led to a profound shift in the way reality is perceived and thought about. It highlights the transition from a reason-based worldview typical of modernity to a more intuitive and visual perspective dominated by images. The twentieth century witnessed a significant transformation in thought and perception, with war accelerating this process and giving rise to new forms of art and understanding. Montage emerges as a key compositional mechanism for representing the complexity and fragmentation of contemporary reality. The text invites readers to consider war not only as a historical event but also as a catalyst for profound cultural and mental transformations. Montage, as a visual language, is essential for comprehending and depicting the intricacies of the modern world. By juxtaposing heterogeneous elements, montage creates new meanings and opens the door to a novel way of thinking and knowing. Brecht’s epic theatre, with its use of montage and the alienation effect, stands as a significant expression of this new artistic sensibility. Ultimately, the text demonstrates how montage serves as a fundamental tool for understanding Brecht's epic theatre. Through the analysis of Kriegsfibel and other works, it illustrates how montage enables the creation of a political and engaged theatre that stimulates critical reflection in the audience and promotes social change.
keywords | Montage, epic theatre, Bertolt Brecht, World Wars, visual culture, artistic transformation, alienation effect, political theatre, social change.
Per citare questo articolo / To cite this article: Daniela Sacco, Pensare per immagini. Il principio drammaturgico del montaggio. A partire dall’Abicì della guerra di Bertolt Brecht, “La Rivista di Engramma”, n. 127, maggio-giugno 2015, pp. 315-336 | PDF