Umanesimo tragico
Presentazione del volumeUmanisti italiani. Pensiero e destino
I Millenni Einaudi, Torino 2016
Massimo Cacciari, Raphael Ebgi
English abstract
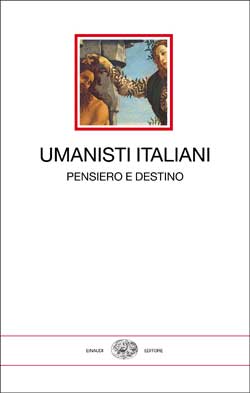
Fresco di stampa per i Millenni Einaudi, esce il volume Umanisti italiani. Pensiero e destino, a cura di Raphael Ebgi con un saggio di Massimo Cacciari. Al ricco contributo introduttivo di Massimo Cacciari, Ripensare l'Umanesimo, seguono otto sezioni con una antologia di scritti di Umanisti del XIV-XVI secolo, fra i quali: Francesco Petrarca, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Lorenzo Valla, Leon Battista Alberti, Giorgio da Trebisonda, Marsilio Ficino, Cristoforo Landino, Pico della Mirandola, Angelo Poliziano, Girolamo Savonarola, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli. Ogni sezione è introdotta da un saggio di contestualizzione storica e di approfondimento teorico, a cura di Raphael Ebgi:
I. Umanesimo tragico
II. Vita activa. Vita contemplativa
III. Filologia e filosofia
IV. Metaphysica
V. Teologia poetica
VI. Hermetica
VII. Cielo e mondo
VIII. Figura futuri
Pubblichiamo qui, per gentile concessione degli autori e dell'editore, un paragrafo del testo introduttivo di Massimo Cacciari Ripensare l'Umanesimo; un paragrafo dell'introduzione Umanesimo tragico di Raphael Ebgi; e, dalla stessa sezione dell'Antologia, l'epistola Ghiribizzi di Niccolò Machiavelli a Pier Soderini del settembre 1506.
Ripensare l'Umanesimo
Massimo Cacciari
«Architecti est scientia pluribus disciplinis et variis eruditionibus ornata», cosí suona solennemente l’inizio del De architectura vitruviano; il Rinascimento vedrà in questo classico, ‘risorto’ nel 1414 a Montecassino, la rivendicazione del valore dell’architettura come autentico sapere, non empirico soltanto, non derivante dalla pratica, e dell’architetto come colui che, accanto e oltre alla sua abilità ed esperienza tecnica, deve essere anche eruditus in geometria e nelle lettere, in matematica e negli studi storici. Una concezione del fare architettonico che nell’Umanesimo si impone già con Brunelleschi e che troverà nell’Alberti la sua piú alta espressione. Se però ci chiedessimo quale disciplina sia la fondamentale per l’architetto umanista, dovremmo indicare proprio la filologia, in quel senso che è emerso dallo studio di Valla. Senza lo studio del testo classico, senza la conoscenza diretta del monumento antico, mai potrà nascere un’architettura cum auctoritate, capace cioè non solo di funzionare e piacere, ma anche di generare nuove forme e dare così vita a una nuova, classica, tradizione. Leon Battista affronta il campo specifico dell’architettura esattamente come Valla quello della filologia. Le opere antiche vanno tutte esaminate con ogni cura; un’ammirazione sentimentale per la loro grandezza non produrrà alcun frutto. Considerarle bisogna, misurarle, comparare le une alle altre così da comprendere quali canoni, quali ‘rime’ le informino. E poi occorre disegnarle, compierne esatti rilievi. Ciò che implica costanza, pazienza, lungo lavoro, avanzare lento pede, esercizio filologico. È lo stesso obstinato rigore con cui l’ars deve procedere, che ritroveremo in Leonardo. E la regola vale universalmente; in ogni campo, nell’arte come per la ‘roba’ della Famiglia o per gli affari dello Stato: il fare senza pazienza, ‘in furia’, è rovinoso; saper indugiare bisogna («indugio quanto posso»), mai cedere alla ‘malattia’ di quel personaggio rappresentato da Machiavelli nel primo capitolo dell’Asino, «ch’in ogni luogo per la via correva | e d’ogni tempo sanza alcun rispetto».
Tale regola sta alla base dei Libri della famiglia come del De re aedificatoria, del grande trattato, cioè, che proprio sul fatto architettonico, sulla complessa realtà del costruire e sul valore essenziale che esso riveste per la civitas hominis, concentra il suo studio. È questa intenzione che obbliga a considerare l’architettura classica. Impossibile pensare la cosa dell’edificare senza fare memoria di Roma. La stessa idea ritornerà ancora in Bramante, di cui Leonardo è «cordial caro ameno socio» con le Antiquarie prospetiche romane [54]. L’architettura di Roma non è un passato da idolatrare, e neppure uno statico modello da imitare o ripetere. Una miniera, piuttosto, di concreti problemi progettuali e compositivi, che trovano varie risposte o soluzioni. Altrettanto armonica, dotata di pari concinnitas, dovrà apparire anche la nostra architettura, e altrettanto capace di varietà, di afferrare la concretezza delle situazioni, di adattarsi ai tempi, di corrispondere al mutare degli usi, ad usum et commoditatem. Alberti tratta l’architettura classica esattamente come Machiavelli gli exempla antichi. La distinzione è sempre salva; la consapevolezza della grande varietà delle cose, anche nel campo delle arti, profonda, acuta, ma non vi è spazio per uno scetticismo di stampo guicciardiniano («è fallacissimo el giudicare per gli essempli, perché se non sono simili in tutto e per tutto, non servono...»), scetticismo che, di continuo, in fondo, anche si contraddice: «chi vuole vedere quali sieno e pensieri de’ tiranni, legga Cornelio Tacito...» (Ricordi, 13, e ancora: «non fate novità in sulla speranza [...] vedete lo essempio di Bruto e Cassio...» (Ricordi, 121)). L’esperienza è maestra (e Guicciardini «è forse il solo storico tra i moderni, che abbia conosciuto molto gli uomini, e filosofato circa gli avvenimenti attendendosi alla cognizione della natura umana», Leopardi, Pensieri, LI), ma esperienza è anche quella che i Romani ci trasmettono. Qui vale essenzialmente ciò che già si è detto: essere all’altezza dei classici, nient’affatto lasciarsi ‘incantare’ da essi, questo è il sollen degli umanisti. E nell’architettura questo ‘dovere’ è sentito con energia forse ancora maggiore che nelle altre discipline. L’abitare, infatti, caratterizza l’uomo quanto il suo linguaggio. Dobbiamo apprendere a bene parlare come a bene abitare.
Scriveva Poliziano a Paolo Cortese: «non exprimis, inquit aliquis, Ciceronem. Quid tum? Non enim sum Cicero; me tamen, ut opinor, exprimo» [55]. E già lo aveva detto Enea Silvio Piccolomini: «fugienda est omnis supervacua imitatio». Non perché ami Cicerone io lo voglio imitare, aveva insegnato a tutti Petrarca. Guardare a Roma è essenziale per imparare a esprimersi in questo tempo, perché le sue lettere e le sue architetture sappiano rappresentarne e aiutare a risolverne i problemi. Proprio l’architettura dell’Alberti è animata, io credo, da questa intenzione con la piú grande intensità. Ed è ‘logico’ che così sia: il massimo architetto, il massimo ‘filologo’ dell’architettura per eccellenza, quella romana, non può essere che colui che piú profondamente conosce la drammatica serietà dell’edificare, quanto improbus labor quest’arte comporti, come estrema sia la difficoltà di far abitare e imparare ad abitare (sta qui il rapporto tra il De re aedificatoria e le opere politico-civili dell’Alberti), di dare casa e città a quel ‘miracolo’ grande e tremendo che è l’uomo. Il metodo della filologia si trova qui alla prova piú ardua, di fronte al dover comprendere con la stessa cura con cui ascolta l’autentica voce dei classici quel testo che è l’esserci umano nel suo esprimersi, nei suoi ‘abiti’ effettuali. Non bastano i suoi testi scritti per comprenderlo, non bastano le sue opere. Anzi, queste, come l’architettura dimostra, avranno valore solo in quanto capaci di confrontarsi con la realtà effettuale. Filologia stessa, insomma, impone una rappresentazione realistica, per quanto dolorosa possa risultare, dell’agire umano. Come sarebbe possibile interpretarne le opere ignorando l’autore? Come contentarsi di osservare l’opera compiuta, ‘in forma’, senza seguire il cammino che a essa ha portato? Se non si ficca l’occhio nell’esserci dell’animale incurabilis, il nostro Umanesimo diverrà consolante, sedentaria erudizione. L’occhio albertiano si decide in questo senso con tanta consapevolezza da non potersi trovare l’uguale in tutto l’Umanesimo [56] – tuttavia il dramma che esso vede è largamente condiviso. Leon Battista dà la voce più potente a contraddizioni e conflitti che appartengono alla trama più profonda ed essenziale di tutta questa età. Essenziale comprendere che non si tratta di superficiali contraddizioni o di una semplice varietà di voci e caratteri; filologia significa volersi esprimere, voler comunicare; comunicare è possibile soltanto conoscendo l’interlocutore, «quis es, tu, homo?»; fedeltà al testo implica realismo antropologico. Le grandi opere che studiamo non debbono portare ad alcuna adulazione dell’uomo, bensí costringerci a comprenderne la drammatica complessità. Riflettendoci sul loro specchio, anzi, è piuttosto la nostra ‘miseria’ ad apparire: nella grande poesia la inopia del nostro eloquio, nella grande architettura quella del nostro edificare. Esse non debbono servire a consolarci, bensì piuttosto sostenerci nel perseverare nella ricerca, nello sforzo per conferire una forma che duri al nostro presente doverci esprimere e abitare.
Per risalire a tale forma è però necessario attraversare lo stesso inferno. Se ne rimuovi l’esistenza, se lo ignori, se non dipingi il pessimo e nel tuo quadro trova luogo soltanto l’immagine della dignitas, non sarai né buon filologo né buon artista. E tanto meno buon filosofo. Non lo ha affermato lo stesso Platone nel Fedone (97d, 4)? Dal pericolo sommo di un simile descensus nascono le architetture albertiane; tanto piú esse stanno, quanto piú sfidano l’inesorabile opera del tempo «da cui son vinte anche le pietre», quanto piú ad infera affondano le loro fondamenta. Le tonalità che assume la ‘stagione all’inferno’ albertiana toccano corde varissime, spesso risonanti insieme nel medesimo brano, dal riso piú mordace del Momus [57], che farà ritorno nei ‘calci’ e negli ‘scherzi’ dell’Asino machiavellico, al sarcasmo piú amaro, dalla parodia alla malinconia piú luttuosa. Camaleonte anche l’Alberti tragico. Perfino l’opera fatta per durare va letta in lui come maschera. E la maschera piú cupamente pessimistica trova forse la sua ‘stazione’ nel secondo libro del Theogenius. L’uomo non è soltanto vittima della perfidia della Fortuna, non è semplicemente in balia dell’universale, cosmica vicissitudo, poiché neppure nei cieli è quiete, ma di questa costituisce elemento, fattore, soggetto attivo. Non è un destino alieno, non sono le stelle a farci incapaci di stare. Fra tutti gli essenti siamo noi gli infermissimi; l’ordine ‘fatale’ che esige che tutte le cose siano sempre in moto si esprime perfettamente soltanto nella natura dell’uomo. Non sono cause esteriori a farci effundere lacrimas, a costringerci sempre a «grandissima fatica»; se si trattasse soltanto di entrare ai ferri corti con esse, potrebbero ancora valere quei saggi consigli stoici ed epicurei che abbondano nel primo libro. No, è l’agitazione invincibile del nostro stesso animo, l’impotenza a stare che abita in noi, a risultarci fatale. È la nostra stessa natura a colpirci, poiché essa ci ha fatto «animale irrequieto e impazientissimo di suo stato alcuno e condizione». Sempre mutiamo, senza mai mutare noi stessi. E tale inquietudine si trasforma necessariamente nell’incapacità di lasciare in pace. «Di quivi nasce la pace e la guerra...» (L’Asino, III,94). Impossibile che un’anima per se stessa agitata sopporti o tolleri di non travolgere con sé ogni altro essente. La sua violenza non è errore o vizio emendabile, ma espressione della sua natura. «Vitia erunt donec homines». Cosí possiamo diventare lupi agli altri (il filologo sa che viene da Plauto l’homo homini lupus...), volere asservire e soggiogare ogni essente, fare quasi del nostro ventre «publica sepultura di tutte le cose». Dirà l’amarissimo porco incontrato dall’Asino machiavellico (Asino d’oro, che attraverso la sofferenza viene iniziato al duro sapere, non afflitto dall'‘asinità’ bruniana): «Non basta quel che ’n terra si ricoglie, | ché voi entrate a l’Oceano in seno | per potervi saziar de le sue spoglie» (L’Asino, VIII, 100-2). La nostra natura è la vera matrigna, la sua ontologica stultitia che mai ti rende «di cosa alcuna contento né sazio». Questa colpa è iscritta tragicamente nella costituzione del nostro esserci, fino a farci apparire gli infelicissimi fra tutti gli enti.
Il disincanto che svelle dalle radici, come in Machiavelli («Tanto v’inganna il proprio vostro amore, | che altro ben non credete che sia | fuor de l’umana essenza e del valore», (L’Asino, VIII, 31-33)), ogni possibile finalismo antropocentrico, che abbatte ogni boria o presunzione, ha in se stesso, tuttavia, il contraccolpo. Un’amicizia stellare lega Alberti a Leopardi anche in questo: quando ti sembra di esser giunto al fondo del pessimismo, proprio a quel punto devi scavare ancora; e allora forse vedrai fiorire la Ginestra. Non si tratta di immaginare utopisticamente la nascita di un ‘uomo nuovo’, ma di comprendere come da una stessa linfa possano maturare contrapposte possibilità. L’assoluto pessimismo è altrettanto irrealistico delle lodi e delle adulazioni per l’umana virtú. Che virtus si dia è un fatto, se non altro quella di volgere ai colpi della Fortuna «il viso di lacrime asciutto» (L’Asino, III, 85-87). Lo mostrano le bonae artes antiche e moderne, che la filologia custodisce e interpreta. Ma è virtus di quello stesso esserci dannoso agli altri e a se stesso, ambizioso e avaro, invidioso e violento. Come si combinano in una sola anima simili dissonanze? Non le si supera, se non conoscendole e sopportandole – questo insegna il Theogenius. L’agitazione continua che sconvolge l’uomo «efferatissimo» agli altri e a se stesso è necessaria radice del cogitare. Togli l’inquietudine e l’impazienza per il proprio stato e toglierai non solo superbia e violenza, ma anche gli «artefici innumerabili» che l’ingegno e lo studio producono. Elimina le maschere, l’ipocrisia, il simulare e dissimulare con cui gli uomini reciprocamente si ingannano ed eliminerai quelle ‘finzioni’ che sono le sue stesse opere piú grandi, quasi in lotta contro il tempo che tutto divora. ‘Guarisci’ l’anima dalla sua insaziabilità di volere addirittura ‘emendare’ e contraffare la natura e vedrai spegnersi anche la sua volontà di conoscerne ogni segreto. Rendi l’anima ‘contenta’, liberala dalle «varie aspettazioni», che le impediscono di vivere il presente, e tacerà anche quella somma virtus, che si esprime nell’investigare sempre, nel ricercare instancabilmente cose nuove. Incurabilis è l’uomo di questo dissidio che ne marca la natura, conflitto non tra principî separati e opposti, lotta immanente alla sua radice. Homo naturalis è questo – ma se è questo, ciò significa che nella vicissitudo che lo costituisce sussiste realmente anche la possibilità del cogitare, dell’operare, del produrre, non solo di denaturare la natura, ma di conoscerla e rappresentarla, non solo di essere peste all’altro, ma anche civis, solidale con l’altro, riconoscente lui, nella polifonia della res publica. Destino è l’esserci inquieto e insaziabile; a noi tuttavia spetta la decisione in quale forma assumerlo, come prendervi parte, conoscerlo e affrontarlo. Fato la vicissitudo di cui siamo partecipi e non spettatori, e la cui suprema espressione apparirà, con Pomponazzi e Bruno, «il mutamento di natura religiosa», e tuttavia viverla da schiavo, in preda alle tempeste della Fortuna, o invece stare desti, «mai partirsi dal timone», volgere la cura che ci assilla verso un’opera che sembri poter restare, è scelta che il Fato stesso assegna a ciascuno, cui nessuno può sottrarsi. Questa libertà è l’altra faccia del Necessario.
Nessuno nell’Umanesimo riconosce piú di Alberti e Machiavelli la potenza della Fortuna. Senza Fortuna propizia neppure l’impero romano si sarebbe costituito e avrebbe potuto cosí a lungo durare. Proprio quello Stato che si tempra nella piú dura disciplina innalza meravigliosi templi alla Fortuna! Che cosa significa questa dea in politicis? Il complesso degli eventi imprevisti e imprevedibili, o che almeno cosí ci appaiono nel fiume della Vita. Essi stanno perciò sempre a fronte di ciò che vogliamo, progettiamo e perseguiamo. Senza tali cause mai potremmo farci neppure l’idea della Fortuna. Dopo l’accaduto è sempre possibile indicarle, e sempre risulterà evidente anche il ruolo della Fortuna nell’aver concesso a quelle intenzioni, a quei propositi, ai nostri dover-essere, di valere finalmente in tutto o in parte. La causa indica ciò che ha reso possibile un evento e in nessun modo la necessità che esso avesse realmente luogo. Il vento che spinge le nostre vele, come nell’emblema di casa Rucellai, non è potenza che appartenga loro. Un drammatico timbro tacitiano domina le pagine sul nesso virtù-fortuna in Alberti e Machiavelli – del Tacito che sarà carissimo a Vico.
Impiger mens quella dell’uomo, aveva detto Lucrezio [58]. Mente che può risolversi in mera incostanza, in una vana instabilità, preda della Fortuna e delle passioni, così come, all’opposto, immaginare e costruire le supreme misure del Sant’Andrea. Sempre instancabile rimane, sempre incapace di quiete. Plastes et fictor sia quando inscena il carnevale tragico-grottesco del Momus, sia quando dà forma e organizza la propria esistenza, i propri nec-otia nel febbrile tumulto, nella competizione che segna la vita cittadina, e che in ogni momento può trasformarsi in guerra, in stasis. Un camaleonte l’animale uomo, sia quando inventa maschere per travestirsi e ingannare, che quando ‘ri-vela’ in forme sempre nuove, dietro facciate come quella di Palazzo Rucellai, i propri interessi, i propri affari e le proprie cure. Plasmare, fingere bisogna sempre, se si vuole affrontare il mestiere che Leon Battista, come poi Machiavelli e lo stesso Guicciardini, sanno per personale esperienza essere il piú faticoso di tutti: il vivere – e per affrontarlo non basterà industria, consiglio, arte, saranno necessari mani, piedi e nervi. Tutte le ‘ragioni del corpo’ dovranno allearsi a quelle della diligenza, della sollecitudine, della cura per navigare il fiume della Vita, sfidarne tempeste e naufragi (Fatum et fortuna) [59]. Poiché la machina che siamo è complessione indissolubile di corpo e mente, e se anche l’uomo avesse il doppio dell’ingegno ma non avesse la mano, ‘organo de gli organi’, non esisterebbero dottrine, istituzioni, edifici e città (la famosa pagina della Cabala del cavallo pegaseo sembra venire davvero direttamente dall’Alberti!) [60].
La pazienza che occorre nel navigare il fiume Bios è altrettanto impiger dell’impazienza di quelli che si affannano a sopravvivere trascinati dalla corrente. Virtus sarà costruire bonae artes come naviculae, cui aggrapparsi, per giungere alla sponda ultima ‘contenti’ soltanto di avere cosí bene vissuto. Libertà è data, nessuna stella può sottrarcela, ma costretta in questi limiti, che non sono semplicemente quelli dell’universale Fato, bensí quelli derivanti dal nostro intimo essere contraddizione: creatori e perturbatori, artefici e contraffattori, lupi gli uni agli altri e ‘animali politici’, pronti perfino a «soffrire le fatiche della patria», agitatissimi e impazientissimi nello stesso dover sempre cercare, inventare e conoscere. Complexio oppositorum, da cui si origina il meglio e il pessimo del thauma che è l’uomo. Complexio che occorre rappresentare razionalmente, misurare, organizzare in un quadro spazialmente compiuto. Thauma, insomma, che occorre guardare e dipingere secondo la «dolce prospettiva» [61]. Come Messer Filippo ha insegnato. Ma all’interno di tale spazio palpita in tutta la sua concretezza il dramma di quella summa di opposti che è l’uomo – e tale dramma occorre anche saper rendere secondo i suoi colori, le sue ombre, in tutta la gravità delle sue masse, dei suoi pesi. Questo vedrai, fermissima immagine, alla cappella Brancacci, o scolpito per sempre da Donatello sul volto dei suoi profeti. Vedrai nelle opere di quei sommi che sono davvero tutt’uno con l’opera che realizzano, pur sapendola peritura, e che mai fuggono da tale dolorosa coscienza.
Credo non sarebbe difficile mostrare (andando oltre quella ‘divisione in epoche’ che Ernst Robert Curtius considerava propria «di una miope scienza storica») come questo timbro tragico dell’Umanesimo albertiano abbia nel Petrarca del Secretum e di tante Epistulae [62] la sua fonte prima. Poco importa quanto consapevole. La traccia fondamentale che conta ricostruire è quella che intercorre fra Petrarca [63], Alberti e Machiavelli, che trova in Valla il senso philosophicus maxime da attribuire a Filologia, e che costituisce, come vedremo, il controcanto necessario, e nient’affatto semplicemente contraddittorio, alle correnti neoplatoniche. La volontà albertiana, consapevole quanto quella di Petrarca della fragilità delle proprie intenzioni («quotiens volui nec potui»), manca certamente della religiosa fede di questi, non ha un Agostino a sorreggerla. E tuttavia uguale è il loro «desiderium vehemens surgendi», e se l’anelito alla renovatio è inteso da Petrarca anzitutto come metanoia-conversio, neppure in Alberti manca la nostalgia per il colloquio dell’anima con sé sola, per la solitudine contemplativa (la sua figura nelle Disputationes camaldulenses non è affatto un’invenzione). L’Agostino del Petrarca è quello del tormentato itinerario delle Confessioni, e il Paolo che egli ama rimane infinitamente lontano da quello che Ficino ‘sistemerà’ neoplatonicamente. Un Agostino che alimenta costantemente quel desiderio, senza che mai esso giunga a soddisfarsi. Come nell’Alberti, l’uomo non può pervenire ad alcuno stato: «si a stando status dicitur, nullus hic homini status est, sed fluxus iugis ac lapsus» (come non ‘precipitare’ con la mente allo Schicksalslied dell’Hyperion? «Doch uns ist gegeben, | Auf keiner Stätte zu ruhn...». Dal Petrarca ha sempre inizio il canto-threnos di Europa). L’irreparabile tempus, quel tempo «vincitore veloce, predatore delle create cose» (cosí ancora Leonardo!), che sembra aver travolto la stessa Roma, che pare produrre, piú che mutatio, ruina, è nostro segno e carattere. Tempo è l’esserci stesso, che tutto muta e perturba, che non può in nessuna opera trovare quiete, insaziabile, mal-contento sempre, perfino nelle espressioni somme della propria potenza. Anche le nostre opere più ‘virtuose’ avranno, allora, il timbro dell’incompiutezza, del tentativo, dell’indizio. La loro sostanza è quella stessa del nostro esserci, di noi, gli interroganti, nos interrogantes. Chi interroga non dà risposta, non produce risultati, ma soltanto, e se saprà con pazienza tentare e ritentare, una grande quantità di cominciamenti, «tanta coeptorum moles». Ma che di vera mole, allora, si tratti! Che l’opera appaia davvero un monumento alla nostra capacità di dare-inizio, di procedere sempre oltre, di interrogare ancora. Segno di inopia, certamente, ma anche indomita volontà di inaccessa tentare (come Petrarca dice in una famosa lettera al Boccaccio), ‘armandosi’ dei classici del passato proprio per essere in grado di affrontare la navigazione a noi destinata.
Tuttavia, anche a questo proposito, nessuno avverte piú dolorosamente del Petrarca come questo riguardare indietro per procedere innanzi costringa a dubitare, per la coscienza cristiana, di aver posto saldamente mano all’aratro. Già nel Petrarca vive il dramma del rapporto tra Umanesimo e Rivelazione: Atene e Gerusalemme non sono, neppure sotto il piú stretto riguardo filologico, schematicamente separabili, e però ciò non comporta alcun pacifico dialogo tra le due ‘fonti’ del nostro stesso presente; all’opposto, per Petrarca la stessa grandezza del passato che egli venera è sempre anche vissuta come periculosum maxime, come energia capace di ‘sedurci’ da quel radicale mutamento di mente e anima, da quella conversio integrale di tutto il nostro esserci, cui il Cristo ci chiama. A un tempo, è evidente come sottenda continuamente il pensiero del Petrarca l’idea che proprio il ‘ritorno’ al classico possa rivitalizzare, ‘ringiovanire’ la cristianità, o almeno frenarne la decadenza, i cui segni palesi possono anche essere interpretati ‘astrologicamente’, e tragicamente, come presagi della sua fine. La contraddizione deve essere sostenuta, ‘tollerata’, non possiamo sperare di sanarla, così come non possiamo eliminare, quasi si trattasse di errori logici, quel carattere o dèmone della nostra natura, in cui nobiltà si intreccia a inquietudine, la volontà d’arte a malinconia, la nostalgia d’andare a costante attrazione per la stessa accidia, quella natura per cui l’itinerario del ritorno a se stessi, in interiore, piuttosto che con la visione della verità, si conclude con la drammatica scoperta della molteplicità dei nostri nomi, non con l’Uno, ma con la sua stessa originaria divisio.
Soltanto l’eloquenza dei Padri dispone, per Petrarca, dell’energia necessaria per convincere alla conversio. L’eloquenza dei Padri versus la verbositas degli scolastici, non solo dei detestati averroisti [64]. La sua forza non sta nell’arrangiare discorsi, costruire sillogismi, ma nell’affermazione che amare vale piú di ogni sapere. Amare soltanto può vincere la miseria della volontà che fa il male pur vedendo il bene. Non si supera l’angoscia che da tale miseria ci viene con il ragionamento, ma in forza di caritas [65] – e a una tale misura di amore non si perviene se non gratia adiuvante. L’eloquenza dei padri ci ha comunicato tale principio con le parole più appassionate e appropriate, lo ha reso davvero suavis grazie anche alla copiosità delle invenzioni e immagini con cui lo ha espresso, e cioè grazie, in fondo, alla sua natura poetica. L’Alberti non condivide questa fede nella predicazione dell’amore; non parla in nessun luogo di una Grazia che ci aiuti a conquistarla; tantomeno in lui la virtú umana potrebbe mai oltrepassarsi fino alla deificatio; e tuttavia affonda in quella del Petrarca la sua visione dell’inesorabile contrasto nell’anima tra posse e velle, e dell’instancabile anelito della volontà, proprio sul fondamento di tale contrasto, nel dar forma comunque al proprio esistere, per riuscire ad abitare, nonostante tutto, nella propria stessa inquietudine. Nessuna fede in Alberti che l’insana natura umana possa giungere a scoprire un balsamo per le proprie ferite, ma a conoscerle sì. La sofferenza produce questo sapere, ed esso è segno del piú alto grado di virtù cui sia possibile ambire. Tragicamente, anche il sapere genererà, poi, sofferenza (i termini dell’assioma tragico classico, pathei mathos, possono essere in ogni istante invertiti), poiché appunto farà vedere come costitutivo del nostro esserci ciò che prima potevamo illuderci fosse puro accidente o semplice occasione. Questo circolo è evitabile solo ignorando la nostra essenza, gettandoci nel fiume Vita come rottami, serrando il nostro sguardo alla realtà e, nello stesso tempo, il nostro orecchio a quella voce che chiama dal fondo della coscienza (voce che ciascuno nomina come può) a essere liberi, tanto da edificare la nostra dimora, entrare in colloquio con il classico che sfida il tempo, marcare attraverso questo colloquio con ‘l’immortale’ il tempo che siamo. L’occhio emblema dell’Alberti rimane in-sanamente insonne di fronte allo ‘spettacolo’ dell’esistenza, nell’infinita varietà delle figure e maschere in cui essa si esprime, della follia che la scuote, senza la quale, tuttavia, neppure sarebbero mai nate le divine manie poetiche, poetico-profetiche e filosofiche.
L’emblema albertiano dell’occhio alato e saettante [66] non può perciò essere letto attraverso le lenti di un Umanesimo-Humanismus e così ridotto a immagine dell’acutezza dello sguardo unita alla rapidità dell’ala. Certo vigile e circospetto è quest’occhio, e solare sembra esserne la natura. L’emblema non contrasta con la venerabile tradizione che vede nell’occhio un dio tra le membra. Ma la inquieta e interroga. Quid tum? Che vedi, dunque? A quale realtà può rivolgersi la tua luce? Che cosa illuminare? Scopri forse le ragioni ultime del tuo esserci infermissimo? Oltrepassi forse i limiti del suo sapere per indizi, per congetture? Trasformi la mole dei suoi tentativi e cominciamenti in opere divine? Chi vedi? «Fabulae sumus», risponderà l’amaro riso del Codro alla fine del secolo [67]. L’occhio vola, sì, ma soltanto quaggiú può rivolgersi, soltanto al mondo sotto la luna si riferisce il suo raggio. Non gloriarti di esso, non adularne le ali. Anche quello del Defunctus ne possiede la virtù, eppure non raccoglie in sé che lo spettacolo delle miserie umane. Spettacolo da cui non deriva, però, alcun facile pessimismo: quello sguardo è terso, non un filo di nebbia lo offusca, perfino i raggi del sole sopporta fermamente. Se, come Giobbe, non sa frugare fino all’estremo limite, se pur scandagliando il fondo dei fiumi non sa trovare ‘il luogo dell’intelligenza’ («Sapientia vero ubi invenitur?»), tuttavia dipinge vera mente ciò che vede, ne comprende i rapporti. Non è visio Dei, ma pittura sì, pittura che analizza e commisura, dolorosa e vera, della condizione umana. Eloquenza della pittura, in quanto compiuta resa in immagine dell’idea. Lungi dal poter dar luogo ad accidia o disperazione, essa appare condizione necessaria anche di ogni conversio, poiché non si cambia mente e cuore se non attraverso la stretta dell’angoscia. Qui è eco della voce di Paolo nel Petrarca, e forse piú ancora della religiosità della devotio moderna, opposta tanto alla verbositas teologica quanto alla superstiziosa credulitas. Per questi fili, tali correnti della spiritualità trecentesca possono collegarsi al disincanto dell’Alberti. Tutto vedi, mio occhio? «Tutto»?! Soltanto sulla tua stessa realtà ti è stato concesso di volare. Sovra-umanarti non puoi; aspetta un poco e ascolterai ‘l’ultima’ parola di Montaigne (o è Momo che parla?): «e sul piú alto trono del mondo non siamo seduti che sul nostro culo». E trovi forse pace al colmo della tua potenza? Insonnia soltanto è il dono concessoti. Hai forse quel riposo e quella quiete cui anelavi in terra? Ancora meno ora che sembri conquistare il cielo. Che voluptas ti viene dal tuo essere alato? E, ancora piú, ora che vedi ‘tutto’, sei forse giunto finalmente a vedere te stesso? O hai incontrato quella pupilla di un altro dove specchiarti, che Socrate invita Alcibiade a scoprire (Alcibiade Maggiore,132d-133c)? Hai forse trovato il segreto che ci consenta di rappresentarci secondo il nostro vero nome? Il soggetto della rappresentazione, ‘l’artista’, non può rientrare nella rappresentazione stessa. Chi è colui che mi guarda dal dipinto in cui mi sono ritratto? Quis est? Qui es, tu? In quale spaventosa notte si penetra quando si fissa negli occhi un uomo? In quale mondo di fantasmagoriche ed enigmatiche rappresentazioni – si chiederà Hegel? Malinconia del simbolo dello Specchio e della grande ritrattistica del manierismo, che già qui si annuncia. Inquietudine dell’immagine, agitarsi nella inventio dell’emblema albertiano di diverse e dissonanti interrogazioni.
Lezione antidogmatica, skepsis autentica, che ancora potrebbe trovare in una rilettura del Petrarca la propria fonte. Troppo spesso se ne è interpretato il pensiero come un semplice ‘rigetto’ di scienza e filosofia ‘rigorose’. Tra i passi che vengono citati a proposito, famosissimo quello della Senile da Venezia (V, 2), in cui Petrarca narra del suo incontro con uno dei tanti intellettuali padovani averroisti, teologi e religiosi solo per l’abito, ma pronti a ‘latrare’ in privato «contra Christum et coelestem Christi doctrinam». Costui disprezza apertamente la fede del poeta: «tuos ecclesiae doctorculos tibi habe», quel tuo apostolo Paolo non fu che un «seminator verborum et insanus»; se tu riuscissi a comprendere Averroè vedresti quanto egli sia superiore «tuis his nugatoribus»! E Petrarca lo caccia con sdegno. Testimonianza estrema e un po’ patetica di una religiosità al tramonto? Atteggiamento antiscientifico, funzionale all’esaltazione della poesia? Nessuno più di Petrarca è cosciente dei limiti di quest’ultima rispetto allo stesso discorso teologico. Nella durezza della sua opposizione ai dottori padovani occorre avvertire soprattutto il formarsi di una consapevolezza critica nei confronti del carattere dogmatico di un certo aristotelismo, consapevolezza che animerà tutto il dibattito filosofico successivo. L’atteggiamento fondamentale del Petrarca non è affatto ‘oscurantista’; esso lascia piuttosto presagire la docta ignorantia. Non certo a caso una parte del De remediis venne confusa con il De vera sapientia cusaniano dagli editori del Quattrocento! Per non dire dell’evidente rapporto tra l’antiaverroismo di Petrarca e quello di Ficino. Certo, la polemica del poeta pensante contro occamisti e scotisti, le nuove scuole ‘gotiche’ che vanno dis-facendo la grande architettura scolastica ‘latina’, sembra ridursi a esercizio retorico, e tuttavia il limite del loro formalismo logico viene compreso: che cosa giunge a dire di ciò che è specificatamente umano una filosofia ridotta a logica, al raggiungimento di un’interna coerenza nell’ordine del discorso? Analogamente, come potrebbe un’etica meramente intellettuale suscitare amore per la virtú, muovere a essa? La felicità che promette non è vera, poiché la fa coincidere con la coerenza dell’agire a imperativi razionali. Qui a Petrarca soccorrono la fede e il suo Agostino; tuttavia la critica all’intellettualismo dell’etica classica, nelle sue varie espressioni, fermenterà lungo tutto il pensiero dell’Umanesimo, in quella sua direzione critica, antidogmatica, che ne fa un’alba tutt’altro che incompiuta per il pensiero del Moderno.
Un’etica intellettualistica non può corrispondere al bisogno supremo dell’esserci umano: la felicità. Essa fallisce, cioè, nel suo stesso dichiarato obiettivo: quello dell’eudaimonia. E qui di nuovo filologia e filosofia si sposano. Valla si interroga nel De vero bono su come tradurre l’Agathon, il sommo mathema per Platone? Summum Bonum aveva proposto il Bruni. Ma quel ‘sommo’ manca nel greco. Se il Bene deve essere sommo non potrà intendersi che nella forma di un perfetto ‘indiarsi’, di una compiuta omoiosis theoi. Felicità allora non potrà trovarsi che in Deo. Felicità impossibile alla finitezza mortale. Un’etica orientata all’Agathon come Summum Bonum è un’etica rivolta a sovra-umanare il nostro esserci, condannandoci così all’insoddisfazione e all’infelicità. L’idea di virtù non può contraddire la nostra natura. E ciò avviene sia interpretandola secondo un astratto intellettualismo, sia ‘traducendo’ malamente Platone in una prospettiva altrettanto astrattamente dualistica, che separi Bene da voluptas. «Voluptatis causa omnia fieri». A questo Bene tendiamo – a perseverare nel nostro esserci e a goderne tendono tutti i nostri conatus. E questa volontà di Bene è comune a tutti gli enti sotto il cielo, per quanto si esprima per diversi gradi, e nell’uomo possa manifestarsi anche nel ricercare e conoscere razionalmente. La voluptas propriamente umana (voluptas, e non «turpis voluptas», spiegherà Ficino nei Commentariola in Lucretium) sta nell’inquisitio, nel godimento per l’apprendere, l’indagare, lo scoprire, nel piacere che viene dal saper fare opere che soddisfano intelletto e sensi. Poiché si tratterà sempre anche di piacere sensibile; il corpo lo prova! La voluptas non è disincarnabile. E occorre dipingere l’uomo che a essa tende, lieto nell’agitarsi stesso del pensiero, felice in corpore nel movimento stesso dell’anima. Certo, qui Valla intende la Natura, lucrezianamente, come Venus benigna, e cosí intenderà «la profonda dottrina del dotto Lucrezio» lo stesso Bruno, energia che rende possibile il raggiungimento della voluptas. Profondamente scettico su ciò l’Alberti, e lo sarà ancora piú Machiavelli. Anche per loro virtus significa tendere a un fine determinato, e mai è fine a se stessa, ma in entrambi la drammatica di Valla si approfondisce e radicalizza: la natura umana non guida affatto, può ingannarci, anzi, in merito al fine, può indurci in errore nel perseguirlo; può addirittura spingerci a nuocere a noi stessi. Lo spartito è quello di Valla; l’esecuzione differisce profondamente, o forse, meglio, la dissonanza è immanente alla musica che si suona, poiché essa vuole rappresentare il piú inquietante, il dissonante in sé: il nostro esserci semper indagandum poiché sempre indagante-interrogante. La presunzione di fondarsi su qualche solida auctoritas per poterlo rappresentare è vana illusione. Non l’auctoritas aiuta, ma l’insaziata curiositas (da cura!), l’osservazione instancabile della realtà, senza ‘idealizzarne’ alcun aspetto. ‘L’occhio’ dell’Alberti introduce a quello leonardesco, alla sua «bramosa voglia» di ficcarsi nell’ignoto, di penetrare nella «mirabil necessità» che tutto anima e tutto collega, nella ‘caverna’ del mondo, della «artifiziosa natura» [68]. Potrebbe essere, io credo, l’occhio del piú giovane dei ‘tre filosofi’ del Giorgione, fiducioso della propria forza, fisso di fronte alla caverna-ingens sylva, pronto a esplorarla e rappresentarla; abissi di ignoto, sì, gli si presentano dinanzi – ma nulla di inconoscibile.
Inquieta la natura, energia in ogni suo atomo, e tuttavia sempre in moto, in perenne trasformazione – dove prima era roccia, ora è mare, dove montagna pianura, dove acqua terra –, inquieto l’occhio che vuole penetrarla. Se non lo fosse, nulla avrebbe in comune con il suo oggetto e nessuna relazione potrebbe prodursi. Le forme con cui l’occhio di Leonardo comprende la natura sono quelle con cui Dio stesso crea «numero, pondere et mensura»; la sua scienza non può esser letta da chi non sia ‘matematico’; e tuttavia quella «divina proporzione» che egli apprende dal grande Luca Pacioli, del quale illustrerà mirabilmente l’opera, affonda le sue radici nel De pictura, è parente strettissima del De re aedificatoria, riprende quel pro veritate laborare che è il motto della Dialectica di Valla, contemporanea delle prime, e forse piú drammatiche, opere albertiane. Verità effettuale, non rivelata. Verità semper indaganda da philo-sophia e philo-logia indissolubilmente unite, poiché l’infinito finito che si presenta di fronte all’inarrestabile mente che è propria del nostro esserci interrogante non potrà mai venire completamente conquistato, ridursi a un calcolo e misura definitivi. E da un tale thaumazein, da una tale tremenda meraviglia, si rianima anche sempre il senso religioso dell’esistere, fino ad assumere timbri apocalittici: «nulla rimarrà sulla terra che non sia tormentato e distrutto», «o terra che cosa aspetti a spalancarti e precipitare gli uomini nella profonda apertura dei tuoi abissi?». Scienza, misura e senso tragico dell’esistenza si fondono in questi autori, nella ‘catena’ che essi formano; non una vaga Stimmung, ma una filosofia li accomuna, che cerca di costruire un logos capace di guardare al «carattere enigmatico, temibile, distruttivo, che si cala nel fondo dell’essere» [69] con il rigore e la potenza della costruzione prospettica.
Note
* Paragrafo 4, pp. XLIX-LXVIII. Si è scelto di mantenere la notazione originale.
54 Il testo di Bramante è stato pubblicato da C. Pedretti nel suo importantissimo volume Leonardo architetto, Milano 1978.
55 In modo del tutto analogo si esprime Alberti nel Prohemium al settimo libro delle Intercenales: l’eloquenza è cosa assai varia; anche Cicerone cambia moltissimo da uno scritto all’altro e solo gli imbecilli idolatrano tutti gli scrittori del passato. La varietà degli ordini, di cui si parla nel De re aedificatoria, va riscontrata e applicata anche nell’oratoria. Il problema è esclusivamente sempre quello: «dicere apte et luculenter».
56 Gli studi che hanno aperto la strada a questa interpretazione dell’Alberti sono quelli di Garin (Rinascite e rivoluzioni) cui ha ‘corrisposto’ C. Vasoli (Alberti e la cultura filosofica), che ha introdotto il Convegno internazionale dedicato nel 2004 all’Alberti (Alberti e la cultura del Quattrocento). Le ricerche in particolare di R. Cardini (Attualità dell’Alberti, "Professione architetto" II [1995]; Id., Alberti e la nascita dell’umorismo moderno, "Schede umanistiche" I [1993]), di F. Furlan, Studia albertiana, Torino - Parigi 2003, di G. M. Anselmi, Letteratura e civiltà tra Medioevo e Umanesimo, Roma 2011, e Id., L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento, Roma 2013, mi sembrano proseguire e sviluppare con intelligenza e sim-patia la linea di questi maestri. Fondamentali pagine sull’Alberti ‘in prospettiva’ bruniana in Ciliberto, Pensare per contrari. Disincanto e utopia nel Rinascimento, Roma 2005, 115-132, e nel saggio Sogno, ombra, dissimulazione. Variazioni di un tema, in Id., L’occhio di Atteone, Roma 2002.
57 Sul tema il riferimento d’obbligo è alle ricerche di M. Bachtin, Tvorcěstvo Fransua Rable i narodnaja kul′tura srednevekov′ja i Renessansa [trad. it. L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Torino 1979]; cfr. anche R. Klein, Le rire, in aa.vv., L’Umanesimo e “la follia”, Roma 1968; C. Segre, Fuori del mondo, Torino 1990; sul Momus: A. Tenenti, Il Momus nell’opera dell’Alberti, in Id., Credenze, ideologie, libertinismi tra Medioevo ed Età Moderna, Bologna 1978; S. Simoncini, L’avventura di Momo nel Rinascimento. Il nume della critica tra Leon Battista Alberti e Giordano Bruno, "Rinascimento" XXXVIII (1998), e il saggio introduttivo di F. Furlan all’edizione dell’opera presso Mondadori, Milano 2007. Sulla maschera e il riso dell’Alberti, cfr. L. Cesarini Martinelli, Metafore teatrali in Leon Battista Alberti, "Rinascimento" XXIX (1989). Debbo, infine, rinviare al mio saggio Il Momus dell’Alberti, in Il principe invisibile, Tournhoot 2015.
58 Da quando nel 1418 Poggio Bracciolini inviò al Niccoli il manoscritto, ora perduto, del De rerum natura, il confronto con l’epicureismo lucreziano è diventato fattore imprescindibile del pensiero umanistico e rinascimentale. E ciò vale per lo stesso neoplatonismo, che con Ficino ‘tradusse’ la voluptas-libertas di Lucrezio in divina voluptas (già con i giovanili Commentariola in Lucretium e nel De voluptate). Anche nella definizione della ‘concordia’ tra platonismo e teologia cristiana potevano essere fatti rientrare motivi lucreziani, come, ad esempio, quello riguardante la non eternità o divinità del mondo (motivi, peraltro, già presenti nell’antica apologetica). Il ruolo che giocherà Lucrezio, fin nello ‘stile’, nel pensiero del Bruno sarà ancora più determinante. Cfr. H. Jones, The Epicurean Tradition, London - New York 1989 [trad. it. La tradizione epicurea, Genova 1999]; V. Prosperi, «Di soavi licor gli orli del vaso». La fortuna di Lucrezio dall’Umanesimo alla Controriforma,Torino 2004.
59 Per le Intercenales disponiamo ora di un’eccellente edizione a cura di F. Bacchelli e L. D’Ascia, che ne hanno steso anche un’ampia e importante Introduzione, «Delusione» e «Invenzione» nelle Intercenali di Leon Battista Alberti, Bologna 2003.
60 Anche sotto questo profilo è la filosofia-pittura di Leonardo a esprimere, prima del Bruno, la posizione più radicale: il corpo, per la sua formidabile organizzazione, è cosa divina. Lui è il miracolo grande, e anima non è che il suo essere-animato. È il tema fondamentale dei grandi saggi di Valéry (in Oeuvres, vol. I, Paris 1957, 1153-1269) su Leonardo: per Leonardo, egli dice, «la morte viene interpretata come un disastro per l’anima», e si chiede: come esser filosofi se si è senza mani e senza occhi?
61 Intorno alla visione prospettica confluiscono i motivi simbolici, filosofici e scientifici dell’Umanesimo, a partire dalla stessa forma e dal valore che il vedere assume in Dante. Lo ha mostrato nella sua monumentale raccolta A. Parronchi, Studi sulla dolce prospettiva, Milano 1964, che contiene in appendice anche il Della prospettiva di Paolo dal Pozzo Toscanelli.
62 Utilissima, a questo proposito, l’antologia curata da L. Chines: Petrarca, Lettere dell’inquietudine, Roma 2004.
63 «Un genio delle origini» è il Petrarca per K. Stierle, Francesco Petrarca, München 2003 [trad. it. La vita e i tempi del Petrarca, Venezia 2007], dove lo stesso confronto con Dante (l’ascensione dantesca contrapposta al «vagando e cogitando» del Petrarca) serve a mettere in evidenza la ‘modernità’ di quest’ultimo. Coscienza della svolta d’epoca e tormentata impotenza a immaginarne un esito risolutivo caratterizzano l’opera del Petrarca anche per U. Dotti, Petrarca e la scoperta della coscienza moderna, Milano 1978.
64 Cfr. Vasoli, La dialettica e la retorica dell’Umanesimo. «Invenzione» e «Metodo» nella cultura del XV e XVI secolo, Milano 1968, cap. i: «Antichi» contro «moderni».
65 Saranno tutti motivi che ritroveremo in Ficino, studiati da C. Vasoli in numerosi saggi; cfr. soprattutto Filosofia e religione nella cultura del Rinascimento, Napoli 1988, parte I. Importante per capire la posizione niente affatto ‘passatista’ del Petrarca ‘pensatore’ è avvertire già in lui la presenza dell’idea che si farà chiara nella docta ignorantia di Cusano: G. Santinello, Nicolò Cusano e Petrarca, in Id., Studi sull’umanesimo europeo, Padova 1969. (Cfr. anche G. Cuozzo, Mystice videre, Torino 2002, cap. iii).
66 Tutta la letteratura sull’emblema albertiano è riportata e discussa da A. G. Cassani, L’occhio alato. Migrazioni di un simbolo, Torino 2014 (con un mio saggio). In generale sul simbolismo dell’occhio: W. Deonna, Le symbolisme de l’oeil, Oaris 1965 [trad. it. Il simbolismo dell’occhio, Torino 2008 (con una Introduzione di C. Ossola)].
67 Capitolo essenziale per intendere il ‘riso’ umanistico l’opera di Antonio Urceo, sul quale sarà ancora da leggere il piccolo classico di E. Raimondi, Codro e l’Umanesimo a Bologna, Bologna 1950 (nuova ed. con Introduzione di A. Emiliani, 1987). A Codro il Raimondi ha dedicato forse il suo ultimo scritto, Il mio incontro con Codro, in A. Urceo Codro, Sermones I-IV, a cura di L. Chines e A. Severi, Roma 2013. A Bologna, a partire dal magistero di Filippo Beroaldo, matura tutto un platonismo ‘proverbiale’, ironico e disincantato, eppure in strettissimo rapporto con quello fiorentino, la cui corrente prosegue fin nello spirito degli Adagia erasmiani (cfr. ora la bella monografia di A. Severi, Filippo Beroaldo il Vecchio, un maestro per l’Europa, Bologna 2015).
68 Come non rammentare il formidabile passo del codice Arundel? «... e tirato dalla mia bramosa voglia, vago di vedere la gran copia delle varie e strane forme fatte dalla artifiziosa natura, ragiratomi alquanto infra gli ombrosi scogli, pervenni all’entrata d’una gran caverna, dinanzi alla quale resstato allquanto stupefatto e igniorante di tal cosa, cominciai piegato le mie reni in arco, e ferma la stanca mano sopra il ginochio, e colla destra mi feci tenebre alle abbassate e cchiuse ciglia, e sspesso piegandomi in qua e illà per vedere se dentro vi dissciernessi alcuna cosa, e questo vietatomi per la grande osscurità che là entro era, e sstato allquanto, subito salse in me per contrarie cose, paura e desiderio: paura per la minacciante e oscura spilonca, desiderio per vedere se là entro fusse alcuna miracolosa cosa».
69 G. Guida, Arte e natura in Machiavelli e Leonardo, in F. Meroi (a cura di), Con l’ali de l’intelletto. Studi di filosofia e di storia della cultura, Firenze 2005, 28.
Umanesimo tragico
Raphael Ebgi
Sullo sfondo dei drammi, che hanno segnato il destino d’Europa, si muovono gli umanisti italiani; drammi di cui essi furono testimoni, quando non protagonisti, e che in ogni caso s’imposero, per grandezza, alla loro attenzione, finendo per influenzarne e fino a modellarne il pensiero. E fu così non solo per le figure che vissero tra la metà e la fine del Quattrocento, ma anche per gli uomini di cultura dei primi decenni del secolo. In proposito, un esempio significativo è rappresentato dalla lettera in cui Poggio Bracciolini (1389-1459) descrive all’amico Leonardo Bruni la pubblica discussione della causa per eresia di Girolamo da Praga, seguace del riformatore ceco Jan Hus (circa 1372-1451) [18].
Girolamo era professore di logica e teologia, maestro d’arti, ma anche elegante oratore [19], aspetto, quest’ultimo, di cui diede ampia prova nel corso del processo, in particolare allorché fu costretto, dai giudici, a replicare alle numerose imputazioni raccolte contro di lui dai suoi accusatori. Poggio, che era presente, confessa di aver trattenuto a stento la sua meraviglia di fronte al portamento dell’accusato e alla sua eloquenza: «Non ho mai visto nessuno [...] avvicinarsi di più all’eloquenza di quegli antichi che tanto ammiriamo». Terminato il lungo interrogatorio, fu concessa all’imputato la possibilità di esporre la propria apologia. Egli disse subito di sentirsi ingiustamente accusato. Ma che la storia insegnava che molti innocenti subirono tormenti, esili, e persino la morte per mano di corrotti giudici. Tra i più grandi Socrate e lo stesso Gesù. Lui era pronto a seguire il loro esempio, a subire supplizi, a cedere ai suoi nemici e alle loro accuse menzognere. La morte non lo spaventava, anzi, scrive Bracciolini, egli «pareva desiderarla». Gli furono concessi due giorni per ritrattare. Non lo fece. Seguirono allora la condanna per eresia e le fiamme. Girolamo andò al supplizio «sereno e gioioso in volto». Il suo ultimo gesto fu quello di invitare il littore ad appiccare il fuoco davanti ai suoi occhi, non alle sue spalle. Infine, mentre le lingue del rogo si alzavano, a malapena interrotto dal fumo, intonò un inno a Dio, seguito da queste parole: «Signore, Dio Padre onnipotente, abbi pietà di me, perdona i miei peccati. Perché tu sai quanto sinceramente ho amato la tua verità!» [20]. La mente corre al Socrate citato dallo stesso Girolamo, e al canto del cigno da questi evocato nel Fedone, che si fa più bello nel momento in cui l’uccello sente la fine approssimarsi, perché felice di andare verso il suo dio [21]. Morte degna di un filosofo, e da vero filosofo, glossa Poggio, se ne andò il predicatore ceco.
Il tono di questa lettera risulta certo sorprendente (e sorpreso si disse apertamente il suo destinatario) [22], se solo si pone mente al fatto che tanto rammarico e compassione per le sorti di un eretico impenitente provenissero da un uomo al servizio del pontefice. Ma qui a risuonare non è la voce del segretario apostolico [23], bensí quella, piú intima e autentica, del letterato «innamorato degli antichi», della loro cultura e parola – grazie a cui un uomo, diceva, si eleva al di sopra degli altri uomini [24] –, la voce dell’umanista che sentiva suo quell’ideale, si potrebbe dire socratico, di agire virtuoso e magnanimo, che conduce al disprezzo di fortuna, all’accettazione della sorte avversa e della morte. Ideale nel quale già i suoi predecessori avevano scoperto la più alta e sincera forma di humanitas. Si pensi, su tutti, a Petrarca (1304-1374), autentica fonte di quella vena tragica che affiora qui in Poggio, e che segnerà tanta parte della filosofia del Quattrocento, e in particolare a certe sue lettere, dove la morte si fa res a cui viene inchiodata la meditazione. Un confronto con la ‘fine’, questo, rischioso ma essenziale, scrive il poeta, perché solo facendo di essa la cosa del pensiero gli uomini potranno esorcizzare i fantasmi che la sua immagine suscita nella loro mente, e smettere così d’essere «viandanti a rovescio», appassionati del cammino, timorosi della meta. A chi ‘sappia’ la morte, infatti, essa apparirà quale termine delle tremende fatiche della vita e liberazione dalle sue infinite vicissitudini. Una meta a cui tutti sono destinati, ma a cui si può volare in modo consapevole e felice, o verso cui si può essere trascinati come schiavi, in catene.
Alla luce di questo pensiero la realtà trasfigura. Le speranze di cui l’uomo colora l’esistenza si rivelano vane, vuoti i timori che la rendono triste e dolorosa; folli i ‘sogni’ di chi pone valore soltanto negli splendori superficiali del presente, che si angoscia e tribola per onori, ricchezze, potere (miseria vestita di luce!), che perde corpo e anima in questo «imperscrutabile labirinto di errori». Il tempo è vortice inarrestabile, e chi si affidi a esso sarà trascinato come da impetuosa corrente, e vivrà inquieto, tormentato, invecchiando tra gemiti e lacrime. Da stolti, infatti, credere che una qualsiasi delle nostre arti possa fabbricare stabili dimore in questo giorno di burrasca che è la vita. La natura dell’uomo è vulnerata. Le sue sorti in balia della fortuna. Il suo sapere, per quanto vasto, è poca cosa, e sempre imperfetto. Vuoti i suoi ragionamenti, e incapaci di arginare l’angoscia, se non si traducono in pratica di vita virtuosa, ossia se non possiedono la forza di superare il piano degli umani accidenti, per toccare le cose nella loro realtà: «philosophandum nobis et rebus est» [25]! Ecco allora che solo il pensiero della morte, rivelando le cose del mondo per quel che esse sono in verità, educa l’uomo ad amare, e non a temere, l’inevitabile [26]. Soltanto in questo modo la debolezza che segna la nostra condizione terrena si converte in virtú, giacché soltanto per questo amore, che supera ogni misura umana, l’anima diventa capace di sfiorare – fino anzi a vedere pienamente (visio beata) [27] – quella sapienza che tutte le cose ha fatto: la sapienza di Dio.
È l’insegnamento di Agostino, certo, anche se verrebbe da pensare, ancora una volta, alle pagine del Fedone e in particolare a quel passo, che Petrarca appunta di suo pugno, in cui Socrate, dopo aver insegnato a ogni uomo a vivere ornando la propria anima di tutte le virtú, cosí da sconfiggere la paura degli inferi, s’incammina verso l’ingiusta morte, rispondendo senza esitare alla chiamata del destino: «iam vocat Parca» [28]!
Questo timbro tragico della riflessione sull’uomo e sulla sua condizione, per quanto declinato in forme diverse, segna la riflessione dei grandi eredi quattrocenteschi del Petrarca. Si pensi alle pagine più cupe dell’Alberti (1404-1472), e in particolare al secondo libro del Theogenius, dove l’esistenza degli uomini, agitata da un’invincibile irrequietezza – che li spinge persino a «tragettarsi [...] fuori del mondo» – si risolve in sofferenza e lacrime, e mai è libera dall’ombra sinistra della morte, che accompagna ogni suo passo, e che è scura e priva di ogni annuncio celeste. O a Valla (1407-1457), al suo Del libero arbitrio, libello in forma di dialogo composto nel 1434, in cui egli pone l’accento sull’insana volontà di conoscere propria dell’uomo, tanto folle da pretendere d’illuminare, con la sola e ben povera luce della ragione, la notte in cui riposa la causa del volere divino, e giunge (qui la maggiore differenza con l’Alberti) a un’esaltazione di quella fede di carattere paolino, le cui benefiche radici affondano negli abissi della nostra debolezza. O ancora, per scavalcare il secolo, ai fulminanti Ghiribizzi al Soderini di Machiavelli (1469-1515), nei quali, con estremo disincanto, è denunciata la drammatica condizione dei mortali, costretti alla fatica di adattare la loro natura al continuo mutare dei tempi e degli ordini delle cose, mai sicuri di riuscire nella loro opera, perché «havendo li huomini prima la vista corta et non potendo poi comandare alla natura loro, ne segue che la fortuna varia et comanda ad li huomini» [29].
A esiti non dissimili era giunto anche il pensiero del celebre teorico della dignitas hominis, Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494). Persino lui, infatti, che aveva prima cercato risposta alla sua domanda sull’uomo, e alla «magia» della sua natura, nella letteratura classica, nelle immagini della tradizione segreta ebraica e nelle poesia di un Oriente fantastico, si ritrova, negli ultimi anni della breve vita, a fare appello alla fede e al vivere virtuoso per fronteggiare le angosce dell’esistenza terrena [30], e a riporre le speranze di futura salvezza in una preghiera che affiori dal fondo dell’anima e nelle opere di elemosina – perché «conviene che Dio disprezzi te uomo, se prima tu uomo avrai disprezzato un altro uomo» [31]. Come non avvertire, in queste parole, l’eco della voce del frate di San Marco? di quel Savonarola che prima di venire tacciato d’essere l’Anticristo fu amico del conte, e che finí per esercitare su di lui una profonda influenza [32]? Ecco che il percorso iniziato con il rogo di Girolamo da Praga riconduce al profeta di Ferrara, nella cui figura vivono, giungono al loro apice, e infine si frantumano le tensioni di un intero secolo.
Note
* Paragrafo III-IV, pp. 9-13. Si è scelto di mantenere la notazione originale.
18 L’interesse per la riforma hussita rimase vivo anche nell’ambito del piú tardo Umanesimo italiano, come dimostrano le parole di ammirazione con cui Ficino, nella seconda metà del Quattrocento, esaltò la Praga ‘riformata’, cfr. M. Ficino, Opera omnia, Basel 1576, 1404 [In dialogum quintum de Iusto, epitome].
19 Le scarse notizie biografiche su Girolamo da Praga sono state raccolte e discusse da R. R. Betts, Jerome of Prague, "University of Birmingham Historical Journal" I (1947), 51-91.
20 Ibid., 90.
21 Cfr. Platone, Phaedo, 84e-85a.
22 Nel rispondere a questa missiva, infatti, Bruni invita Poggio a essere piú circospetto, trovando rischiosa quella sua aperta esaltazione dei meriti dell’eretico Girolamo, cfr. Leonardo Bruni, Epistolarum libri VIII, recensente L. Mehus (Firenze 1741), a cura di J. Hankins, Roma 2007, vol. I, 120 [IV, 9].
23 Questo il ruolo rivestito, all’epoca, da Bracciolini.
24 Cfr. in proposito la lettera spedita da Poggio a Guarino Veronese, da Costanza, il 15 dicembre 1416 (incipit: «Licet inter quotidianas»), in E. Garin (a cura di), Prosatori latini del Quattrocento, Milano - Napoli 1952, 242-243.
25 Petrarca, Res Seniles. Libri I-IV, a cura di S. Rizzo, con la collaborazione di M. Berté, Firenze 2006 44 [I, 3, 33]: «Bisogna filosofare su di noi e sui fatti».
26 Cfr. Id., Le familiari, ed. critica a cura di V. Rossi, 4 voll., Firenze 1933-42, vol. IV, a cura di U. Bosco, 83 [XXI, 12].
27 Cfr. C. Trottmann, Pétrarque à la fracture de la philosophie dans le «De sui ipsius et multorum ignorantia», in J. Biard e F. Mariani Zini (a cura di), Ut philosophia poesis. Questions philosophiques dans l’œuvre de Dante, Pétrarque et Boccace, Paris 2008, 171-190.
28 Cfr. Platone, Phaedo, 115a. Sulle note del Petrarca al Fedone (dialogo da lui letto nella traduzione latina medievale di Enrico Aristippo), cfr. L. Minio-Paluello, Il «Fedone» latino con note autografe del Petrarca (Parigi, Bibl. Naz., cod. Lat. 6567A), "Atti dell’Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti classe di Scienze morali, storiche e filologiche" IV (1949), 107-113.
29 Oltre a quelli segnalati nella nota introduttiva al testo, altri studi fondamentali sui Ghiribizzi si trovano in C. Dionisotti, Machiavellerie. Storia e fortuna di Machiavelli, Torino 1980, 73-78 ; M. Ciliberto, Pensare per contrari. Disincanto e utopia nel Rinascimento, Roma 2005, 133-154.
30 Si prendano a esempio le due lettere spedite al nipote, entrambe risalenti al 1492, dove ritorna il lamento per la miseria della vita dei mortali, che non è se non affanno, travaglio e fatica. Persino i suoi piaceri si iscrivono tra i due poli della stanchezza (causata dalla loro continua ricerca) e del tormento (che sorge dalla loro inevitabile perdita). Ma empio è abbandonarsi a tale ‘destino’, e chi lo farà è come affidasse la vita nelle mani del diavolo, ponendola «sotto i vessilli della morte». Per far fronte a questo avversario, l’uomo deve sobbarcarsi l’arduo compito di soffrire le sofferenze del mondo, farsi da esso crocifiggere – morire al mondo – per essere cosí esaltato in Dio, e giungere a vivere in Lui, dove solo è vera vita. Questa misura di dolore supera però le possibilità umane e non sarebbe sopportabile se non ci si affidasse alla misericordia divina, cfr. G. Pico della Mirandola, Epistola a Giovanfrancesco Pico, Firenze, 15 maggio 1492 (incipit: «Discendenti tibi», in Id., Opera omnia, Basel 1557, 340-343; Id., Allo stesso, Ferrara, 2 luglio 1492 (incipit: «Felix es fili», ibid., 344-46)).
31 Cfr. Pico della Mirandola, Opera omnia, cit., 343: «Neque enim decet ut te Deus hominem non contemnat, qui prius homo hominem contempsisti».
32 Sui rapporti tra Pico e Savonarola cfr. G. C. Garfagnini, Pico e Savonarola, in P. Viti (a cura di), Pico, Poliziano e l’Umanesimo di fine Quattrocento, Firenze 1994, 149-157.
Ghiribizzi al Soderini*
Epistola a Giovan Battista Soderini, Perugia 13-21 settembre 1506
Nicolò Machiavelli
Ghiribizi scripti in Perugia al Soderino.
Una vostra lettera mi si presentò in pappafico; pure, dopo dieci parole la riconobbi. Et veramente io credo la frequentia di Piombino per conoscervi; et delli impedimenti vostri et di Filippo son certo, perché io so che l’uno è offeso da el poco lume et l’altro da el troppo. Gennaio non mi dà noia, pure che febraio mi regha fra le mani. Dolgomi del sospetto di Filippo, et suspeso ne attendo el fine. Fu la vostra lettera breve, et io, rileggiendo, la feci lungha. Fummi grata perché mi dètte occasione ad fare quello che io dubitavo di fare, et che voi mi ricordate che io non faccia; et solo questa parte ho riconosciuta in lei sanza proposito. Di che io mi maraviglerei, se la mia sorte non mi havessi mostre tante cose et sì varie, che io sono constrecto ad maraviglarmi poco o confessare non havere gustate né leggiendo né pratichando le actioni delli huomini et e’ modi del procedere loro. Conoscho voi et la bussola della navigatione vostra; et, quando potessi essere dannata, che non può, io non la dannerei, veggiendo ad che porti vi habbi guidato et di che speranza vi possa nutrire (onde io credo, non con lo spechio vostro, dove non si vede se non prudentia, ma per quello de’ più, che si habbi nelle cose ad vedere el fine et non el mezo), et vedendosi con varii governi conseguire una medesima cosa et diversamente operando havere uno medesimo fine; et quello che manchava ad questa opinione, le actioni di questo pontefice et li effetti loro vi hanno adgiunto. Hannibale et Scipione, oltre alla disciplina militare, che nell’uno et nell'altro excelleva egualmente, l’uno con la crudeltà, perfidia, inreligione mantenne e’ suoi exerciti uniti in Italia, et fecesi admirare da’ popoli, che, per seguirlo, si ribellavano da e’ Romani; l’altro, con la pietà, fedeltà et religione, in Spagna hebbe da quelli popoli el medesimo séguito; et l’uno et l'altro hebbe infinite vittorie. Ma, perché non si usa allegare e’ Romani, Lorenzo de’ Medici disarmò el popolo, per tenere Firenze; messer Giovanni Bentivogli, per tener Bologna, lo armò; e Vitelli in Castello et questo duca d’Urbino nello stato suo disfeciono le forteze, per tenere quelli stati; el conte Francesco in Milano et molti altri le edificorno nelli stati loro, per assicurarsene. Tito imperadore, quel dì che non benificava uno, credeva perdere lo stato; qualchun altro, lo crederrebbe perdere el dì che facessi piacere ad qualchuno. A molti, misurando et ponderando ogni cosa, rieschono e’ disegni suoi. Questo papa, che non ha né stadera né canna in casa, ad caso conséguita, et disarmato, quello che con l'ordine et con l’armi difficilmente li doveva riuscire. Sonsi veduti o veggonsi tucti e' soprascripti, et infiniti altri che in simili materia si potrebbono allegare, adquistare regni o domarli o cascarne secondo li accidenti; et alle volte quello modo del procedere che, adquistando, era laudato, perdendo, è vituperato; et alle volte, dopo una lunga prosperità, perdendo, non se ne incolpa cosa alcuna propria, ma se ne accusa el cielo et la dispositione de’ fati. Ma, donde nascha che le diverse operationi qualche volta egualmente giovino o egualmente nuochino, io non lo so, ma desiderrei bene saperlo; pure, per intendere l'opinione vostra, io userò presuntione ad dirvi la mia. Io credo che, come la Natura ha facto ad l’huomo diverso volto, così li habbi facto diverso ingegno et diversa fantasia. Da questo nascie che ciascuno secondo lo ingegno et fantasia sua si governa. Et perché da l'altro canto e' tempi sono varii et li ordini delle cose sono diversi, ad colui succedono ad votum e’ suoi desiderii, et quello è felice che riscontra el modo del procedere suo con el tempo, et quello per opposito, è infelice che si diversifica con le sue actioni da el tempo et da l’ordine delle cose. Donde può molto bene essere che dua, diversamente operando, habbino uno medesimo fine, perché ciascuno di loro può conformarsi con el riscontro suo, perché e' sono tanti ordini di cose quanti sono provincie et stati. Ma, perché e' tempi et le cose universalmente et particularmente si mutano spesso, et li huomini non mutono le loro fantasie né e’ loro modi di procedere, adcade che uno ha un tempo buona fortuna et uno tempo trista. Et veramente, chi fussi tanto savio che conoscessi e tempi et l'ordine delle cose et adcomodassisi ad quelle, harebbe sempre buona fortuna o e' si guarderebbe sempre da la trista, et verrebbe ad essere vero che ’l savio comandassi alle stelle et a' fati. Ma, perché di questi savi non si truova, havendo li huomini prima la vista corta, et non potendo poi comandare alla natura loro, ne segue che la Fortuna varia et comanda ad li huomini, et tiègli sotto el giogo suo. Et per verificare questa opinione, voglo che mi bastino li exempli soprascripti, sopra e' quali io la ho fondata, et così desidero che l’uno sostengha l’altro. Giova ad dare reputatione ad uno dominatore nuovo la crudeltà, perfidia et inreligione in quella provincia dove la humanità, fede et religione è lungo tempo abbundata, non altrimenti che si giovi la humanità, fede et religione dove la crudeltà, perfidia et inreligione è regnata un pezo; perché, come le cose amare perturbano el gusto, et le dolci lo stuchano, così li huomini infastidiscono del bene, et del male si dolgono. Queste cagioni, in fra le altre, apersono Italia ad Annibale et Spagna ad Scipione, et così ognuno riscontrò el tempo et le cose secondo l'ordine del procedere suo. Né in quel medesimo tempo harebbe facto tanto profitto in Italia uno simile ad Scipione né uno simile ad Annibale in Spagna, quanto l'uno et l'altro fece nella provincia sua.
* Riproduciamo qui l’edizione critica del testo pubblicata da R. Ridolfi e P. Ghiglieri, I Ghiribizzi al Soderini, "La bibliofilia" LXXII (1970), 52-74: 71-74. I Ghiribizzi sono la bozza, stesa a Perugia, di una lettera che Machiavelli forse mai spedí, destinata a Giovan Battista Soderini (1484-1528), in risposta a una missiva di quest’ultimo datata 12 settembre 1506; una nuova proposta di lettura di questa epistola, accompagnata da una diversa ipotesi di ricostruzione del testo (condotta a partire da un’analisi dell’autografo preservato nel cod. Vat. Capp. 107, cc. 219r-221r), viene proposta da C. Ginzburg, Diventare Machiavelli. Per una nuova lettura dei «Ghiribizzi al Soderini, "Quaderni storici" CXXI (2006), 151-164. Per quanto riguarda invece l’ipotesi che questo abbozzo si trovi alla base delle terzine del Capitolo di Fortuna, che Machiavelli dedica allo stesso Soderini, cfr. M. Martelli, I «Ghiribizzi» a Giovan Battista Soderini, "Rinascimento" IX (1969), 147-180: 155-56. Sempre all’articolo di Martelli (nello specifico alle pp. 173-177) occorre rifarsi per la segnalazione dei luoghi paralleli tra i Ghiribizzi e i capitoli del Principe (XXV) e dei Discorsi (III, 8-9) dedicati alla fortuna.
English abstract
A tragic Humanism. A presentation of the book: Umanisti italiani, Pensiero e destino, I Millenni Einaudi, Torino 2016
Hot off the press for the serie "I Millenni Einaudi", comes the volume Umanisti italiani, Pensiero e destino (Italian Humanists. Thought and destiny), edited by Raphael Ebgi with an essay by Massimo Cacciari. A rich introductory contribution (Massimo Cacciari, Ripensare l’Umanesimo – Rethinking Humanism –, pp. VII-CI) is followed by 8 sections with an Anthology of the writings of the fourteenth-sixteenth century humanists, including: Francesco Petrarca, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Lorenzo Valla, Leon Battista Alberti, George of Trebizond, Marsilio Ficino, Cristoforo Landino, Pico della Mirandola, Angelo Poliziano, Girolamo Savonarola, Leonardo da Vinci, Niccolo Machiavelli.
Each section is introduced by an essay on historical context and theoretical study, edited by Raphael Ebgi:
I. Umanesimo tragico (Tragic Humanism)
II. Vita activa. Vita contemplativa (Active Life. Contemplative Life)
III. Filologia e filosofia (Philology and Philosophy)
IV. Metaphysica (Metaphysics)
V. Teologia poetica (Poetic Theology)
VI. Hermetica (Hermeticism)
VII. Cielo e mondo (Sky and Globe)
VIII. Figura future (Future Figura)
Courtesy of the authors and the publisher, we here publish a paragraph of the introductory text by Massimo Cacciari; a paragraph of the introduction Umanesimo tragico (Tragic Humanism) by Raphael Ebgi; and, from the same section I of the Anthology, the epistle of Niccolò Machiavelli to Pier Soderini, dated September 1506.
Per citare questo articolo / To cite this article: M. Cacciari, R. Ebgi, Umanesimo tragico. Presentazione del volume Umanisti italiani. Pensiero e destino, I Millenni Einaudi, Torino 2016 , “La Rivista di Engramma” n. 140, dicembre 2016, pp. 79-108 | PDF of the article