Il 'sorriso' di Melencolia?
A proposito di un volume dedicato ai 500 anni del celebre bulino di Albrecht Dürer
Alberto Giorgio Cassani
English abstract
Eh! quanti precetti qui necessari mancherebbono, Lionardo, a chi volesse lato e diffuso disputarne! come se chi forse avesse dagli astronomi udito che Marte disponga impeto di esserciti e furore d’arme, Mercurio instituisca varie scienze e suttilità d’ingegno e maravigliose arte, Iove moderi le cerimonie e animi religiosi, el Sole conceda degnità e principati, la Luna conciti viaggi e movimenti feminili e plebei, Saturno aggravi e ritardi nostri pensieri e incetti.
Leon Battista Alberti, I libri della famiglia, IV, 1029-1937
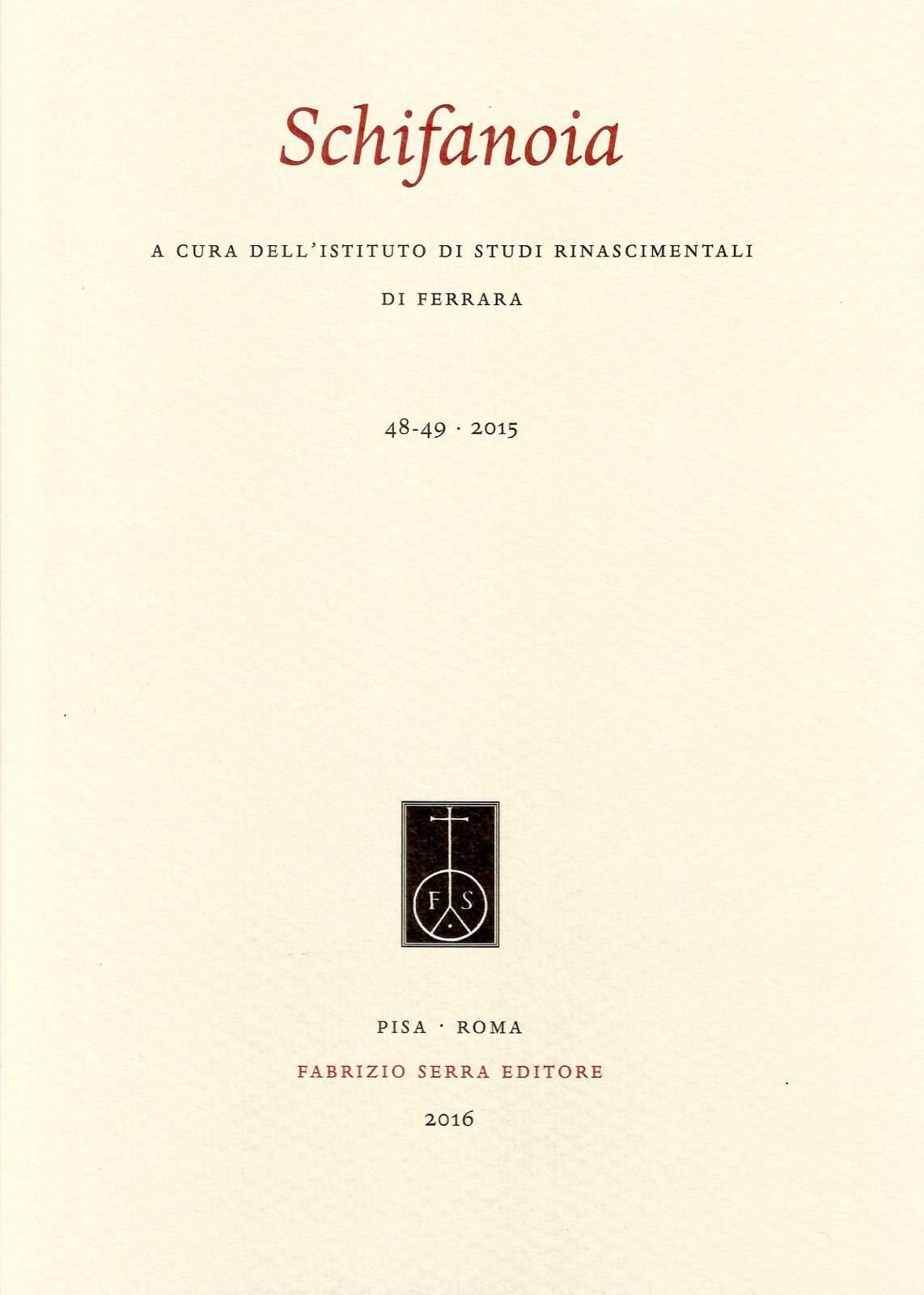
Difficile trovare un bulino più celebre della Melencolia I di Albrecht Dürer. E arduo altresì indicarne uno che, dopo reiterati esercizi di ermeneutica, lasci aperte ancora tante domande sul suo possibile significato. Il fatto è che l’incisione düreriana non è l’indovinello della Sfinge che una volta risolto non ci dice più nulla, ma un “simbolo” (come lo chiama Massimo Cacciari nel suo saggio) che, come scrive il miglior erede di Warburg, Edgar Wind, in Pagan Mysteries in the Renaissance, “è l’opposto di una sfinge; esso è ancora più vitale quando il suo enigma è stato risolto”. A cinquecento anni dall’incisione di quel capolavoro (1514-2014), a cura di Marco Bertozzi, Direttore dell’Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara, si è tenuto un Convegno internazionale in occasione della XVII Settimana di Alti Studi Rinascimentali, dal 4 al 6 dicembre presso la Sala dei Mesi di Palazzo Schifanoia a Ferrara. Gli Atti, suddivisi in due parti, pubblicati con la superba cura di Fabrizio Serra editore (Pisa-Roma) nella rivista “Schifanoia” (vol. 48-49, 2015), organo dell’Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara, vengono qui recensiti. A fronte delle iniziative tenute in Europa in quell’anno, si può dire che quello ferrarese è stato l’appuntamento più importante del cinquecentenario.
Marco Bertozzi, Metamorfosi di Saturno: la “Melencolia” di Albrecht Dürer

1 | Albrecht Dürer, Melencolia I, incisione a bulino, 1514.
L’intervento di Bertozzi, che inaugura la giornata di studi all’interno di una cornice ideale per un tema così warburghiano – gli affreschi di Schifanoia –, sottolinea subito come, di là da qualunque performance ermeneutica, il capolavoro düreriano mantiene “intatta tutta la sua potenza espressiva e la sua inesauribile ricchezza simbolica” (è un simbolo e non un indovinello, avrebbe detto Wind). Bertozzi riassume bene il senso generale di questa “enigmatica icona della nostra modernità”: essa ci mostra “il genio dell’artista rappresentato nel momento della sua meditazione creativa: uno spirito melanconico e saturnino, ma temperato dalla positiva influenza di Giove, attestata dal suo ‘quadrato magico’”. L’Autore, dopo aver ricordato gli studi e le celebri pubblicazioni della scuola warburghiana sul tema (Panofsky-Saxl), passa a parlare dell’interpretazione di Warburg. Nel suo Divinazione antica pagana in testi ed immagini dell’età di Lutero (1920), egli riconosceva il suo debito nei confronti dei lavori pionieristici di Karl Giehlow, “l’amico della scuola di Vienna”, “che aveva scoperto come nell’incisione Melencolia I di Dürer fosse messa in scena l’idea di una congiunzione planetaria (Saturno e Giove), una configurazione celeste favorevole alla cura dei sintomi perniciosi della melanconia, secondo i dettami della medicina astrologizzante del Rinascimento. Anche se, dalla sua intuizione, Giehlow non aveva osato trarre le estreme conseguenze, cioè che il ‘quadrato magico’ di Giove poteva rappresentare un talismano anti-saturnino. Una confortevole soluzione, secondo Warburg, per esorcizzare e mettere a debita distanza fobie ancestrali”. “Saturno, l’antico demone planetario, il dio cannibale che divorava i propri figli […] – prosegue l’Autore – si era nel tempo trasformato in “iuvans pater” (un padre amorevole, secondo le teorie di Marsilio Ficino), dispensatore di benefici doni a chi era destinato a nascere sotto la sua influenza”; “Una metamorfosi attraverso la quale, per esempio, la lentezza si trasforma in attività meditativa, che va in profondità, che scava nell’interiorità e produce il genio pensieroso all’opera”.
Bertozzi aveva già dimostrato, in precedenti saggi, come le fonti filosofiche della Melencolia I si trovassero negli scritti di Marsilio Ficino e come invece il “quadrato magico” di Giove, per questione di date, non potesse dipendere dal De occulta philosophia (1533) di Cornelio Agrippa (dato che nel manoscritto del 1510 i quadrati magici non compaiono). Va anche ricordata, en passant, la proposta, ormai accettata dalla critica, che nella rappresentazione della cometa (in alto a sinistra) e in quella della “misteriosa” pietra poliedrica Dürer abbia voluto evocare il meteorite caduto il 7 novembre 1492 a Ensisheim, vicino a Basilea, dove, proprio in quell’anno, l’artista si era recato per lavorare alle illustrazioni della Nave dei folli di Sebastian Brant. In uno dei fogli volanti che illustrano questo poema, apparirà proprio il meteorite con funzione “apocalittica” (ma in altre opere di Dürer il frammento caduto dal cielo occuperà una posizione di privilegio).
Se Ficino aveva dato consigli a filosofi e letterati su come difendersi dalla malinconia (concentrazione spirituale, alzarsi presto e fare lunghe passeggiate sotto il sole, creare immagini talismaniche – come il quadrato magico), sarà “il geniale incisore” a darli anche agli artisti – dimenticati da Ficino – sempre sulla base dello pseudo-Aristotele, che entrambi ben conoscevano. Invece del “volgare badile” usato dai figli di Saturno per seppellire i morti, Dürer mette in mano alla Melanconia alata un “’geometrico’ compasso del genio”. Dunque, una favorevole congiunzione astrale unisce Saturno e la bonaria influenza di Giove. La magica tavola numerica appare come “una sorta di ex-voto offerto alla salvifica divinità” (Giove).
Saxl e Panofsky criticarono nel 1923 l’interpretazione di Warburg che vedeva, nel conflitto tra Saturno e Giove, il prevalere di quest’ultimo e nemmeno ritennero il quadrato magico – la mensula Jovis – un talismano decisivo, ma solo uno dei tanti e “neppure il più importante”. Ma Warburg farà loro notare che “si erano dimenticati di aggiungere due fondamentali tipologie, di carattere psicologico, come Amleto e Faust” (tema trattato più specificatamente dall’intervento di Claudia Wedepohl). Per Warburg, “a Saturno spettava il compito di allontanare i suoi figli migliori dalla società”, aiutandoli “a concentrarsi in una proficua meditazione creatrice”, mentre Giove “doveva poi riportarli in società, per condividere le conquiste ottenute” ed evitare di essere trasportati negli “’inferi’ dal piombo saturnino”. Proprio in ciò, per Warburg, consisterebbe “la melanconia dell’artista di genio, sospesa in una continua tensione fra depressione e impulso creativo, due parti tra loro inscindibili”. Come chiosa giustamente l’Autore, in nota, in questa duplicità si rispecchiava anche nel dramma vissuto in prima persona: “la discesa agli inferi” del crollo nervoso, e “il ritorno in società da ‘homo victor’”.
Dürer, perciò, nella sua incisione, coglie perfettamente il “simbolo” espresso nella polarità della facies saturnina: “tetra divinità che può divorare i propri figli” e, allo stesso tempo, “padre premuroso che dona loro la creatività del genio”. È probabilmente, per l’Autore, la raffigurazione dell’anima stessa di Dürer.
Massimo Cacciari, Melencolia I: un simbolo?
Allegoria elevata a simbolo: è questo il senso dell’incisione düreriana secondo Massimo Cacciari che, nel suo intervento, ne fornisce anche una nuova interpretazione. Per far questo, bisogna ridurre “lo sterminato oceano delle esegesi” di stampo “allegorico-metaforiche”, ritornando alla “cosa” che qui Dürer ci rappresenta. E qui l’Autore descrive, una per una, le “cose” che compaiono nel celebre bulino. Prima cosa che si osserva: Melanconia tiene in mano un compasso (non la pialla e la sega): “Melencolia appartiene all’arte, di cui va rivendicata la potenza immaginativa e conoscitiva, meta-empirica, non a un fare esecutivo”. Secondo punto: è impossibile “assimilare Melencolia a figure di semplice inerzia o a-kedia. Ella appare piuttosto dominata dalle curae! Nessuna inerzia o pigrizia esprimono la sua posa e tantomeno il suo sguardo”. Il suo sguardo “dardeggiante” medita forse sulle sue opere passate e cerca di presagire “ciò che il Fato va disponendo?”. Quel che è certo, per l’Autore, è che tale sguardo “non si rivolge al basso, né si richiude affatto in sé, in interiore, come avviene in tante immagini o emblemi della Malinconia”. La pietra ben squadrata accanto a lei – “(altro che masse inerti!)” – dimostra che si sta per dar vita ad un edificio. Non esiste filosofia senza fare. Questo è anche il “punto-chiave delle grandi teorie dell’arte dell’Umanesimo, dall’Alberti a Leonardo”. Melancolia ne è un perfetto rappresentante: “Un genio […] del misurare, del ponderare, del progettare è Melencolia, in nessun modo riducibile a “artigiano” e neppure a semplice typus geometriae”. Sì, tutto sembra giacere in un mucchio a terra, strumenti del costruire, pietre ben squadrate… Sembra che l’impotenza blocchi la figura: “Il Costruttore possiede ora chiavi che non aprono, borse colme di un possesso che non frutta, un compasso che non disegna, una mano che non opera, che non disserra, che serve soltanto a reggere il capo”. Ciononostante la sua figura “non denuncia […] una sola fibra di debolezza. Nessun cedimento, nessuna “depressione” nel suo corpo, che rimane magnifico […]. Essa è trattenuta, imprigionata, ma piena proprio nella sua latenza. Lo spirito crepuscolare saturnino ha imprigionato il grande artista: “Inesorabile fugge il tempo – e cioè quell’esserci, il nostro, che è il tempo” (come ben sapeva Alberti). “Nessuno, neppure i geni alati, possono stare. Nessuna opera, neppure la più grande, può dirsi eterna”. “Vi è un momento nella vita – che il genio vivrà con intensità assoluta – in cui l’immagine della vanità delle opere assale, un istante sospeso, tra il giorno e la notte (“in mezzo al cammino”, come lo è la sabbia nella clessidra che pende sul capo di Melencolia) in cui il già-fatto viene a noia e la volontà di provare ancora sembra dilegui, e un bivio ci si apre, allora, dinanzi: o la disperazione (per il genio non può darsi serena rinuncia […]), o il porsi in ascolto, in presagente ascolto, il restare desti in attesa degli dèi avvenire”.
La Melencolia di Dürer sembra non rispondere a questo “bivio”. Ma Dürer lo fa con l’intera sua composizione: la malinconia va guarita dai pericoli dell’akedia, dell’abulia, ma “soprattutto da quello mortale: disperazione”. In ciò, “Giove la soccorre”, attraverso “erbe salutari, prescritte dalla platonica medicina”; attraverso il quadrato magico – il 1514 è posto tra il 4, la pitagorica tetraktys e l’1, “fons et origo numerorum”. “Fortuna o Fato o Stelle pongono perciò Melencolia nelle condizioni di potersi “superare”, di pervenire a vita nuova”. Malinconia deve “elaborare-lavorare” il “proprio lutto”. Ma come avviene questo passaggio da nigredo ad albedo? – Cacciari non ha paura di usare termini alchemici. Il fatto è che lo stato in cui si trova Melencolia non è “semplicemente negativo”. Al contrario. “Senza la crisi col passato […] non si dà genio, non si produce opera alcuna”. Senza far “violenza” su noi stessi “negandoci di godere di ogni godimento limitato”, il carpe diem, non si possono raggiungere quei differenti stadi descritti da Agrippa.
Come Dürer rappresenta tutto ciò? Il Bimbo, posto al centro della composizione, ne è la chiave. “L’opera non può rinascere dalle stesse mani che l’hanno abbandonata”. “Che un’età finisca – scrive Cacciari – non è il segno della debolezza del genio o della sua opera, ma della forza del destino”. È la legge della vicissitudo – ben conosciuta da Alberti, ma da tutto l’Umanesimo filosofico – secondo cui “nulla muore”, bensì tutto “si trasforma e rinnova”, anche se, ahimé, “i volti di un tempo scompaiono”. Ciò procura, inevitabilmente, malinconia, ma “non deve però generare tristezza” né “l’inerte abbandonarsi del canis dormitans” (Alberti, così caro all’Autore, avrebbe detto: un “vilissimo tronco”). Qui sta il senso del Bimbo, “il più prossimo a Melencolia”. “Ridurre questa figura centrale a ‘semplice assistente’” come fanno Saxl e Panofsky in Saturno e la melanconia, “comporta il travisamento della pregnanza del simbolo nella sua integrità”.
Il Bimbo “si esercita […] non sono ancora litterae […] ma ne contengono l’essere in potenza”. “Il Bimbo può essere, cioè, Albrecht Dürer”. Ma, per far sì che ciò accada “non basteranno le stelle, né le cure di Giove”. Occorreranno tutte quelle virtutes che già Alberti aveva indicato. Cacciari le elenca: “industria, disciplina, studio, coltivazione metodica delle proprie capacità immaginative e razionali”. Di più: “nervi, ossa, mani buone, come diceva l’Alberti e dirà Giordano Bruno”. Nell’incisione, la scala coi suoi sette scalini è “intatta” e “salda”. Interi sono, altrettanto, gli oggetti presenti sulla scena: compasso, borsa, chiavi, pietre ben squadrate, “segni della potenza geometrico-matematica dell’artefice”. Pronti a essere utilizzati nella “nuova Età”. L’incisione è, dunque, “esattamente l’opposto di una rappresentazione della vanitas vanitatum”.
Ciò che Dürer qui raffigura, per Cacciari, “non è espressione di alcun determinismo astrale”. Doppi sono tutti i segni che qui l’artista tedesco dissemina. Solo una cosa è certa: “l’ingresso in un tempo di straordinari rivolgimenti, annunciato dalle tragedie che segnano la fine dell’Umanesimo”. Anche il cielo sembra doppio. Siamo così certi, si chiede Cacciari, che quella rappresentata sia una “cometa”? Un elemento che troppo spesso i varî interpreti hanno dimenticato è che “Melencolia dubita”: “Lungi dall’essere inerte, questa Melencolia è tormentata da dubbi e interrogazioni”. “E se la cometa fosse in realtà un grande astro che cade?”. Se fosse un segno del quinto Angelo dell’Apocalisse (9, 1-2)? In ogni caso Dürer, nato quando una cometa illuminava i cieli del Nord, lui, al tempo stesso, “geometra, matematico e artista”, “ha saputo comporre Saturno con Giove”. Anche la cometa è duplice: positiva se viene dal Sole, da Giove o Venere, negativa se saturnina. Di certo, quell’astro-cometa “è segno del ciclo delle epoche: una si chiude, va al suo giudizio, un’altra può aprirsi”. Che sia “il fuoco della Ri-forma che la luce ignea dell’astro annuncia?”. Possibile, secondo Cacciari. Ma segno sicuro di cosa pensasse Dürer di questo indicibile futuro c’è: l’arcobaleno. “Dopo la catastrofe, pace di nuovo. Il cielo non vuole la Fine di tutte le cose”. Ma di nuovo, il concetto di discorde armonia del pensiero cacciariano emerge: non si tratta di pace ecumenica, bensì di difficile pace. Una promessa di pace che “non annulla contraddizioni e catastrofi, bensì, all’opposto, le comprende in sé come necessarie”. “È questa l’essenza del sapere del malinconico. L’inquietudine che tale sapere in lui produce appartiene alla stessa linfa che gli consente di misurare, considerare, ponderare, progettare”. Ma arriva un momento in cui “questo operare lo delude e lo angustia. Sempre la sua opera l’ha lasciato insoddisfatto, ma ora non può che ‘dismetterla. Dovrà ‘svuotarsi’ per lasciar luogo al Bimbo, per permettere a lui di innalzarsi. Nulla in cielo impedisce che tale rivolgimento avvenga. Nulla lo afferma con sicurezza. Il simbolo né dice, né nasconde, ma indica”.
Di fronte a queste parole, non si può fare a meno di pensare all’ultima sequenza di 2001: Odissea nello spazio. Con la morte del protagonista, David Bowman (l’arciere!) – che ha affrontato tutti i pericoli di un viaggio oltre la Luna, verso Jupiter [!] and Beyond The Infinite –, contrassegnata dalla presenza del misterioso monolite, l’ultima immagine che Kubrick ci lascia, nietzschianamente, è quella di un Bimbo che ruota nell’“utero” di un nuovo pianeta: “Ma ditemi, fratelli, che cosa sa fare il fanciullo, che neppure il leone era in grado di fare? Perché il leone rapace deve anche diventare un fanciullo? Innocenza è il fanciullo e oblio, un nuovo inizio, un giuoco, una ruota ruotante da sola, un primo moto, un sacro dire di sí”.
Claudia Wedephol, Warburg, Saxl, Panofsky and Dürer’ Melencolia I.

3 | Aby Warburg, ritratto, Warburg Institute, London.
Il saggio dell’archivista del Warburg Institute, l’unico in inglese, si sofferma sulle divergenze tra l’interpretazione della Melencolia I svolte da Warburg in Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten (1920) e il saggio di Panofsky-Saxl Dürer’s Melencolia I. Eine quellen-und typengeschichtliche Untersuchung. “We dont’t believe to have found a particular solution to the problem; we have only carried further what is written in the study on ‘Luther’”, così scrive Fritz Saxl a Warburg (nella traduzione inglese dell’Autrice) il 30 gennaio 1924 e si capisce subito che la questione parte col piede sbagliato. Saxl pare davvero convinto che il libro scritto a due mani con Panofsky costituisca un passo avanti rispetto alle ricerche del loro maestro. Dedicatosi al tema sin dal 1905, Warburg, secondo quanto afferma Peter-Klaus Schuster (Melencolia I. Dürers Denkbild, 1991), aveva derivato la sua interpretazione dallo studio di Giehlow (Dürers Stich Melencolia I und der maximilianische Humanistenkreis, 1903), a favore di una “optimistic interpretation of Dürer’s invention” (Schuster in trad. Wedephol). Scopo del saggio dell’Autrice è dimostrare, sulla scorta di Schuster, che l’interpretazione warburghiana “differed significantly” da quella dei due allievi. Per far ciò si servirà sia di documenti nuovi che di una rilettura del saggio su Lutero del 1920. Un altro motivo di contrasto, forse, è stata la paradossale vicenda della cura del volume di Giehlow intrapresa da Panofsky-Saxl, risoltasi con la decisione di non poter pubblicarla così com’era per palesi carenze interpretative del testo (secondo i curatori), il cui risultato è, appunto, il saggio Dürers Melencolia I del 1923. Ma questo “compromise”, spinge i due studiosi a concepire un’opera ben maggiore che, però, come sappiamo, “per l’influsso di Saturno”, uscirà soltanto nel 1964. La principale critica di Warburg – come si apprende da uno scambio epistolare con Saxl – ruota attorno alla mancanza, in Dürers Melencolia I, di “two quintessentially melancholic types”: l’Amleto di Shakespeare e il Faust di Goethe. In particolare il primo era stato definito da Warburg, nel saggio su Lutero del 1920, “laconically”, “Saturnkind” (1920). Per Warburg, il dialogo col “gravedigger” (becchino) era in realtà un “monologue with one side of his own twofold saturnine nature”, mentre nel Faust II, Goethe “had transformed the base shovel [badile] into an instrument of salvation”.
Appare qui la visione “duplice” (sim-bolica) di Warburg di un Saturno che muore e rinasce. Warburg in una lettera a sua moglie Mary del febbraio 1923, scriveva, in riferimento al bulino di Dürer, che “The spring bow [compasso] in the hand [sc. della Melencolia di Dürer] […] spiritualises the sickle [falce]”. L’autrice poi, nel capitolo ‘Typenlehre’, ‘Typenkunde’ and ‘Typengeschichte’, discute le differenze del concetto di “Typus” tra Warburg e Panofsky-Saxl, mentre in quelli successivi – Melancholy - Acedia - Bipolarity e Inner Tension: the Hamlet-Problem – affronta, nel primo, l’analisi del concetto di acedia nell’antichità greco-romana e nel Rinascimento, in particolare Ficino; mentre, nel secondo, ritorna sul “problema Amleto” in Warburg, analizzando la sua conferenza del 1926 dedicata a Rembrandt und die italienische Antike. L’ultimo capitolo – Mourning River Gods – ribadisce come il tema della Malinconia sia stato, anche dopo la pubblicazione del saggio su Lutero, sempre presente in Warburg, nonostante egli non abbia pubblicato nulla di definitivo (occorre ricostruire il suo pensiero da lettere, frammenti, voci di diario e note). Ma questi documenti sparsi, per l’Autrice, dimostrano “once again that his very own concept of a structural polarity of the human mind also counted as model for mental ambivalence and inner conflicts”, così come si potrebbe affermare che Warburg “tried to capture an innate bipolarity in the malinchonic type”. Come sempre, Warburg ha tratto questo concetto dalla mitologia classica. In questo caso la figura in posizione “reclinata”, erede dell’immagine antica delle divinità fluviali, è addolorata per la sua condizione terrena che le impedisce di salire “into supernatural spheres”, a cui il suo “innate heliotropism” ambirebbe.
Quest’impossibile ascesa platonica, causata dalla nostra “esistenza ancora corporale”, è magistralmente espressa nel frammento Manet and Italian Antiquity, scritto da Warburg nel suo ultimo anno di vita: “Doomed to remain on river-banks and mountains they raise themselves, whether in awe or longing, to spheres of light never to be their own. Their eyes, completely absorbed by the fearful spectacle of the divine epiphany, speak of nostalgia and the burden of still-corporal existence – the fate of the non-Olympians”.
Saverio Campanini, Melencolia II. Gershom Scholem e l’istituto Warburg. Un’indagine di storia delle fonti e dei tipi.
L’Autore affronta il tema del rapporto tra Scholem e Warburg. L’occasione, per Scholem, di ripensare, dopo tanto tempo, con quella distanza permessa dalla “saggezza” e dalla “rigidità”, “doni inseparabili dell’età avanzata”, si presentò nel 1977, quando egli ricevette la traduzione inglese dell’Ursprung des deutschen Trauerspiel di Benjamin fatta da John Osborne con l’introduzione di George Steiner. Steiner vi sosteneva, a un certo punto, che se l’opposizione di Panofsky non avesse impedito a Benjamin di portare felicemente a termine il “tentativo di avvicinamento” all’Istituto Warburg, egli vi avrebbe trovato “una dimora intellettuale e un clima psicologico […] assai più confacente alle sue attitudini di quanto non dovesse rivelarsi in seguito la frustrante e, con il senno di poi, fatale collaborazione con l’Istituto per la ricerca sociale di Francoforte” di Horkheimer e Adorno. Queste parole non potevano non avere colpito chi “aveva passato buona parte della sua vita, dopo il settembre 1940, a chiedersi se Benjamin si sarebbe potuto salvare”. Scholem, nella lettera che scrive a Steiner il 28 giugno dello stesso anno, giudica questa ipotesi come ciò che gli “pare maggiormente degno di nota nella sua introduzione”, ma osservando subito che il “flirt con il comunismo” era “più antico” di qualsiasi contatto con l’Istituto di Francoforte e si chiedeva, dubitativamente, “se i membri del circolo Warburg avrebbero potuto svolgere una finzione efficace” nel distrarre Benjamin “da quella, per Scholem decisiva, illusione”. Nella lettera, poi, Scholem rivela a Steiner l’esistenza di una lettera, inviatagli da Saxl il 17 giugno 1928, e scomparsa dall’archivio di Scholem fin dal 1936, che invece la sua prima moglie aveva ritrovato tra le vecchie carte e gli aveva riconsegnato nel 1976. Nella lettera, Saxl affermava di aver apprezzato il libro di Benjamin (ricevuto in dono da Warburg) e di volerlo incontrare. Ciò che Scholem non sapeva era che lo stesso Saxl aveva a suo tempo scritto in modo riservato a Panofsky, ricevendone la conferma della “freddezza” del suo giudizio sull’opera benjaminiana, pur imbarazzato per il tono usato nella lettera inviata a Hugo von Hofmannsthal che aveva pubblicato il capitolo sulla Malinconia della tesi di Benjamin sulla sua rivista “Neue Deutsche Beiträghe” (2, 3, 1927). Come scrive in una nota l’Autore, “Il libro di Benjamin è l’oggetto di una triangolazione tra Warburg, Saxl e Panofsky che appare anche quale evidente segno d’imbarazzo: è come se vi si riconoscesse un tratto famigliare e, nello stesso tempo, una qualche deformità che nessuno è disposto a guardare in faccia”. Ma, si chiede Campanini, “era davvero solo per via di Benjamin che Scholem ripensava, quasi colto di sorpresa, a Warburg e al suo circolo?”. E subito si risponde: “ci pensava in re propria”.
L’interesse per Warburg, per l’Autore, risale alla biografia scritta da Gombrich, che egli “lesse con avidità”, ma anche “con una certa delusione”. In una lettera del 22 febbraio 1971, assieme alle lodi, Scholem esprime, seppur con molto tatto, “le sue riserve sulla decisione di passare sotto silenzio le ‘sfere oscure’ e l’irrazionale”. Il “diagramma della mente” di Warburg, esplicitato dal catalogo della sua biblioteca e dalla stessa distribuzione sugli scaffali, evidenziavano un “‘resto irriducibile’” rispetto “al quadro riconciliato e olimpico” offerto da Gombrich nel suo libro. Al lato “apollineo”, mancava decisamente quello “dionisiaco”. Scholem, del resto, non era d’accordo nemmeno con l’anonima stroncatura della recensione del “Times Literary Supplement”, firmata, come Scholem aveva ben compreso da Edgar Wind, nemico giurato di Gombrich: per Wind “la biografia warburghiana di Gombrich contiene troppa tetraggine, o malinconia […] troppo poca a parere di Scholem”.
Nonostante quello che Scholem ha voluto far credere del circolo di Warburg – da lui in tarda età considerato alla stregua di “una delle “sette” ebraiche” da lui tanto disprezzate” – in realtà “non fu Benjamin a rischiare di far parte del Warburg, fu piuttosto Scholem che tentò ripetutamente quella via”. La ricostruzione di questa vicenda è possibile grazie al regesto dei documenti del Warburg Institute Archive. Impossibile seguire tutte le tracce che ne emergono: l’amicizia con Robert Eisler (sin dal 1920), che probabilmente è il primo a parlare di Scholem a Saxl e che, essendosi Scholem fin dal 1923 trasferito a Gerusalemme, tenne i contatti tra quest’ultimo e la direzione del Warburg; tanto che l’Autore afferma come “i primi anni della produzione scientifica di Scholem siano stati quasi interamente sotto il segno del Warburg (Alchimia e qabbalah del 1925 e altri). Il successivo viaggio di Scholem ad Amburgo, nel 1927, aveva lo scopo di ottenere “un sostegno finanziario” e, soprattutto, “un endorsement di carattere culturale”. Il Sefer ha-Bahir (il primo testo letterario cabalistico), argomento della tesi di dottorato di Scholem, poi, nel ms 214 della Jewish National Library di Gerusalemme, dove Scholem era bibliotecario, compare accanto alla traduzione ebraica del Picatrix, testo magico “che ha segnato profondamente la ricerca di Warburg e le vicende editoriali dell’Istituto”. È assai probabile, da quello che si ricava dai documenti, che il Sefer ha-Bahir dovesse essere pubblicato da Warburg. Se ciò non avvenne, nonostante gli sforzi di Scholem, Eisler e Hugo S. Bergman (direttore della Biblioteca), fu per la “fiera opposizione di Warburg nei confronti dell’ideologia sionista, incarnata in questo caso da Scholem”. Così aveva scritto al fratello Max, in seguito all’avvicinamento dei sionisti alla Gran Bretagna dopo la prima guerra mondiale, in una lettera del 16 maggio 1918: i sionisti non sono altro che “epigoni falliti, proprio come la civile Europa cristiana”, che “credono di poter costruire qualcosa di nuovo sulla base di una cultura specificamente ebraica”. In una lettera a Eisler del 7 agosto 1925, rincara la dose: dopo un giudizio sprezzante su Bergman, si dichiara intenzionato ad acquistare 30 copie del volume (ma alla fine saranno solo 5), ma di non aver alcuna intenzione di “finanziare i sionisti”. “Non si può dire – scrive in conclusione della vicenda l’Autore – che Warburg abbia boicottato la pubblicazione, ma certo a sua diffidenza verso l’ideologia sionista costrinse Scholem a pubblicare il libro a proprie spese”. Scholem, come detto, visiterà la Biblioteca di Warburg nell’ottobre del 1927 (senza poter incontrarne la mente a causa del viaggio in Italia). La descrizione positiva fattane da Saxl a Warburg non sembra averlo convinto a cambiare parere sul Nostro.
Solo dopo la morte di Warburg, tra l’ascesa del nazionalsocialismo e il trasferimento a Londra della biblioteca, avviene l’“unica autentica collaborazione tra Scholem e il Warburg” col progetto a cura di Edgar Wind e Hans Meier della Bibliografia sulla sopravvivenza dell’antico (edita nel 1934). Ma nel complesso, si tratta di soli sei articoli. La vicenda della recensione da parte di Martin Rasch sul “Völkisher Beobachter”, organo ufficiale del partito nazionalsocialista tedesco che dipingeva il Warburg come se fosse “sostanzialmente un’istituzione ebraica” e la successiva rettifica dovuta alle proteste di molti studiosi da lui nominati che affermavano “di non essere emigrati ed essere ariani”, avrebbe confermato Scholem, se ne fosse venuto a conoscenza, della sua opinione che il Warburg era una “setta ebraica che rifiutava di trarre le debite conseguenze dalla propria male accettata identità”.
Dopo una mancata collaborazione con l’importante “Journal”, l’organo dell’Istituto a partire dal 1937, e dopo un lungo periodo di silenzio, i rapporti ripresero con una “più distesa simpatia e cordialità” negli anni ’60: oltre ai suoi “rapporti assai amichevoli” con Frances Yates, fu consulente della traduzione tedesca del Picatrix, e soprattutto, trascorse un anno sabbatico, il 1961, presso l’Istituto. Ma, ciononostante, nessuna pubblicazione di Scholem venne mai edita col marchio del Warburg Institute (nemmeno l’articolo sul “corpo astrale”, di chiaro interesse warburghiano: Von der mystischen Gestalt der Gottheit, che fu pubblicato a Zurigo sotto l’egida della “setta” di Ascona del nume tutelare Carl Gustav Jung; Scholem aveva partecipato, con una serie di conferenze, agli incontri di Eranos).
L’Autore si chiede, alla fine del suo saggio, se nei rapporti tra Scholem e Warburg prevalgano “le differenze o le analogie”. Risponde che vi abbondano, sicuramente, come nel caso di Benjamin, le “occasioni mancate”. Quando voleva lui entrare nel circolo, ne fu escluso da Warburg e quando ce ne fu occasione, fu lui a preferire il circolo Eranos. Forse perché la “sofferenza di Warburg lo attraeva e lo respingeva ad un tempo perché era la sua”, risponde l’Autore. Prima ancora di aver visto il ritratto di Warburg, che tanto lo impressionò, pubblicato sulla biografia di Gombrich, e da lui a lungo studiato (ricordiamo gli interessi di Scholem per la fisiognomica), Scholem così aveva descritto all’amico corrispondente Werner Kraft: “Posso dirti che Warburg ha sofferto per un periodo di una grave forma di mania di persecuzione ed era un malinconico di prima grandezza”. Come del resto fu anche lui. Lo dimostrano due componimenti poetici: il primo, del 1933, all’ultimo verso di una quartina, recita: “Und wo einst Gott stand, steht Melancholie” [“e dove Dio fu ora sta Melancolia”]; il secondo, una poesia dedicata a Ingeborg Bachmann, è intriso di profondissima malinconia di un’intera quartina: “Così ci ha parlato lo spirito di utopia, / in cui si uniscono, nel buio, conforto e tristezza. / Al suo posto ci è rimasta la melancolia, / e tutto quel che resta del conforto è il pianto”. A causa della lunga età, a Scholem accadde di essere un “sopravvissuto”. “Con la morte dell’inafferrabile Warburg”, egli sperimentò probabilmente su di sé uno dei significati del termine warburghiano e benjaminiano Nachleben: “dover vivere ‘dopo’”.
Elena Filippi, Melancholia, stupor, philosophia: Dürer, la sua Melencolia e l’inizio del pensiero come arte.

2 | Albrecht Dürer, Autoritratto con pelliccia, olio su tavola, 1500, Monaco, Alte Pinakothek.
L’Autrice (di cui, nel 2018, uscirà un saggio per i tipi de il Mulino proprio dedicato al bulino düreriano), pur consapevole dell’“inesauribile lavoro ermeneutico” che sottende il “capolavoro düreriano”, intende sostenere la tesi del carattere “filosofico” dell’incisione. Infatti, per l’incisione dobbiamo parlare di una “filosofia in immagine”. In ciò l’artista di Norimberga non è stato il primo, essendo stato in un certo senso preceduto da Nikolaus von Kues, nell’opera De visione Dei del 1453, testo che Dürer conosceva. In un experimentum ad alcuni confratelli benedettini, Cusano utilizza un piccolo ritratto di Cristo per mostrare la sua onniveggenza. In questo, il dipinto, che “ricambiava lo sguardo degli osservatori, in quiete come pure in movimento, addirittura in direzioni opposte”, era più esplicito di tante parole. Il “logos umano è sempre prospettico nell’affermare questo o quello […] ma non simultaneamente due realtà che si escludono a vicenda; non è insomma omogeno al logos divino, perché non è adatto a sondarlo”.
Non in tutte le opere, però, un artista può utilizzare il “ragionare per immagini”, come ha fatto Cusano e come farà Dürer. Solo in alcune, e tra queste la Melencolia I. L’immagine della filosofia compare per la prima volta in Dürer in una xilografia commissionatagli per il frontespizio del compendio di Konrad Celtis, Quatuor Libri Amorum Secundum Quatuor Latera Germanie (Norimbergæ, 1502). In quest’opera emergono i primi tratti che caratterizzano le immagini filosofiche di Dürer: una “rigorosa centralità”, non solo sul piano “compositivo”, ma anche “ermeneutico”: “è a partire dal centro che l’opera va letta e compresa”. In secondo luogo tutte le immagini filosofiche hanno un “riferimento esplicito o implicito alla sua persona”, nel senso del suo “ruolo di artista e umanista”; ultimo punto, sono tutte caratterizzate da un “intento programmatico”. La filosofia conferma tutto ciò: il monogramma di Dürer è sull’asse centrale: l’artista “intende intraprendere il cammino delle scienze indicate dalle iniziali delle parole greche”, per giungere infine alla filosofia. Quali altre opere di Dürer presentano queste caratteristiche?
L’Autoritratto con pelliccia del 1500 (all’Alte Pinakothek di Monaco), che nella firma a sinistra e nella scritta programmatica a destra formano il transetto di una croce, “progetto umanistico e cristologico insieme” e, nel gesto della mano, esprime al contempo, in modo ambivalente, “il riferimento a sé e il gesto del Cristo benedicente”; la Nemesis (La grande Fortuna), del 1501-1502, in cui al centro della composizione sono le gambe ipertrofiche della figura nuda alata; per l’Autrice, la rappresentazione, in basso, dello scenario alpino di Chiusa/Klausen, “al limite fra i due mondi culturali” della Germania e dell’Italia, starebbe ad indicare il “luogo di tale competizione” fra arte nordica (“naturalistica” e attenta al dettaglio) e arte meridionale (astratto-sintetica). E allora come non vedere, mi permetto di aggiungere, che proprio al centro del paesaggio è collocato un piccolo ponte in legno, segno della volontà di Dürer di “collegare” quei due mondi? Un ruolo di primaria importanza spetta, sotto quest’ottica, alla Melencolia I. In essa, però, i caratteri di centralità sono “più difficili da riconoscere”. Ma l’Autrice, prima di dedicarsi all’esegesi dell’incisione più celebre di Dürer, individua nella cosiddetta Colonna dei contadini del 1525 il “punto di arrivo della filosofia düreriana per immagini”. Dürer vi inserisce un preciso riferimento ai “fatti di sangue di Frankenhausen”, con evidente “intento programmatico circa la funzione morale dell’arte”. Per l’Autrice in queste quattro opere Dürer sonda non una bensì “‘la’ domanda filosofica”: il “senso dell’essere nel mondo” dell’uomo “nel suo confronto col cosmo, con la cultura, con Dio”. Dunque, la Melencolia I. Innanzitutto essa è un enigma, dunque non un “rompicapo che un giorno potrà essere risolto”. Non un “rebus da decifrare”, ma un “enigma” dunque una “domanda che non è indirizzata a ricevere una risposta”. Come l’occhio alato di Alberti, aggiungo io, in cui l’enigmaticità è “al quadrato” grazie al motto: QVID TVM (E allora?). Tracciando le diagonali del foglio, il punto d’incrocio si trova subito sotto al “putto”, che occupa perciò “il posto d’onore nella composizione”. Egli, cosa che è sfuggita a quasi tutti gli esegeti, “tiene in mano la stessa tavoletta sulla quale Dürer è solito presentare il proprio monogramma. Il putto sta incidendo la tavoletta: rappresenta “Dürer stesso”, dunque l’arte. La sua funzione è “quella di figura in assistenza”, e si trova “al di fuori della malinconia”, sottratto ai suoi influssi. Ma perché Dürer in forma di putto? - si chiede l’Autrice. Perché quando aveva nemmeno un anno, lo si è già accennato prima, nel cielo tedesco era visibile una cometa. Dunque Dürer nasce sotto un segno palese: non sarà un uomo qualunque. Il rapporto tra cosmologia e anima era allora un nesso riconosciuto: non solo il già citato Cornelius Agrippa di Nettesheim, ma anche Cusano, Ficino, Pico, Bovillus, Reuchlin, Ulrich Pinder, per risalire allo stesso Cicerone (di recente, il legame con Agrippa, però, non gode molto più i favori della critica). Per l’Autrice, già tutti questi nomi di filosofi dovrebbero far propendere per un intento ‘filosofico’ dell’opera düreriana; inoltre il fatto che non si sia riusciti però a individuarne “la fonte par excellence” può far indirizzare verso un diverso sbocco ermeneutico: se, ventottenne, Dürer era in grado di dipingere un autoritratto in pelliccia nel solco di Cusano, perché quarantaduenne non poteva ‘filosofare in proprio’? Il primo punto, dunque, è stato fissato: Melencolia I rappresenta “la nascita dell’artista e con ciò il suo ingresso nel mondo, il ruolo che nel mondo gli spetterà”. Ma che cosa collega l’essere artista al pensiero filosofico?
Platone e Aristotele avevano visto nel thaumázein il principio stesso della filosofia. Ma, come scrive l’Autrice, “l’autentico thaumázein, che potremmo chiamare stupor […] lascia emergere come inquietante (e perciò degno di essere interrogato) proprio ciò che è solito e consueto: un indagare che si estende all’ente nella sua totalità. Ebbene, proprio questo è il senso di ciò che Dürer chiama ‘melencholia’. Nel finale l’Autrice, lasciando aperta la questione del significato del titolo – “‘Melencolia I’? ‘Melencolia paragrafo Uno’? ‘Melencolia i’ (“Vattene, malinconia” – propende, contro “la visione della filosofia sviluppata da Agrippa”, che vede la malinconia sottoposta a una dimensione astrale “che trascende il piano dell’umano e la conditio humana”, per l’interpretazione düreriana, proprio per una visione filosofica “il cui sforzo muove piuttosto proprio dalla condizione umana”. In questo l’incisione va letta nel contesto dei Meisterstiche: Il cavaliere, la morte e il diavolo, la Melencolia I e il San Girolamo nello studio (cui è da aggiungere, come prima tessera, l’Adamo ed Eva del 1504). Ma su questa lettura l’Autrice rimanda a un’altra sede.
Giovanni Maria Fara, Melencolia I di Albrecht Dürer nell’arte e nella letteratura italiana tra XVI e XVII secolo.
L’Autore affronta il tema della ricezione italiana dell’incisione. La prima traccia è in una lettera di Anton Francesco Doni, da Venezia, “l’ultimo giorno di agosto di un anno imprecisato” all’amico incisore Enea Vico da Parma, in cui l’incisione è inserita all’interno della collezione di stampe dell’autore. “da qui in avanti” – scrive Fara – la “presenza” delle incisioni di Dürer “segnerà il valore di una collezione”. Sarà invece il Vasari a dare per primo l’ecfrasi letteraria dell’incisione: “Si mise anco ad intagliare, per una carta d’un mezzo foglio, la Malinconia con tutti gl’instrumenti che riducono l’uomo e chiunche gl’adopera a essere malinconico”. Questa descrizione trova riscontro in testimonianze letterarie e artistiche che si rifanno alla cerchia vasariana (la Melanconia mai eseguita o perduta dello stesso Vasari in Palazzo Vecchio nel Terrazzo di Saturno; la Malinconia di Jacopo Zucchi dipinta nella volta dello Studiolo di Francesco I, con “motivi e attributi che derivano dal bulino düreriano”). Più ampie le citazioni in letteratura (anche se ancora in fase di “delimitazione”): il poemetto Il sogno di Alessandro Caravia (1541), oltre che nel testo – “Voi mi parete la Melancolia / Dipinta da buon maestro dipintore” – riproduce il caratter malinconico dell’autore nella xilografia del frontespizio, “chiaramente esemplificata sulla Melencolia di Dürer”. Dietro al “buon maestro dipintore”, l’autore ipotizza che, oltre a celarsi l’ovvio riferimento al Dürer, ci sia “un preciso riferimento alla sua attività di pittore […] di cui a quel tempo a Venezia, a differenza del resto d’Italia, si trovavano cospicue testimonianze, certo non ignote a un gioielliere e mercante come Caravia”.
Schlosser aveva riconosciuto nella personificazione della Scultura del trattato di Doni (Disegno) un rimando alla Melencolia düreriana. Se così è, come sembra a maggior ragione confermare la presenza dell’incisione nella collezione dell’autore, Fara vi aggiunge anche la vicinanza con la raffigurazione dell’Industria, più volte usata da Doni, xilografia che compare per la prima volta ne Le Sorti di Francesco Marcolini (Venezia 1540). La successiva stretta collaborazione tra il Doni e il Marcolini tra il 1552-1553 favorì il riuso dell’immagine. Ma altre allegorie marcoliniane “denunciano evidenti debiti con modelli iconografici düreriani”: la Maninconia e l’Occasione (quest’ultima derivante dalla Nemesis). Partendo dalla constatazione che “non esiste alcuna copia della Melencolia I sicuramente riconducibile ad un artista italiano, nonostante questo esercizio abbia costituito una pratica diffusa, un imponente fenomeno di traduzione e assimilazione del Dürer”, nella storia dell’arte successiva si assiste a “prestiti minimi”: il cane accucciato nel ritratto di Massimiliano Stampa dipinto da Sofonisba Anguissola nel 1557 (Baltimora, Walkers Art Gallery), ripreso in un disegno a penna e inchiostro marrone acquerellato di Leloo Orsu (Diana e Endimione, 1560 ca., Modena, Galleria Estense); un foglio di schizzi di Raffaello (Uffizi), con una figura femminile che appoggia il capo alla mano con un cane (oggi poco visibile), accucciato ai piedi, datato al 1514, basato su un sarcofago della collezioni Albani del Drago, “la cui memoria viene temperata e ammodernata” dalla conoscenza del bulino di Dürer (il che significa che la bottega di Raffaello recepisce in presa diretta la Melencolia I che è dello stesso anno). Dell’incisione se ne ricorderà anche Giulio Romano, che riprenderà la posa della figura femminile per la sua Psiche abbandonata da Amore nella camera di Psiche di Palazzo Te, circondandola in più di oggetti (scopetta, séssola e mastello), non citati da Apuleio e dunque anch’essi riconducibili al capolavoro düreriano.
Alice Barale, “Collectione et quasi compressione”: Warburg e Benjamin in dialogo con Panofsky e Saxl.
L’Autrice, intervenendo sulle vicende, “ancora piuttosto misteriose”, del mancato rapporto tra Benjamin e il Warburg-Kreis, si sofferma su una “critica, passata sino a ora inosservata” che Benjamin nel Dramma barocco tedesco sembra indirizzare a Panofsky e Saxl e che riguarda “il loro rapporto con quello che Benjamin definisce il loro “straordinario modello”: Karl Giehlow. Questo chiarirà anche come “la differenza […] dell’interpretazione warburghiana della malinconia rispetto a quella di Panofsky e Saxl non possa essere considerata sotto il segno di un maggiore ottimismo da parte di Warburg, ma rinvii al contrario a un elemento problematico, che Panofsky e Saxl sembrano respingere, e che è invece presente – come colgono sia Warburg sia Benjamin – già in Giehlow”. Si tratta dell’aspetto della “concentrazione”.
Benjamin nel Dramma cita un passo di Ficino – presente anche in Giehlow e in una serie di appunti del giovane Warburg – sul “nesso tra bile, terra e concentrazione”. Benjamin lo cita dal saggio di Panofsky-Saxl sulla Malinconia del 1923, passo che però gli autori mettono in nota senza dare a esso quel rilievo datogli da Giehlow (e da Warburg) e che, come capisce benissimo Benjamin, costituisce una chiara critica allo stesso Giehlow. La questione è dunque sulla diversa interpretazione del ruolo della pratica della “concentrazione spirituale” (per Panofsky-Saxl, Ficino non la consiglia affatto al malinconico).
Si conosce l’ammirazione di Warburg per Giehlow. Egli, nel 1915, qualche anno dopo la morte di quest’ultimo, si offre in aiuto alla pubblicazione del suo studio sulla malinconia (inedito, mentre il saggio sui geroglifici viene pubblicato proprio nello stesso anno). Dopo varie vicissitudini i materiali sono inviati a Saxl, cui si affianca Panofsky per curare l’edizione. Da qui in avanti la curatela diviene “una vera e propria rielaborazione”, anche se, per Barale, in “buona fede […] perché Panofsky e Saxl pensavano davvero che la ricerca di Giehlow, così com’era, non andasse più bene, e andasse sviluppata in un altro modo. Giehlow stesso, del resto, non era soddisfatto delle sue conclusioni”. Ma si è mai visto, aggiungo io, che i curatori correggano il testo di chi non può difendersi perché morto?
Warburg, intanto, dall’“esilio” di Kreuzlingen, pur riconoscendo “di grande valore” il saggio sulla malinconia di Panofsky, “si lamenta che poco è stato accolto […] della sua idea della “sublimazione” dell’antico demone Saturno”. Ed evidenzia la mancanza del tema della “zappa” di Faust: essa è sì uno “strumento di distruzione ma serve anche ad aprire la terra, per piantare i semi” (il “simbolo”, nella sua duplicità ineliminabile, secondo Warburg). L’altro polo è il becchino dell’Amleto (ma su questo si veda il saggio della Wedepohl).
Ma l’elemento di maggior distanza dell’interpretazione di Panofsky-Saxl da Warburg è la questione di chi vinca, alla fine, tra Saturno e Giove (quest’ultimo, per Warburg) e l’importanza del motivo della mensula Jovis (dai due autori ritenuto “certamente non il più importane”. Panofsky tiene presente la “trasformazione” di Saturno, ma non ne fa il centro della sua interpretazione. Perché? Si deve tornare a Warburg. Per lui il “potere di trasformare la figura di Saturno” spetta alla “coscienza”, o meglio a qualcosa che la accompagna: si tratta della già citata “concentrazione”. Come può questa costituire un rimedio contro la malinconia?
La malinconia, per Warburg, nasce dalla consapevolezza dell’uomo dei suoi limiti, del suo confine “fluttuante” con l’“estraneo” (tutto nasce con Adamo, per Warburg – negli appunti per la conferenza sul rituale del serpente – “nell’aver incorporato la mela, un corpo estraneo” e nell’essere costretto a utilizzare la zappa (la stessa zappa di Faust!) “per lavorare la terra”, sperimentando “un’estensione tragica della sua esistenza attarverso lo strumento, poiché quest’ultimo non fa parte del suo essere. La tragedia dell’uomo che mangia e che manipola è uno dei capitoli della tragedia dell’umanità”. In altre parole, del proprio essere materia inorganica, animalità. Qui il rimando al cane della Melencolia I è inevitabile. Giehlow, contra Panofsky che lo vedeva come “cane malandato”, lo aveva interpretato come un cane “che sta sognando sogni profetici” (e secondo Horapollo, negli Hieroglyphica, così studiati da Giehlow, il cane è associato alla milza, dunque alla malinconia. Ma come dimenticare, aggiungo io, il Canis di Alberti?). Qui è il punto essenziale: riuscire a “tenere insieme” “vertici del sapere e vita animale”. Solo il genio – di Dürer – è in grado di fare questo: tenere insieme “il sé e il non sé, il proprio e l’estraneo, la vita spirituale e animale, il significato e la materia. Un tenere insieme difficile, che non sopprime la tensione instabile tra queste forze […] e che ha un carattere di divinazione” (il cane profeta!). La divinazione è presente in Agrippa, ma è proprio quest’ultimo a costituire il pomo della discordia tra Giehlow e Panofsky-Saxl: Agrippa, per il primo, rappresenta il “portare nel mondo la dottrina di Ficino”, l’”applicarla a una conoscenza intensificata della realtà […] capace di penetrarla in ogni suo grado e di dischiuderne i segreti”. Ma è proprio sull’interpretazione dei geroglifici di Dürer (nell’incisione Il mistero dei caratteri antichi, xilografia per l’Arco di trionfo di Massimiliano I). Per Giehlow, i geroglifici del Cinquecento – a differenza di quelli del primo umanesimo che evidenziavano l’”espressione immediata e cristallina di un pensiero o di un’idea” (ma, contro: e l’occhio alato di Alberti, allora?), sono “follemente instabili” e ciò ne impedisce una patente esegesi.
Ma è questo della ricerca di Giehlow che interessava tanto a Warburg e a Benjamin: “è proprio nel momento in cui la speculazione si perde in se stessa […], che quest’ultima avverte la necessità di tornare a quella concentrazione da cui proviene e che nessun “grado” del proprio avanzamento può lasciarsi definitivamente alle spalle. Una concentrazione 'su di sé' che è anche […] concentrazione sul mondo: sullo spazio che il pensiero deve continuamente ri-aprire al proprio interno e a cui deve ri-aprirsi, per non perdersi, per ritrovare il proprio orientamento”.
PARTE SECONDA
Stefania Santoni, Melancholia al femminile.
Tra le tante fonti possibili della Melencolia I ve ne sono alcune che chiamano in causa “echi femminili provenienti dal mondo antico”: “il tema della tessitura” e il “celebre gestus malinchonicus che contraddistingue numerose eroine della classicità”. Per analizzare il primo punto, l’Autrice deve brevemente accennare alla teoria dei quattro temperamenti.
È “un’estensione della dottrina degli umori” causa, secondo i medici antichi, delle malattie dell’uomo. La teoria dei temperamenti, invece, fa riferimento a “qualità e inclinazioni che sono stabili nell’uomo”. Secondo questa dottrina, “alcune persone […] hanno un’inclinazione ad avere malattie specifiche: alcuni cadranno più facilmente in preda a mali legati alla collera, altri al flemma, altri ancora alla bile nera, e anche il loro profilo interiore e psicologico ne risulterà profondamente condizionato”.
Come dimostrano alcuni esempi portati dall’Autrice (Tractatus de quaternario, XI o XII sec., il primo calandario tedesco di Augsburg, 1480 ca., calendario tedesco di Strasburgo, 1500 e manoscritto di Zurigo), compaiono figure femminili intente a filare, raggomitolare, utilizzare la conocchia: a mostrare “che nel modulo iconografico del temperamento saturnino ritornano elementi appartenenti al mondo femminile". Ciò si riscontra anche nelle “rappresentazioni medievali di vizi e virtù”. In alcuni opuscoli illustrati, come ad esempio la Somme le Roi, si vede che l’Accidia è rappresentata nella forma del tipo malinconico. Inoltre, in una xilografia del Narrenschiff di Brant (1494), riguardante i vizi della Pigrizia e dell’Indolenza, accanto al seminatore (presente anche nella Somme le Roi alla voce Accidia) compare una filatrice “indicata come Acedia” (che sostituisce il “diligente seminatore” della Somme le Roi). E nell’editio princeps dell’Iconologia di Cesare Ripa (1593), ancora alla voce Accidia, si legge: “Donna a sedere, vestita di color negro, di panni stracciati et terrà ambe le mani alla cintola et il capo chino; havrà appresso un paio di forbice, con un pezzo di panno et un gomitolo di filo gettati per terra”. Visto il ricorrere così frequente di attributi femminili relativi al temperamento malinconico, l’Autrice deduce che “vi sia un legame fra femminilità e malinconia”.
Il secondo tema è quello della “testa reclina”. Attestazioni “del gestus melancholicus” si hanno fin dal V secolo a.C. in ceramiche e sculture greche, associate a Penelope, tessitrice topica (skyphos del 420 a.C. del museo archeologico di Chiusi), in cui la moglie di Ulisse medita con la mano appoggiata all’orecchio. “Come spiegare il motivo del gestus melancholicus o, per dirla in termini warburghiani, la Pathosformel della mano al volto?”, si domanda l’Autrice. Col fatto che, nell’antichità, “la memoria era associata ad una parte del corpo, più precisamente all’orecchio”. Teste Plinio il Vecchio, “quando si tocca l’orecchio, si chiama qualcuno a testimone” (Naturalis historia, XI, 251).
Il motivo della testa reclinata conosce subito una grande fortuna per ciò che concerne le figure femminili con l’aggiunta di uno specifico oggetto tenuto in grembo: Elettra l’urna del padre, Medea la spada ecc. Meditative sono Canace e Alcesti (entrambe pensano alla morte). La stessa testa reclinata retta dalla mano ha la musa Polimnia (e quando le muse prendono il posto delle nove sfere, non a caso, a lei spetterà Saturno…). Dunque, nell’antichità, “il gesto di riportare la mano al volto carico di un’altissima componente emotiva e drammatica, connota atteggiamenti di chiusura riflessiva e di colloquio interiore”. Inoltre, la “mano sull’orecchio […] ci ricorda che il malinconico è tormentato dal suo stesso sapere, “dalla sua troppo acuta sensibilità” (Monica Centanni)”. Ma qui sta il punto centrale: “è proprio grazie a questo disagio, a questa “sacra insoddisfazione” [G. Bing] che si garantisce una propensione alla ricerca continua, alla meditazione costante: dalla noia scaturisce la progettualità che porta il melanconico a percorrere nuove vie del sapere”. Negotium e otium convivono in coincidentia oppositorum: “la solerte filatrice e l’eroina meditabonda si incontrano e diventano retaggio al femminile della Melencolia I di Dürer”.
Laura Antonella Piras, Effigies Melancholiae: la poesia di Petrarca.
Se il Problemata XXX dello pseudo-Aristotele, per la prima volta, rivoluzionerà “profondamente il modo di vedere e di sentire la melanconia”, attribuendola all’uomo di genio, capace di conseguire i vertici più alti del pensiero, sarà solo con l’Umanesimo e con Marsilio Ficino che tali intuizioni giungeranno ad una forma più compiuta. Chi aiuterà questo processo, nel Medioevo, di passaggio da malattia a stato d’animo, sarà la poesia e Petrarca in primo luogo. Figura di transito, Petrarca ha in sé tutti i contrasti di un passaggio epocale tra Medioevo e Umanesimo. “Per la prima volta nella storia della letteratura italiana ed europea, – scrive l’Autore – la poesia si fa palcoscenico dell’anima del suo autore e si fa pura rappresentazione della melanconia, nelle sue più svariate declinazioni, tanto che lo storico Daniello Bartoli, nel 1600, indicò Petrarca quale autentico padre della melanconia italica”. La poesia di Petrarca appare come frutto di quel “furor divino che invasa i poeti, di quella melanconia considerata, in senso aristotelico e rinascimentale, come la sorgente della più alta esaltazione spirituale”. Petrarca la definì accidia, una “malattia” che lo perseguitò di giorno e di notte ma da cui trasse, al contempo, una “disperata voluttà”. In questo un ruolo “lenitivo” è svolto dalla filosofia, appresa da Cicerone, Seneca, Boezio e sant’Agostino. Il Secretum è il massimo esempio “di terapeutica morale”, volta a “liberare l’animo dai suoi tormenti”. Quale la causa di questa malattia? Petrarca la individua nel “sommarsi di diversi fattori”: la miseria humanæ conditionis, “la memoria degli affanni passati e il timore dei venturi”. Essa appare senza fondamenti veri, una “tristitia sine causa”, da cui sembra impossibile liberarsi. L’Autore parla, in termini psicoanalitici, per Petrarca, di un’”istanza bipolare”, “sempre in bilico tra abbattimento ed esaltazione”. Strettamente legata ad essa è una “voluttà”, in qualche modo “perversa”, che determina un “oscuro piacere nell’assistere alla vittoria della pulsione di morte sulla pulsione di vita”. Una voluptas dolendi che è un vero e proprio “peccato di hubris”. Un fenomeno di “narcisistica auto contemplazione”. Il rischio, per Petrarca, è credere che nemmeno la grazia possa far nulla per cambiare le cose. Ma qui soccorre l’aiuto di Agostino che indica come farmaci Cicerone e Seneca. Torna qui, ancora, la questione, già affrontata, della “concentrazione”: Petrarca “deve tornare in sé, restituire sé a se stesso”. Lui stesso lo promette alla fine del Secretum: “Sarò presente a me stesso quanto potrò raccoglierò gli sparsi frammenti dell’anima mia e dimorerò in me con attenzione”. Al centro della propria opera (Secretum, Epistole, Canzoniere) Petrarca mette il proprio io, la propria individualità. E questa, per la prima volta nella storia, è “contrassegnata dalla complessità, dalla conflittualità interna e da una profonda inquietudine psicologica e morale”. La stessa che anche Alberti scoprirà e che cercherà di far diventare una strutturata visione del mondo, sine ira et studio. Uno dei tratti più evidenti di quest’inquietudine petrarchesca, come ha ben individuato Loredana Chines, è la sua “incapacità di star fermo”. In ciò, viaggiare per Petrarca “significa anche indagare la natura più intima dell’uomo e conoscere se stessi”. Tanti sono i luoghi che rispecchiano la solitudine e la melanconia petrarchesa: Valchiusa, Selvapiana. I luoghi, con atteggiamento pre-romantico, rispecchiano gli stati d’animo, del poeta. Lento pede, il Poeta attraversa questi luoghi. È l’andatura tipica dell’eroe melanconico, come Bellerofonte, in cui Petrarca s’identifica, che percorre sentieri lontano da qualunque impronta umana. Ma proprio qui il poeta non trova pace, inseguito sempre dai suoi pensieri malinconici: “Ma pur sì aspre vie né sì selvagge / cercar non si ch’Amor non venga sempre / ragionando con meco, et io co’ lui” (Canzoniere, XXXV). Alla condizione del malinconico appartiene anche la consapevolezza della fuga temporis, motivo che spinge il Poeta a cercare a ricomporre e riordinare i fragmenta della sua opera. Petrarca esprime bene il rapporto del melanconico col tempo: intrappolato nel passato, “il melanconico non trova più lo spazio per progettarsi”. “Il tempo – chiosa sinteticamente l’Autore – è il più grande nemico del melanconico poiché consuma la bellezza delle cose terrene e porta con sé il presagio della morte e dell’annullamento”. Per l’Autore, la vera cifra della “patologia melanconica” di Petrarca è Laura. Per lei, il Poeta prova un “eros melanconico”, che è tutto il contrario dell’”amore vero”, che comporterebbe “reciprocità e presenza”. Petrarca utilizza Laura per “difendersi da un reale e possibile abbandono”. Si tratta di una realtà “fittizia”, dove “non esistono perdite reali, perché […] non si può perdere ciò che non si possiede realmente”. Quello del Poeta è “un amore basato sull’assenza, […] un amore […] che, per vivere, deve restare irreale ed irrealizzabile”. Se fosse stato realizzabile, e se dunque fosse nata “una relazione vera e profonda […] avrebbe decretato la fine del sentimento stesso e, probabilmente, avrebbe impedito la nascita della poesia”, essendo tutta l’opera poetica di Petrarca, un canto non all’amore, ma alla “voluptas dolendi dell’io”.
Felice Gambin, Riscritture malinconiche in Spagna tra Cinque e Seicento. Da Andrés Velásquez a Tomás de Murillo y Velarde.
L’Autore affronta il tema della trattazione della malinconia in ambito iberico, ricordandoci che, da tempo, è assodato che il primo libro interamente dedicato al tema in lingua non latina è il testo del medico spagnolo Andrés Velásquez, dal titolo Libro de la melancholia, stampato a Siviglia nel 1585. Nonostante ciò la critica continua a vedere nell’Inghilterra la patria dell’“umor nero”, attribuendo la primogenitura al testo di Timothie Bright, A Treatise of Melancholy (1586), anticipatore del più celebre Anatomy of Melancholy di Robert Burton (1621). Come dimostra anche la mostra Tiempos de melancolía (Madrid, 2015), la Spagna appare, ai mercanti, pellegrini e ambasciatori, una terra desolata, popolata “di gente malinconica”. Un precursore degli studi in terra spagnola fu Arturo Farinelli, anche se il suo lavoro sulla Malinconia non vide mai la luce. Probabilmente anche lui s’imbatté, forse senza rendersene ben conto, nel libro di Velásquez. L’autore, non un medico sconosciuto, in quanto negli ultimi anni della sua vita, fu il medico personale del duca di Medina Sidonia, “uno dei personaggi più ricchi e potenti dell’Impero spagnolo”, scrive il suo libro nell’epoca in cui frequentava, a livello professionale, i postriboli di Arcos de la Frontera. Scopo del lavoro, che sintetizza tutto lo “scibile elaborato sul tema dal mondo antico e rinascimentale”, è di essere utile “para la salud y bien público”. Il libro è una risposta al best seller del medico navarrino Juan Huarte de San Juan, Examen de ingenios para las ciencias, in cui l’autore individuava nei “malinconici adusti […] gli uomini più adatti alla predicazione”, che rimaneva “l’attività più importante dell’impero di Filippo II”. Contro tale riabilitazione, “si scaglia il volume di Velásquez”. Il profetare, tema che abbiamo già incontrato, del malinconico per lui “o è frutto del demonio o effetto del caso” e dietro “il caso clinico compare il peccatore”. “I malinconici – riassume così l’Autore il pensiero del Nostro – sono soltanto individui da curare, da disciplinare, e soprattutto, da confessare”. Si passa poi ad analizzare un’altra opera iberica sulla malinconia, scritta quasi un secolo dopo: Aprobación de ingenios, y curación de hipocóndricos, con observaciones y remedios muy particulares di Tomás de Murillo y Velarde. Figura non “marginale della medicina della seconda metà del Seicento”, fu medico nelle galere spagnole fino a quando Filippo IV lo nomina medico della famiglia reale e suo personale. L’opera di Murillo y Velarde è, come dimostra chiaramente l’Autore “un evidente plagio” del libro di Velásquez. Nonstante ciò, si chiede sempre l’Autore, vi è tra i due, a distanza di quasi un secolo, “una diversa presa di posizione sul rapporto tra anima e corpo, tra dimensione spirituale e dimensione corporea?”. Nonostante il “taglia e cuci”, nonostante il chiaro plagio, Murillo y Velarde considera il libro di Velásquez “un modello da superare”. Oltre a varie “aggiunte” e “digressioni” rispetto al testo di quest’ultimo, uno degli aspetti più nuovi è il fatto che la malinconia è un “umore che facilita l’intervento del diavolo”. Essa è “balneum diaboli”. “Nessuno spazio è concesso ad una malinconia ispirata: il malinconico non è il temperamento dell’ingegno e della perspicacia d’ingegno”. In questo, il libro di Murillo y Velarde, edito nel 1672, risente del nuovo clima che si respira in Spagna in quella decade, quando, dopo lo scetticismo iberico cinquecentesco nei confronti della stregoneria, si assiste a un’intensificazione dei processi di stregoneria. In altri capitoli, Murillo y Velarde non perde occasione di mostrare i cattivi costumi dell’epoca: il curarsi delle donne, il gioco a dadi e a carte, la passione per il teatro, per il cibo e per il sesso, contrapponendo a questo lo studio. Prese di mira sono, naturalmente, soprattutto le donne. Proprio queste ultime, sia vecchie che giovani, assalite dalla malinconia, cadono in “visioni millantate” del bambin Gesù e della Vergine. I tre capitoli finali del testo di Murillo y Velarde, del tutto autonomi dal testo di Velásquez, trattano della cura, in particolare delle donne, esposte più degli uomini alla malinconia. La sua farmacia è “fornitissima”: “piante e spezie, purganti, alteranti, refrigeranti, ricostituenti”. Ma il principale rimedio è la pietra bezoar (lapis bezoaris), da lui ritenuta, contrariamente all’opinione di molti altri medici del tempo, una vera panacea contro tutti i veleni, tra i quali appunto la malinconia e… la peste. Ma anche la china e il cioccolato possiedono virtù terapeutiche contro il male. L’ultimo capitolo, poi, equipara malinconia e sifilide, entrambe “malattie che angosciano e fanno paura”. La loro vicinanza è dovuta al fatto che i malinconici – come si legge anche nei Problemata XXX – “sono per natura particolarmente lussuriosi” (il medico veronese Gerolamo Fracascoro nel suo poema Syphilis, sive de morbo gallico, lega la malattia all’influenza nefasta di Saturno). Inoltre, si capisce che per Murillo y Velarde la malinconia non derivi solo da cause “fisiologiche “ o “teologiche”, ma che dipenda anche da “fattori sociali e morali”. Dunque, medico e confessore devono unirsi per sconfiggerla. Se molte cose non sono cambiate dal libro di Velásquez, una cosa si è aggiunta: la presenza della donna come soggetto della cura. Essa si trasforma nella “protagonista delle follie e dei peccati del mondo, a volte perché cade preda della malinconia, altre volte come strega, altre come finta santa o ancora come corpo che contagia, corpo pericoloso e che incute timore”. Ancora e sempre Eva.
Stefania Iurilli, La Melencolia I di Dürer. Dal quadro prospettico allo spazio tridimensionale.
Scopo del saggio dell’Autrice è ricostruire – procedendo a ritroso con la restituzione delle regole prospettiche – lo spazio tridimensionale dell’incisione düreriana, per procedere, in primo luogo, alla definizione di quello che resta una delle figure più enigmatiche, pur fra le tante, della Melencolia I: il poliedro. Dopo aver ricostruito la letteratura scientifica che ha indagato sulla natura del solido – un romboedro tronco? – e in particolare sulle sue dimensioni, l’Autrice arriva a sintetizzare così lo stato dell’arte: l’angolo acuto della faccia del poliedro, oscilla, nelle ipotesi formulate da cent’anni a questa parte, tra un valore di 72° a 83°. Si rende necessaria, perciò, una lettura che precisi definitivamente la misura dell’angolo. È ciò che fa l’autrice utilizzando gli strumenti della geometria descrittiva. Ma per far ciò occorre un rilievo “estremamente accurato del disegno”. Dopo la ricostruzione del tracciato prospettico, si è potuto verificare che la figura del poliedro è “costruita con assoluto rigore geometrico”, tranne un piccolo scostamento di 1,4 mm di due vertici dello spigolo in basso e più lontano dall’occhio (“piccolo, sebbene non del tutto trascurabile”). Delineata la figura sul foglio da disegno, tramite programmi di digitalizzazione è stato possibile procedere alla sua ricostruzione spaziale. Il risultato finale di tale ricostruzione tridimensionale ha confermato che trattasi di un romboedro tronco, come più volte ipotizzato, e non di un esaedro. Ecco alcuni “dati notevoli” che se ne possono ricavare: il solido presenta “sei facce congruenti a forma di pentagono irregolare, risultato del troncamento dei due vertici superiore ed inferiore”. Se si trascurano tali tagli, si tratta di facce con rombi regolari che presentano angoli acuti di circa 79,10°. Il che esclude che l’ipotizzato (da Peter Schreiber) angolo “aureo” di 72° sia da considerarsi plausibile. Dopo aver fornito altri dati sui rapporti della figura (soprattutto sul troncamento dei vertici dei rombi), l’Autrice s’interroga sul perché Dürer abbia inserito tale figura nella sua incisione: viste le sue conoscenze geometriche non poteva certo essere una figura casuale. Da un’ulteriore analisi della faccia del poliedro, si nota che il “rombo può essere inscritto, con buona approssimazione, in una coppia di rettangoli aurei”. Inoltre l’”altezza del troncamento si ottiene facilmente per via geometrica, tracciando la perpendicolare al lato partendo dal centro della figura”. “Si tratta – dunque, afferma l’Autrice – di uno schema estremamente semplice e regolare, basato su numeri ‘significativi’, in pieno spirito neoplatonico”. La differenza tra il poliedro ricostruito prospetticamente e quello costruito con i triangoli rettangoli “è pressoché impercettibile”. Dürer, perciò, avrebbe costruito il suo poliedro attraverso una costruzione geometrica piana, attraverso “riga e compasso” (come egli dichiara, al principio del quarto libro dell’Underweysung, siano disegnabili i solidi regolari).
L’analisi dell’incisione porta inoltre a prospettare l’ipotesi che Dürer abbia utilizzato un prospettografo di piccole dimensioni in vetro, posto a una distanza di circa due piedi di Norimberga (10,13 cm x 2 = 21,3 cm) dall’occhio dell’artista, distanza “assolutamente naturale in termini ‘ergonomici’, in quanto inferiore alla lunghezza di un braccio umano piegato nell’atto di disegnare”. Apparato ripreso dalle descrizioni di Alberti, di Filarete e fors’anche dal Trattato della Pittura di Leonardo da Vinci che Dürer ben conosceva. “Naturalmente, – conclude l’Autrice – in assenza di prove documentarie, l’ipotesi che la ricostruzione geometrica della Melencolia possa essersi avvalsa di un tale apparato non è che una possibilità, benché confortata da dati metrici certi”. Ciò che senz’altro colpisce, però, “è che quest’opera ancora riesca a fornire nuovi spunti di ricerca e dati inediti”, frutto di quei “‘segreti prospettici’” che l’autore andò ricercando e coltivando per tutta la sua vita.
Tommaso Ranfagni, “Sublimum daemonum receptaculum”. Proposta per un’iconografia dell’anima nella Melencolia I di Albrecht Dürer
L’Autore si sofferma nel suo saggio sulla creatura alata, assorta nella scrittura, seduta sulla macina a fianco dell’immagine della Melanconia. Panofsky l’aveva definita un “putto”, intrepretandola come la figura della Pratica, l’“attività senza pensiero”. L’Autore intende analizzarla, come la rappresentazione dell’"anima dell’uomo quando, nel desiderio di tornare al cielo, trova l’opposizione del corpo”. Non sarebbe dunque un’”invenzione originale” di Dürer, ma un’"originale elaborazione” di un dato conosciuto.
L’Autore fa partire la sua disamina criticando l’idea panofskyana che la figura sia un putto, dal momento che per putto s’intende di solito “un fanciullo, spesso nudo”. Esso appare perciò assai più un angelo. Ciò che sembra di poco conto porta con sé invece rilevanti conseguenze. Il putto spesso (Platone, Gorgia), rappresenta il “poco discernimento”; al contrario, l’angelo è una “potenza semidivina preposta al governo del mondo inferiore”. Dunque per l’Autore i collegamenti fatti con le due Melanconie di Lucas Cranach (Colmar e Edimburgo) appaiono fuorvianti, in quanto lì sì vi compaiono putti a simboleggiare “un’attività priva di intelligenza”.
Così come quella che Panofsky chiama una “lavagna” in realtà assomiglia perfettamente alla tavoletta con la firma di Dürer nel San Girolamo nello studio (lo ha notato anche Elena Filippi). L’Autore specifica che si tratta della tabula su cui gli antichi allievi romani scrivevano; così come fa l’angelo utilizzando una punta da incisore (qui d’accordo con Panofsky). Il gesto con cui l’angelo tiene in mano la tavoletta non è quello di nasconderla, ma semmai di “afferrarla saldamente” e così il fatto che la punta dello stilo sia spostata tutta a sinistra suggerisce all’Autore che “nel momento in cui lo osserviamo, egli abbia appena iniziato a scrivere” e che, dunque, “quella tabula vada considerata una tabula rasa”. La macina, invece, non lascia alcun margine alla sua identificazione, mentre il tappeto che in parte la ricopre costituisce un “dettaglio [il buon dio…] fino a ora mai considerato dai commentatori”, che ha un suo perché. La tabula rasa costituisce, per l’Autore, “il fulcro dell’iconografia”. Essa compare anche tra le braccia dell’angelo nella Madonna di Foligno di Raffaello, interpretata da Andreas Tönnesmann come “la rappresentazione figurativa dell’Intelletto”, la parte dell’anima immortale (confermato dal terzo libro del De anima di Aristotele in cui si paragona la mente umana a una tavoletta di cera, che “prima della conoscenza è vuota ma potenzialmente in grado di ricevere tutte le forme). “Ponendo la tabula rasa fra le mani dell’angelo Raffaello ne descrive dunque la sua aspirazione alla conoscenza, quando, una volta purgata dai sensi e distaccata dal corpo, si innalza verso l’ultimo grado della scala contemplativa, ossia la visione di Dio”.
L’ipotesi di Tönnesmann sembra confermata da una serie di altri ritrovamenti della tabula, reperiti ed elencati dall’Autore: sull’urna reliquario di San Clemente di manifattura bizantina (che ne prova l’antichità); sull’arcosolio del sepolcro di Francesco Castellani in Santa Croce a Firenze; all’interno del sepolcro del cardinale Oliviero Carafa, nella cappella Carafa nel Duomo di Napoli; pertinente come significato anche quella inserita nel fonte battesimale del Duomo di Pietrasanta. La tabula, come visto nel caso di Raffaello, è a volte accompagnata da una figura angelica, che ne accentua il carattere “ascensionale” (vedi il caso del sepolcro di Filippo Lippi nel Duomo di Spoleto, firmato da Filippino). All’angelo che porta in alto la tabula a volte fa da contraltare un elemento che tende a riportare in basso: è il caso del Prospetto della Libreria Piccolomini a Siena, in cui un vaso, simbolo del corpo, è “abbarbicato” a una base marmorea (e il nastro appeso al collo dell’angelo, per questo motivo, “si tira e si torce in conseguenza di quella trazione”). Nell’incisione düreriana tale compito è affidato alla macina. E qui torna la figura del tappeto. L’Autore così lo interpreta: “Costituendo un elemento di separazione tra la macina e l’angelo esso […] potrebbe rappresentare quel tegmen, ossia la copertura, che secondo Ficino separa l’anima dal corpo”.
Ma naturalmente il disegno di Dürer contiene anche delle differenze rispetto all’iconografia tradizionale qui ricordata. “Rispetto agli esempi appena esaminati, – scrive l’Autore – nella Melencolia I l’angelo non sembra voler compiere un’ascesa, anzi, al contrario, egli è immobile, del tutto assorto nel tracciar segni sulla tabula rasa”. Il suo atteggiamento contemplativo lo mette in rapporto stretto con la figura centrale della Malinconia. Secondo l’Autore, “intercettando la linea passante prospetticamente tra l’astro sul fondo, [Saturno] […] e la figura della Malinconia, l’angelo si pone di fatto come un filtro tra questi due estremi, così da presentare la figura in primo piano come il risultato dell’emanazione di quei raggi. Riconsiderando la relazione tra gli elementi dell’opera in questi termini, la tabula rasa potrebbe dunque rappresentare la parte più sublime dell’anima dell’uomo malinconico la quale, sottoposta agli influssi del pianeta Saturno ad essa propizio, ne riceve i benefici doni attraverso i di lui dèmoni, mentre la Malinconia, elemento finale di questa sequenza, si configurerebbe come una sorta di manifestazione sensibile di quell’effetto”. L’ipotesi sembra suffragata – “trova una certa compatibilità”, scrive l’Autore –, sia che si prenda come fonte l’Agrippa del De occulta philosophia, sia il De vita di Ficino.
Donato Verardi, Il diavolo e Saturno. Due note a margine di Melencolia I di Albrecht Dürer: Lutero ed Erasmo.
Le domande da cui parte l’Autore sono: “Che ruolo assegnare al diavolo nella vita degli uomini? Fino a che punto si estendono i suoi poteri e in che apporto essi sono con l’onnipotenza divina e la libertà degli individui?”. Com’è noto Dürer aderì alla Riforma luterana e desiderò di vedere Erasmo e Lutero accomunati da un medesimo progetto si rigenerazione della spiritualità cristiana. L’Autore si propone di mostrare “il differente rapporto malinconia-demonio” in Lutero ed Erasmo, “tentando di individuare quale delle due” sia più vicina all’incisione düreriana (essa fu realizzata prima dell’avvio della Riforma e prima della rottura tra i due pensatori). Le posizioni demonologiche di entrambi, del resto, non erano nuove, ma risalivano a una lunga tradizione cui avevano contribuito platonici agostiniani, aristotelici tomisti, mistici e teologi dalla più varia ispirazione.
Più volte Lutero si è incontrato col demonio. Si può dire che, per lui, egli “era più che un’idea astratta”: era, anzi, “il principe di questo mondo e della Storia”. Lungi dal credere che la Malinconia fosse frutto di squilibri umorali o d’influssi astrali, Lutero era assai più d’accordo con la visione del Malleus maleficarum di Spreger e Institoris (testo “tristemente noto” per il suo ruolo svolto nella caccia alle streghe). Oltre che esternamente, il diavolo colpiva interiormente: egli era infatti il dio della tristezza, dell’angoscia, che colpiva l’uomo solo: “Ogni tristezza, malattia e melanconia viene da Satana” e “la malinconia è un bagno pronto per il diavolo” sono due frasi prese dai Discorsi a tavola (quanto diversi dalle Intercenales albertiane!). Soggetto alle tentazioni e alle depressioni, Lutero ricorreva a dei “remedia”, come “risa, allegria, chiassosità, oscenità, disprezzo, insulti”. Qualcuno, ironizzando, ha scritto che Lutero passava più notti col diavolo che con la moglie Käthe: potendo tuttavia facilmente rimediare a tale tristitia, proprio giacendo a letto con lei.
Totalmente diversa la concezione demonologica di Erasmo: “Cristianesimo della luce”, lo definisce l’Autore. Già Panofsky aveva rintracciato le pagine dell’Enchiridion erasmiano come fonte d’ispirazione de Il cavaliere, la morte e il diavolo di Dürer. In cosa consiste la differenza tra Lutero ed Erasmo (che proprio la lettura dell’Enchiridion non sembrerebbe evidenziare)? In realtà, scrive l’Autore, si tratta di due “posizioni antitetiche, che sottendono anche differenti concezioni antropologiche e della grazia”. Se per Lutero “la malinconia e la tristezza erano debolezze tipiche dell’uomo, che favorivano l’ingresso del diavolo nella sua vita interiore”, per Erasmo “la tristezza era un sentimento successivo all’azione diabolica, che consisteva, però, nel peccato stesso che l’uomo compiva”. Dunque, “solo dopo aver peccato, non prima, si era afflitti dal tormento dell’animo”. Non era dunque “la malinconia ad attrarre o a favorire l’ingresso del diavolo nella coscienza dell’uomo”. Solo dopo subentrava quello stato d’animo. Questa concezione erasmiana, dunque, per l’Autore, è quella che ha ispirato la Melencolia I di Dürer (e non il Malleus maleficarum o Lutero). Infatti “solo limitando l’azione del diavolo nella vita della coscienza, sarebbe stato possibile […] attribuire a Saturno e non a Satana il ruolo di ‘signore della Malinconia’”.
Giacomo Mercuriali, Figura dell’inoperosità. La Melencolia I di Albrecht Dürer nel pensiero di Giorgio Agamben.
L’Autore indaga il ricorrere, periodicamente, nel corso degli ultimi quarant’anni, nella ricerca filosofica di Giorgio Agamben della Melencolia I di Dürer e dunque la sua importanza “nello sviluppo del concetto di inoperosità, uno dei pilastri fondamentali” del suo pensiero.
L’immagine della Melencolia appare sin dal primo libro di Agamben, L’uomo senza contenuto (1970). Qui l’Angelo düreriano viene contrapposto all’Angelus Novus di Benjamin come “angelo dell’arte”, il cui potere sarebbe quello di “salvare taluni oggetti dall’oblio e dall’indecifrabilità del “cumulo di rovine” storiche che l’angelo benjaminiano vede invece accumularsi dietro di sé, “a patto di garantirne la sopravvivenza come “citazioni” straniate”, simili a quegli oggetti che circondano la Melencolia düreriana. In altre parole, per Agamben l’arte possiede un “potenziale di estraneazione” (Agamben) che garantisce all’oggetto “una possibilità di sopravvivenza storica”, ma solo in quanto “perde la sua qualità di utilità pratica”. Questa possibilità di acquisire questo nuovo “statuto ontologico” è ben esemplificato, nel campo delle arti grafiche, dal “ready-made”, oggetto la cui “dimora nella sfera estetica è impossibile “tranne che per l’istante che dura l’effetto di estraneazione” [la citazione interna è da Agamben]”. Inoltre in questo libro sono già presenti alcune riflessioni, che saranno poi sviluppate nei testi successivi sul pensiero di Aristotele per quanto riguarda il tema dell’“inoperosità”, riguardanti le pagine del filosofo stagirita dedicate alle coppie: poiesis/praxis e dynamis/energeia.
La Melencolia ritorna in Stanze (1977). In questo testo, Agamben si occupa di vari temi legati all’incisione. Si sofferma sul concetto di acedia, recuperandone il significato che già il pensiero medievale, ben prima della riscoperta umanistica da parte di Ficino, dava a questa parola: per Tommaso d’Aquino la perversione dell’accidioso era quella di “una volontà che vuole l’oggetto, ma non la via che vi conduce” [Agamben]. L’acedia dunque ha in sé un aspetto paradossalmente “positivo”, comunicando “col suo oggetto – irraggiungibile – nella forma della negazione e della carenza” [Agamben]. La stessa cosa accade al desiderio amoroso (fin dal Problema XXX dello pseudo-Aristotele) durante l’età cortese e umanistica dal momento che esso appare come “un desiderio che vuole possedere e toccare ciò che dovrebbe essere solo oggetto di contemplazione […] un gesto che vuole abbracciare l’inafferrabile” [Agamben]. Così, trattando la teoria psicanalitica di Freud, Agamben considera la malinconia “la capacità fantasmatica di far apparire come perduto un oggetto inappropriabile” [Agamben]. Ciò presuppone l’esistenza di uno spiritus phantasticus.
In Infanzia e storia (1978), Agamben ritorna su queste riflessioni affermando in definitiva che “nella Stimmung melanconica sarebbe in gioco la capacità del soggetto di appropriarsi di un inappropriabile – Dio, donna o feticcio – attraverso il suo “fantasma””. In quest’ottica, Agamben propone di vedere nel “putto” non la “stolida Pratica” (come Panofsky e Saxl), bensì “lo Spiritus phantasticus stesso nell’atto di imprimere nella fantasia il fantasma” [Agamben]. La lettura dell’intera Melencolia I come “l’emblema del tentativo dell’uomo, al limite di un essenziale rischio psichico, di dar corpo ai propri fantasmi e di padroneggiare in una pratica artistica quel che non potrebbe altrimenti essere né afferrato né conosciuto” [Agamben], pone il filosofo sulla scia di Benjamin e Aby Warburg nel considerare il bulino “la rappresentazione della tensione tragica dell’uomo verso la conoscenza piuttosto che una meditazione ombrosa sui limiti intellettuali dell’artista rinascimentale”.
La Melencolia ritorna nel saggio Il corpo glorioso (in Nudità, 2009). Nel saggio si parla del destino dei corpi dei giusti una volta giunti in Paradiso. A cosa servono gli organi nutritivi e quelli sessuali? Origene, Gregorio Magno e Tommaso d’Aquino risolvono il paradosso separando l’organo dalla sua funzione fisiologica: queste, nel “corpo glorioso”, “non sono più eseguite ma solamente mostrate". Un caso, per Agamben, di “solidarietà” col concetto, a lui caro, d’“inoperosità”. La condizione degli organi dei beati è del tutto simile a quella degli oggetti che circondano Malinconia nell’incisione di Dürer. E, soprattutto, in questo modo “viene stabilito il collegamento esplicito fra l’angelo e la riflessione sull’inoperosità”. Gli organi sessuali, gli oggetti che Dürer ha sparso e anche i giocattoli abbandonati dai bambini dopo il gioco, indicano per il filosofo “una situazione di indecidibilità che le cose assumono una volta che abbandonano il loro originario sistema di referenza, prima di rientrare in uno nuovo”. Fin qui abbiamo stabilito dunque un punto fisso nell’analisi della Melencolia I da parte di Agamben: essa è figura di una “condizione contemplativa in cui l’uomo sospende la comprensione delle cose nel loro uso quotidiano e le pone nel modo di una disponibilità a un nuovo uso”. Questo implica un breve accenno al tentativo di Agamben di “fondare un’antropologia dell’(im)potenza”, con le ricadute che questa ha sulla teoria politica e su quella dell’arte. Agamben parte dall’analisi del concetto di potenza (dynamis) in Aristotele, che ne distingue due tipi: una, tipica del bambino, che prevede un accrescimento tramite l’apprendimento; l’altra che è propria di chi già possiede una tecnica e che riguarda una facoltà – la hexis, habitus in latino – “che si può mettere o non mettere in atto” (ad esempio un architetto ha sempre la “potenza” di costruire anche quando non costruisce). Aristotele esprime secondo Agamben questo concetto con una affermazione straordinaria della Fisica (193b 19-20): “La privazione, è come una forma”. Agamben sintetizza così: “ogni potenza umana è, cooriginariamente, impotenza; ogni poter-essere o poter-fare è, per l’uomo, costitutivamente in rapporto con la propria privazione” [Che cos’è l’atto di creazione, in Il fuoco e il racconto, 2014]. Altro punto. Aristotele, e con lui Agamben, si chiede se “esista un’opera specifica dell’uomo”. Lo stagirita propone dubitativamente che “l’uomo possa essere il vivente nato senz’opera e senza attività a lui propria”, ma lascia immediatamente cadere quest’ipotesi, mentre Agamben la fa sua: “l’umanità dell’uomo non si trova dal lato dell’energeia”, non sta dunque “nelle sue opere”, bensì “in quello della dynamis, della sua potenza, vista però dalla prospettiva essenziale della sua impotenza”. Ma quest’ultima non vuol dire affatto “inattività”, quanto “consapevolezza di poter scegliere di non esercitare la propria potenza”, arrivando così a una definizione della più volte citata “inoperosità”: “La potenza-di-non non è un’altra potenza accanto alla potenza-di: è la sua inoperosità, ciò che risulta dalla disattivazione dello schema potenza/atto. Vi è, cioè, un nesso essenziale fra potenza-di-non e inoperosità […]. La potenza-di-non, sospendendo il passaggio all’atto, rende inoperosa la potenza e la esibisce come tale” [Agamben]. Un grande esempio ne è Las Meninas di Velázquez. Politica e arte sono i due luoghi in cui Agamben esperimenta questa “potenza-di-non”, fino ad arrivare a sostenere quel paradosso secondo cui “l’artista ispirato è senz’opera”.
La figura più alta di questa antropologia dell’(im)potenza è rappresentata dal personaggio di Hermann Melville Bartleby, the scrivener (1853). “Figura della potenza perfetta” [Agamben], egli, assieme ai personaggi di Franz Kafka e Robert Walser, rappresenta appieno il concetto d’"inoperosità”. Per il capufficio di Bartleby e per Panofsky, invece, l’atteggiamento dello scrivano newyorkese e della “scrivana” düreriana, non sono altro che “Idleness” e “Untätigkeit”, cioè inazione.
Un “sorriso”, del resto, di là dall’espressione accigliata, par d’intravedere, se osserviamo da vicino, sul volto della Melencolia.
This article reviews the proceedings of the international conference of the 17th Week of Higher Renaissance Studies, held in the Sala dei Mesi of Palazzo Schifanoia in Ferrara on the occasion of the 500th anniversary of Albrecht Dürer's engraving of Melencolia I; a masterpiece that still leaves us with many questions about its meaning. In his speech, Marco Bertozzi immediately emphasises how the importance of Dürer's engraving lies precisely in its quality as a ‘Symbol’ that persists even after its enigma has been solved. For Cacciari, too, the figure of melancholy is allegory elevated to symbol. Claudia Wedephol analyses the differences between Warburg's interpretations of the burin in Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten (1920), based on Giehlow's study, and Panofsky-Saxl's essay Dürer's Melencolia I. While Saverio Campanini addresses the topic of the relationship between Scholem and Warburg and Elena Filippi argues the thesis of the ‘philosophical’ character of Dürer's engraving, speaking of a ‘philosophy of the image’. Giovanni Maria Fara in his speech addresses the topic of the Italian reception of engraving. First citing the literary ecphrasis of Vasari's engraving, then finding other artistic-literary testimonies. Alice Barale dwells on a criticism that Benjamin in German Baroque Drama seems to address to Panofsky and Saxl, which concerns their relationship with Karl Giehlow, arguing how Warburg's interpretation differs from Saxl-Panofsky’s. Stefania Santoni, on the other hand, recalls feminine themes such as the weaving theme and the famous gestus malinchonicus among the sources of Melencolia , going so far as to support a link between femininity and melancholy, given the frequent use of female attributes relating to the melancholic temperament . Laura Antonella Piras discusses the figure and work of Petrarch (in the sense of Accidia), arguing how it was fundamental in the process of passing on the concept of Melancholia. Felice Gambin, on the other hand, discusses the first book entirely dedicated to the subject in non-Latin: ‘Libro de la melancholia ’ (1585). Stefania Iurilli attempts to reconstruct the three-dimensional space of Dürer's engraving through rules of perspective, starting with the definition of the polyhedron. Tommaso Ranfagni dwells in his essay on the winged creature, absorbed in writing alongside the image of Melancholia. Donato Verardi sets out to show ‘the different melancholy-demon relationship’ in Luther and Erasmus, looking for the closest of the two to the Dürer engraving, and Giacomo Mercuriali investigates the frequent recurrence in Agamben's work of the Melancholy I.
keywords | Dürer; Melancholy; Cacciari; Wind; Bertozzi; Schifanoia.
Per citare questo articolo: Il 'sorriso' di Melencolia? A proposito di un volume dedicato ai 500 anni del celebre bulino di Albrecht Dürer, a cura di A.G. Cassani, “La Rivista di Engramma” n. 149, settembre 2017, pp. 73-103 | PDF