Devant le temps. Etica della responsabilità e scrittura della storia
Recensione a: Georges Didi-Huberman, Storia dell’arte e anacronismo delle immagini, tr. it., Bollati Boringhieri, Torino 2007
Giuseppe Cengiarotti
I
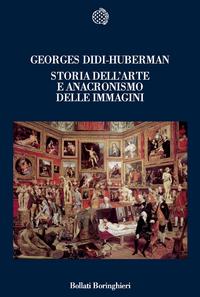
Pare utile seguire le indicazioni contenute in questo volume per allargare lo sguardo sul “bord de la falaise” in cui versa la disciplina storica, svolgendo qualche riflessione intorno ad alcune delle prospettive offerte da questo storico dell’arte di cui è stato recentemente tradotto in italiano anche l’importante studio su Aby Warburg (Didi-Huberman 2006). La sua ampia ricerca, che si è condensata in una produzione assai rilevante e cospicua, lo ha posto prima davanti all’immagine (Devant l’image, 1990) e poi davanti al tempo (Devant le temps) e possiamo notare come l’espressione “l’image survivante” che dà il titolo al volume su Warburg in effetti congiunga queste due modalità della spazialità e della temporalità.
Nel seguire dunque alcuni dei percorsi che hanno condotto alle attuali discussioni sullo statuto della disciplina storica – recentemente presentate anche da Giuseppe Ricuperati (2005) – prendo spunto, in particolare, dalla Ouverture del presente volume, in cui vengono discussi criticamente e dettagliatamente gli orientamenti prevalenti negli studi storici recenti per auspicare e sollecitare una nuova modalità di approccio alla fonte, dialogando con autori che hanno fornito una nuova prospettiva, tuttora poco seguita, specie dalla storiografia francese, compresa quella delle Annales (sul recente dibattito relativo al metodo della ricostruzione storica si vedano in questa stessa rivista il contributo di Daniele Pisani, in “Engramma” n. 55, e le recensioni di Giuseppe Cengiarotti, Fabrizio Lollini e Daniele Pisani, in “Engramma” n. 52). Mi limiterò pertanto qui ad isolare solo alcuni blocchi tematici inerenti agli studi storici, a scapito delle parti del volume dedicate più specificamente alla storia dell’arte.
Nel saggio di apertura, dedicato alla “storia dell’arte come disciplina anacronistica”, la questione viene affrontata allargando lo sguardo dalla disciplina della storia dell’arte in senso specifico alla storia generale (ricordo che la struttura del volume è scandita in due tempi: “Archeologia dell’anacronismo” che viene raffigurata ne “l’immagine-matrice” e ne “l’immagine-malizia”, e poi “Modernità dell’anacronismo” con “l’immagine-lotta” e “l’immagine-aura”). Vengono chiamate in causa personalità diverse, da Benedetto Croce a Raymond Aron, da Henri-Irénée Marrou a Paul Veyne a Chaïm Perelman, per cercare tra le pieghe della teoria e della storia della storiografia. L’approccio consente di estendere gli esiti della ricerca, in particolare, al lavoro degli studiosi di storia intellettuale, essendo l’analisi centrata sulla riflessione sviluppatasi ai primi del Novecento intorno alle diverse modalità della temporalità in rapporto all’immagine. I prodromi di un tale ri-orientamento vengono ravvisati nella Germania e nella Vienna di inizio secolo, per venire tuttavia rigettati subito dopo, e trovano uno dei suoi vertici nella figura di Aby Warburg, posta accanto a quella di Walter Benjamin, cui viene dedicata una sezione importante del volume. Non è dunque per caso che una figura come quella di Aby Warburg è stata sostanzialmente ignorata in Francia. Le cose stanno diversamente in Italia, ma qui occorrerebbe aprire un capitolo ulteriore.
La questione viene dunque affrontata alla luce del “pensiero dell’anacronismo” in una prospettiva dialettica, quale è stata formulata da questi “pensatori tedeschi non accademici”: “la nozione di anacronismo sarà dunque qui esaminata, messa in opera, per la sua virtù – spero – dialettica” scrive Didi-Huberman (2007, p. 27). Tale prospettiva, a sua volta, implica quella del montage, dunque una stratificazione di tempi diversi che coesistono, per venire a configurarsi come sintomi, ossia come elementi rivelatori capaci di smontare le diverse dimensioni del temps, i suoi ritmi eterogenei. Da qui deriva l’esigenza di criticare, proprio attraverso l’anacronismo, una concezione determinata e a giudizio dell’autore ancora prevalente della storia. Nella presentazione viene fatto dunque il punto sugli studi storici in Francia muovendo da una “Journée de discussion interdisciplinaire”, svolta nel 1992 e dedicata al “Temps des disciplines”, alla quale prese parte anche Jacques Le Goff, il quale, pur riconoscendo in quell’occasione l’accettazione della “multiplicité des temps”, ammetteva la tendenza degli storici a ostinarsi nel voler “unifier le temps”. Appoggiandosi ad alcuni interventi di studiosi quali Jacques Rancière, Nicole Loraux, ma anche psicanalisti come Octave Mannoni (cfr. Le Goff, Nora 1974; Chartier 1998; Rancière 1996; Loraux 1993; Mannoni [1963] 1969), Didi-Huberman perviene alla constatazione che l’anacronismo costituisce la part maudite del mestiere di storico. A suo giudizio Jacques Le Goff, ma con lui gli storici in genere, sostanzialmente rifiuta di confrontarsi con coloro che per primi non hanno esitato a far uso dell’anacronismo, ovvero in primo luogo Nietzsche e Freud. Esso era stato tuttavia problematizzato già molto prima e proprio dai padri riconosciuti delle Annales, segnatamente Lucien Febvre e lo stesso Marc Bloch (v. Didi-Huberman 2007, p. 32). Per quanto concerne Lucien Febvre, citando Le probleme de l’incroyance, Didi-Huberman osserva che: “se ‘ogni età si fabbrica mentalmente il suo universo’, come potrebbe lo storico uscire del tutto dal suo ‘universo mentale’ e pensare solo con gli ‘strumenti’ di epoche passate? La stessa scelta di un oggetto di studio storico – il problema dell’incredulità, l’opera di Rabelais – non è indizio dell’universo mentale cui appartiene lo storico?”. Da parte sua, Marc Bloch dedicava alcune pagine importanti sullo statuto della disciplina storica già nel 1941-1942, pagine ispirate ad un “doute méthodique”, in vista dell’acquisizione di una “méthode critique”, e – nota Didi-Huberman – oggetto di tale dubbio è “il passato stesso, in quanto oggetto principale della scienza storica” (Didi-Huberman 2007, p. 35; il riferimento è a Bloch 1993). Vale la pena soffermarsi sui giudizi relativi a Bloch, perché è proprio da qui che emerge tutto il senso della prospettiva offerta in questo volume. Nella Apologie dunque si legge:
Talvolta si è detto: “La storia è la scienza del passato”. A mio avviso, ciò significa esprimersi impropriamente. Perché anzitutto, l’idea stessa che il passato in quanto tale possa essere oggetto di scienza è assurda. Di fenomeni che non hanno altro carattere comune se non quello di non essere stati contemporanei, come se ne farebbe l’oggetto d’una conoscenza razionale senza preliminare decantazione?
Se è vero che gli storici ammettono che l’oggetto storico è il frutto di una costruzione razionale e che la soggettività svolge la sua parte nella costruzione dell’oggetto passato, meno agevolmente – constata Didi-Huberman – si ammette che “il passato stesso perda la sua stabilità di parametro temporale, e soprattutto di ‘elemento naturale’ in cui si muovono le scienze storiche.” Da questo derivano due conseguenze di rilievo: 1) che non è propriamente il passato l’oggetto della disciplina storica e 2) che non è propriamente una scienza quella che lo storico pratica. Più esattamente, la storia non può essere scienza del passato in quanto il passato non esiste in quanto tale, ma solo mediante la “decantazione” (Bloch). Ciò che “fait l’histoire” è dunque solo il “passato umano”.
In questa prospettiva, ossia alla luce di una siffatta problematizzazione nel collocarsi “devant le temps”, si presenta un’analogia con il porsi “devant l’image” (cfr. Didi-Huberman 1990) se è vero che la problematica dell’immagine va intesa come “concept opératoire” e non come mero supporto iconografico, presupponendo “un pensiero della psiche che implichi il sintomo e l’inconscio” unito ad “un pensiero del tempo che implichi la differenza e la ripetizione, il sintomo e l’anacronismo” ovvero una “critica della storia come sottomissione unilaterale al tempo cronologico” (pp. 49-50).
Ebbene, un tale approccio alla temporalità conduce Didi-Huberman a tracciare, alla luce del filo conduttore dell’anacronismo, una sorta di ‘montaggio’ del tempo, un diverso regime della temporalità, e dunque il contrasto di storia e memoria: “Questo tempo che non è propriamente il passato ha un nome: è la memoria”. E ancora: “La memoria è psichica nel suo processo, anacronistica nei suoi effetti di montaggio, di ricostruzione o di ‘decantazione’ del tempo. Non si può accogliere la dimensione rammemorativa della storia senza accettare al tempo stesso il suo ancoraggio nell’inconscio e nella sua dimensione anacronistica”. È allora per questa via, che intreccia tempi diversi, psichici e a-cronici nella memoria, che l’oggetto del sapere storico viene a configurarsi in quanto “sintomo”. Un “oggetto dialettico”, sorta di inconscio della storia. Il presente lavoro costituisce forse solo un’esplorazione di questa ipotesi attraverso esempi scelti nel campo – così vasto – delle immagini visive. Occorrerà dunque interrogarsi ancora su ciò che vuol dire, su ciò che implica la parola “sintomo”. Parola difficile da circoscrivere: non designa una cosa isolata, e neppure un processo riducibile a uno o due vettori o a un numero preciso di componenti.
Cos’ è allora un sintomo? È una complessità di secondo grado. E’ diversa da un concetto semiologico o clinico, benché implichi una certa cognizione dell’emergere (fenomenico) del senso e della pregnanza (strutturale) della disfunzionalità. Questa concezione denota come minimo un duplice paradosso, visivo e temporale, che interessa – lo si vedrà – il nostro campo di indagine sulle immagini e sul tempo: “Occorre comprendere che in ogni oggetto storico tutti i tempi si incontrano, entrano in collisione oppure si fondono plasticamente, si biforcano o si combinano gli uni con gli altri” (Didi-Huberman 2007, pp. 41 e 45).
Nella prospettiva adottata un sintomo – pertanto – non è altro che “la strana congiunzione di queste due durate eterogenee” della differenza e della ripetizione: "une formation de symptôme, c'est en quelque sorte une survivance qui prend corps" (Didi-Huberman 2002, p. 309). Come l’autore ha avuto modo di precisare, “il concetto di sopravvivenza è ideato sin dall’inizio. E’ Hot problem dice Warburg. Quindi la sopravvivenza è il principio stesso del sintomo. […] E la mia ipotesi è che Freud utilizzi la parola sintomo non nell'accezione medica comune. E' un punto che mi vede per esempio in disaccordo con Carlo Ginzburg che fra l'altro ha scritto un bellissimo saggio su Warburg” (Didi-Huberman in “La Repubblica”, 18 agosto 2002). La questione – cruciale, benché mai adeguatamente affrontata – del rapporto tra disciplina storica, filosofia e psicoanalisi si è sinora risolta in un incontro mancato, se – come nota l’autore – gli storici non hanno inteso finora acquisire una seria “teoria dello psichico” – a parte “l’exception notoire” di Michel de Certeau – preferendo di norma attenersi, casomai, a modelli di ispirazione sostanzialmente ancora positivistica. Didi-Huberman dichiara apertamente il proprio debito nei confronti di de Certeau, considerato come una feconda eccezione all’interno della tradizione storiografica francese. Riprendendo l’esigenza posta da Michel Foucault di una “mutazione epistemologica” della disciplina storica (“Attualmente questo mutamento epistemologico della storia non è ancora concluso. Tuttavia non data da ieri”), auspica inoltre – e questo è un assunto di fondo del suo lavoro – per la storia in generale (e per la storia dell’arte in particolare) quel che è avvenuto per la psicoanalisi, la quale “ha dovuto ridefinire la propria mutazione epistemologica a partire da una rilettura, da un ‘ritorno a Freud’” (Didi-Huberman 2007, pp. 29 e 50).
La storia della cultura si viene in tal modo a configurare, in questa prospettiva, come “fatto psichico totale”, che non può prescindere dagli effetti derivanti dal decentramento del soggetto, la freudiana Ichspaltung. Vale la pena di riportare per intero la seguente affermazione programmatica di Jacques Derrida: "Je veux parler de l'Impression laissée par Freud, par l'événement qui porte ce nom de famille, l'impression quasiment inoubliable et irrécusable, indéniable (même et surtout par ceux qui la dénient) que Sigmund Freud aura faite sur quiconque, après lui, parle de lui ou lui parle, et doit donc, l'acceptant ou non, le sachant ou non, se laisser ainsi marquer: dans sa culture, dans sa discipline, quelle qu'elle soit, en particulier la philosophie, la médecine, la psychiatrie, et plus précisément ici, puisque nous devons parler de mémoire et d'archive, l'histoire des textes et des discours, l'histoire politique, l'histoire du droit, l'histoire des idées ou de la culture, l'histoire de la religion et la religion elle-même, l'histoire des institutions et des sciences, en particulier l'histoire de ce projet institutionnel et scientifique qui s'appelle la psychanalyse. Sans parler de l'histoire de l'histoire, l'histoire de l'historiographie. Dans quelque discipline que ce soit, on ne peut plus, on ne devrait plus pouvoir, donc on n'a plus le droit ni le moyens de prétendre parler de cela sans avoir d'avance été marqué, d'une façon ou d'une autre, par cette impression freudienne. Il est impossible et illégitime de le faire sans avoir intégré, bien ou mal, de façon conséquente ou non, en la reconnaissant ou en la déniant, ce qui s'appelle ici l'impression freudienne. Si on a l'impression de pouvoir n'en pas tenir compte, en oubliant, en effaçant, en raturant ou en y objectant, on a déjà confirmé, on pourrait dire même contresigné (donc archivé) quelque "refoulement" ou quelque "répression" (Derrida 1995, pp. 53-54). D’altro canto de Certeau, connettendo la scrittura della storia all’inevitabile dimensione di finzione propria della verità – la quale è fatta dipendere dalla struttura del linguaggio e dalla insanabile frattura tra parole e cose – la configura come elemento costitutivo della soggettività in relazione al “reale”:
Per restituire la sua legittimità alla finzione che affolla come uno spettro le stanze della storiografia, è necessario anzitutto ‘riconoscere’ nel discorso legittimato come ‘scientifico’ quel rimosso che ha assunto la forma della ‘letteratura’. Le astuzie che il discorso trama nei confronti del potere nel tentativo di poterlo utilizzare senza esserne schiavo, le apparizioni dell’oggetto come attore fantastico nel luogo stesso del ‘soggetto del sapere’, le ripetizioni e i ritorni di un tempo che si suppone passato, gli occultamenti della passione sotto la maschera della ragione e via di seguito: tutto questo appartiene alla finzione nel senso ‘letterario’ del termine. La finzione non è tuttavia estranea al reale. Al contrario – e Jeremy Bentham lo notava già nel XVIII secolo -, il discorso fictitious è più vicino al reale di quanto non lo sia il cosiddetto discorso ‘oggettivo’. Ma è un’altra la logica che qui si trova in gioco, e non è quella delle scienze positive. Una logica che ha cominciato a fare la sua ricomparsa con Freud, e la cui delucidazione dovrebbe essere uno dei compiti della storiografia. Sotto questo primo aspetto, la finzione è riconoscibile là dove non si dia un luogo puro e univoco, vale a dire là dove si insinua l’altro. E il ruolo così importante della retorica all’interno del campo storiografico è un sintomo evidente di questa logica diversa. (De Certeau 2006, p. 75)
Lo storico consapevole di compiere una pratica all’interno di questo campo può dar luogo ad un’etica della responsabilità? Ovvero le derive che conducono al negazionismo sono l’inevitabile conseguenza di tali assunti rispetto ai quali occorre erigere una barriera? Detto in altri termini, è possibile un’etica della responsabilità assumendo il carattere scisso del soggetto e di una verità che si può dire solo a metà? “La storia in quanto scienza è incapace di confutare sino in fondo l’ambivalenza del suo stesso nome, che suppone tanto la trama delle finzioni (raccontare storie) quanto la conoscenza degli avvenimenti (fare storia)”. Se qui il riferimento è a Barthes, va detto che de Certeau, che pure assume il “discorso” come campo della storia, per altri versi se ne differenzia, come appare da un recente volume di François Dosse (2007): fare i conti con tutto questo significa accettare che la storia non può limitarsi a “fornire delle cronologie”, per configurarsi auspicabilmente come “montaggio” ossia “contraddanza delle cronologie e degli anacronismi”. Del resto – ribadisce Didi-Huberman – “non se ne esce meglio neppure quando si nega la storia in quanto tale: quando la si decreta ‘finita’ o quando si pretende di ‘farla finita’ con essa. I dibattiti attuali sulla ‘fine della storia’ e, in parallelo, sulla ‘fine dell’arte’ sono grossolani, mal posti, perché fondati su modelli di tempo rozzi, non dialettici”. Al riguardo Michel De Certeau dichiarava che “se la narrazione dei fatti si presenta come una ‘finzione’ propria di un certo tipo di discorso, non possiamo tuttavia concluderne che sia stato cancellato il riferimento al reale. Si tratta piuttosto di uno spostamento. Tale riferimento non viene più dato immediatamente dagli oggetti narrati o ‘ricostituiti’. E’ contenuto nella creazione di ‘modelli’ (destinati a rendere pensabili gli oggetti) adeguati a pratiche” (De Certeau 2004, p. 53; Didi-Huberman 2007, pp. 24-25 e 40). E in Storia e struttura puntualizzava:
Io ‘faccio storia’ non soltanto nel senso che produco testi storiografici, ma anche nel senso che ho accesso, attraverso il mio lavoro, alla consapevolezza che qualcosa c’è stato e oggi è morto e inaccessibile come realtà vivente. La struttura difende ed esprime questa acquisizione dell’esperienza storica. Essa rivela che c’è stato qualcos’altro. All’inizio, una scelta seleziona come ‘documenti’ – nelle biblioteche e nei musei – alcuni fra gli elementi che sono rimasti imprigionati nella rete di un presente. Lo storico parte da un certo numero di elementi che fanno parte della sua attualità, e il suo lavoro dà vita a un ‘passato’ nella misura in cui incontra, in una forma o nell’altra, la resistenza di ciò che non è più. (De Certeau 2004, p. 55; id. 2006, pp. 169-170)
A proposito del rapporto tra storia e struttura – caro a de Certeau come a Carlo Ginzburg – scriveva Arnaldo Momigliano:
There is no hope that structuralism will save us from the predicament of historicism. Structuralism has sharply reminded us that synchronic understanding is even more necessary than diachronic history-writing and has its own presuppositions and rules. […] Looking more carefully, one might even discover that most of the important books of cultural and social history of the last 120 years (from Fustel de Coulanges to J. Huizinga and M. Bloch) are more synchronic that diachronic. […] Structuralism certainly reveals deeper and more permanent elements of our human nature. It has taught us to seek new relations between diachronic and synchronic sets of events. But the reality of change, which is the reality of death, cannot be wiped out. In the future we may as historians have to study long-term changes which are for the moment hardly conceivable. But I cannot foretaste history ever becoming a science of the permanent. (Momigliano 1984, p. 27)
Ciò in quanto “every historian is a collector of facts of the human past. Collecting these facts is so important that is pursued by specific institutions, such as museums, archives, and archeological expeditions” e tuttavia queste istituzioni sussistono solo in quanto parte di un altro aspetto della ricerca storica che è la “selection of the evidence and explanation and evaluation of the facts emerging from the selected evidence”. Il punto è che benché lo storicismo implichi “a danger of relativism” e che “history-writing implies that we choose our facts according to certain criteria – or we try to discover new facts according to certain interests – these criteria and interests already imply a choice of universals or generalizations according to which we want to classify and understand the facts”. Rigettando l’idea che lo storico classifichi i fatti secondo modalità retoriche, perché la retorica “does not pose questions of truth” e non “entail techniques for the research of truth”, Momigliano asserisce che non siamo in grado di comprendere e valutare i fatti “unless we relate them to general categories and values” e non saremmo in grado di scegliere o scoprire i fatti senza aver già in mente dei valori o categorie generali cui riferirli.
II
In un recente volume, che si richiama nel titolo proprio all’Apologia di Bloch, anche Giuseppe Ricuperati ha notato che già Fernand Braudel, e poi soprattutto Jacques Le Goff, si erano distanziati dall’impostazione originaria delle Annales (cfr. Ricuperati 2005, p. 116); progressivamente, “la percezione di essere ‘au bord de la falaise’ … ha portato a privilegiare un terreno che ha molto a che fare con la memoria”. In questo senso ”de Certeau, già presente nelle raccolte di Le Goff e autore di un libro di riferimento come L’écriture de l’histoire, ha insegnato a una nuova generazione di storici ad approfondire il rapporto con le pratiche”. Scrive ancora Ricuperati: “Non a caso nella ricchissima voce Storia, che apre Storia e memoria, non manca una traccia del confronto con Metahistory” (Ricuperati 2005, p. 117; in proposito, si vedano le insistite notazioni di Momigliano 1984). Nel terzo capitolo, intitolato “Mnemosyne” e “anàmnesis”: discipline della memoria e conoscenza storica tra passato e futuro, che “interroga la crisi della storia, le sue possibilità di risanamento e rafforzamento conoscitivo alla luce di un nodo problematico particolarmente rivelatore, il rapporto-distanza con la memoria” Ricuperati pone con forza la questione dei rapporti tra le arti della memoria e avvento della modernità (Ricuperati 2005, pp. VI e 127; ma si veda anche Braudel 1973). Esso, al fine di evidenziare i grovigli in cui si trova oggi invischiata Clio, si apre con un suggestivo “viaggio semantico” che visita voci quali “mnème” e “Mnemosyne”, “Lethe”, “recordari”, “Zakhor”, per poi far riaffiorare i dibattiti degli anni Settanta a partire proprio da Storia e memoria di Jacques Le Goff, in cui era ormai segnato un percorso che allontanava le Annales non solo da Bloch, ma anche dagli indirizzi impressile da Fernand Braudel, che si era più nettamente distanziato dal Febvre, la cui lezione sarebbe invece da riprendere per ri-orientare la storiografia “au bord de la falaise” in direzione della “storia intellettuale, della scienza e della cultura”, secondo gli auspici di Roger Chartier.
Sul rapporto storia-memoria, tema su cui verte la riflessione di Didi-Huberman, merita riportare per esteso questo giudizio:
La sfida del Linguistic Turn costringe lo storico a una serie di operazioni che meritano di essere richiamate, perché è anche un nuovo rapporto con la memoria a essere investito, direttamente o indirettamente, dall’emergere di una nuova consapevolezza – e anche i più precisi, problematici e documentati quadri storici forniscono solo rappresentazioni e immagini del passato, non certo la realtà di cui aveva sognato Ranke, fino a fare dei suoi oggetti di ricerca i pensieri di Dio. La prima di queste operazioni è un bisogno di ricomposizione, che separi il récit puramente narrativo (la fiction), da quello funzionale e specifico degli storici, insistendo sulla clausola – che è anche una pratica e una professione – della ricerca della verità attraverso tecniche e nuovi rapporti con le scienze umane, sociali e naturali. Lo storico è inevitabilmente costretto a cercare delle ragioni teoriche che lo difendano dall’invasione del narrativo. Qui mi preme ricordare alcune strade possibili, a partire dalla riflessione di Arnaldo Momigliano e dalla sua rivendicazione del mestiere e delle regole del gioco contro la dissoluzione estetizzante dei limiti tra ricostruzione storica e racconto di invenzione. […] Non va poi dimenticato l’approfondimento di Carlo Ginzburg, che va oltre Momigliano nella risposta a White, contribuendo ampiamente a un dibattito sui limiti della rappresentazione, nato non a caso sul terreno scottante della Shoah e del negazionismo. Non solo Ginzburg coglie nella soluzione puramente narratologica un’incapacità di distinguere tra discorsi veri e discorsi falsi, ma sposta la responsabilità conoscitiva da un terreno estetico (la storia nell’ambito dell’arte, come l’aveva considerata il primo Croce), riproponendo il terreno etico come essenziale al mestiere dello storico. In Rapporti di forza questo discorso viene sviluppato all’interno della stessa retorica. (Ricuperati 2005, p. 120)
La questione dell’etica della responsabilità dello storico implica dunque inevitabilmente quella dello statuto della verità in relazione all’“organizzazione soggettiva”. Infatti, se il soggetto non è univoco, alla luce della freudiana Ich-spaltung, come si pone la questione del vero? Ricuperati propone di partire dal confronto tra Jacques Le Goff e Temps et récit di Paul Ricoeur (rimando in proposito alla recentissima citata pubblicazione relativa al suo rapporto proprio con de Certeau), “che rappresenta un testo molto importante per gli storici, in quanto stabilisce che la differenza tra il racconto storico e la fiction passa proprio attraverso il vincolo dei documenti intrinseco al primo” (Ricuperati 2005, p. 144; cfr. Momigliano [1969] 1984). Ricuperati sottolinea l’importanza delle pagine relative alla nozione di traccia o la definizione di archivio, “luogo in cui lo storico trova il documento-traccia e compie quell’operazione vincolata che è la conoscenza storica”, per cui la traccia “esercita una funzione di luogotenenza e di rappresentanza. Archivio, documento e traccia vengono così connessi come garanti, appoggi, prove nella spiegazione del passato.”
III. Nella prefazione di un libro splendido, ancorché invero oggi poco ricordato, Storia del paesaggio agrario italiano, Emilio Sereni citava I caratteri originali della storia rurale francese di Marc Bloch per giustificare l’esigenza di produrre sintesi – anche se talvolta premature – al fine di enunciare bene i problemi. Inoltre, motivava così la scelta di fare uso nel suo lavoro di un ampio corredo di immagini (ma anche fonti letterarie quali “un poemetto, georgico od altro”): “Sia ben chiaro, comunque, che delle illustrazioni abbiam fatto uso, qui, non già come di un materiale documentario, bensì solo – là dove la sua rappresentatività fosse garantita da altre fonti – come di un materiale illustrativo, appunto, della nostra esposizione” (Sereni [1961] 1976, pp. 24-25). E poco più oltre: “Là dove, per una impossibilità obiettiva o soggettiva, non sia dato ricorrere ad uno spoglio sistematico ed integrale delle fonti, una testimonianza ‘involontaria’, in effetti, e particolarmente una testimonianza letteraria od artistica, quando sia suffragata dalla conferma di altre fonti, può – per la sua capacità di espressione del ‘tipico’ – assumere un carattere di rappresentatività, che resta altrimenti affidata solo alla più scarna probabilità del dato statistico.” In affermazioni come queste si sente tutta la distanza tra la tradizione dello storicismo italiano e l’approccio alla fonte di Aby Warburg assunta da Didi-Huberman. La testimonianza “involontaria” al massimo “illustra” un enunciato ed è vera solo se “suffragata dalla conferma di altre fonti”, laddove l’immagine è per Warburg in se stessa documento che contiene in se un campo energetico capace di sprigionare senso. Delio Cantimori ci ricorda “come il Warburg fosse passato dalle prime osservazioni sulla teoria delle chiome svolazzanti e delle vesti mosse […] ad osservazioni di più vasta portata, sulla trasformazione dell’intero stile di vita della società mercantile borghese fiorentina nella seconda metà del Quattrocento […] e, come insegnamento generale, l’arte di far sentire voci umane articolate anche da documenti di scarsa importanza apparente, di scoprire, preesistente a una fioritura artistica, tutta una carica di esigenze pratiche e di tendenze di gusto” (Cantimori 1971, pp. 235-236). Ma, come osserva Didi-Huberman : “c’est une réduction typiquement positiviste […] que de traiter les images en simplex documents pour l’histoire, façon de nier la perversité des unes comme la complexité de l’autre.”
Queste discussioni rimandano, come si vede, a problemi cruciali che investono il rapporto tra lo storicismo e le scienze umane e, più specificamente, la tradizione storiografica italiana. Penso in questo senso ai giudizi espressi da Giorgio Agamben in Infanzia e storia ancora nel 1978 laddove, nel “Programma per una rivista”, asseriva:
È implicito inoltre nel progetto ‘filologico’ della rivista, che la concezione della storia che ha dominato lo storicismo moderno debba essere sottoposta a revisione. E’ venuto il momento di cessare di identificare la storia con una concezione volgare del tempo come processo continuo lineare e infinito e, per ciò stesso, di prendere coscienza del fatto che categorie storiche e categorie temporali non sono necessariamente la stessa cosa. Non compito, ma condizione preliminare dei compiti che la rivista si propone è di arrivare a una nuova situazione dei rapporti fra storia e tempo. […] Le nozioni di processo, di svolgimento, di progresso, con le quali lo storicismo cerca di reintrodurre come una parvenza di senso la cristiana ‘storia della salute’ in una storia che esso stesso ha ridotto a una pura cronologia, debbono essere criticamente demolite. (Agamben 1978, p. 145)
Eppure, in tempi non lontani, tale rifiuto ha dato luogo a conflitti le cui derive sono ricadute fino a noi. Carlo Ginzburg le ha recentemente stigmatizzate riferendosi alla artificiosa contrapposizione ‘politica’ tra desiderio e realtà in voga nella Bologna del 1977. In Unus testis infatti si legge: “Tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta il soggettivismo – ivi compreso il soggettivismo estremo – aveva un sapore nettamente radicale. In una situazione in cui desiderio veniva considerato come una parola di sinistra, realtà (ivi compresa l’insistenza sui ‘fatti reali’) aveva un’aria decisamente di destra. Questa prospettiva semplicistica, per non dire suicida, appare oggi ampiamente superata: nel senso che gli atteggiamenti implicanti una sostanziale fuga dalla realtà non sono più privilegio esclusivo di esigue frazioni della sinistra” (Ginzburg 2006, pp. 217-218).
La sua difesa del principio di realtà (per cui, pur apprezzando La scrittura della storia di de Certeau esortava a non disfarsi della vecchia nozione di realtà) trova una sua ragione per esempio di fronte a questo giudizio sui “fatti di Bologna”: “non esisterà uno storico, non tollereremo che esista uno storico, che assolvendo una funzione maggiore del linguaggio, offrendo i suoi servizi alla lingua del potere, ricostruisca i fatti, innestandosi sul nostro silenzio, silenzio ininterrotto, interminabile, rabbiosamente estraneo. (…) Un discorso senza soggetto comincia a parlare” (cit. in Rella 1978, p. 65). Tornano alla mente i versi di Pierpaolo Pasolini su valle Giulia o le parole di Enrico Berlinguer sui “quattro untorelli”. Di ben altro tenore mi pare la proposta di Didi-Huberman che, al di là di letture (o non letture?) talvolta superficiali che hanno caratterizzato gli anni Settanta, è fondata su un autentico confronto con quegli stessi testi di riferimento, da Foucault a Lacan allo stesso Deleuze.
Ricuperati ha ribadito la rilevanza del volume di Umberto Eco Limiti dell’interpretazione, un lavoro che si inserisce in un contesto storico e ideologico in cui talune posizioni venivano fraintese fino a esiti sconcertanti. Secondo Ricuperati, Eco – che riprende queste tematiche nel recentissimo Dall’albero al labirinto. Studi storici sul segno e l’interpretazione (Milano, Bompiani 2007) – ha toccato un punto chiave “riproponendo i limiti vincolanti del testo: questa è una scelta che a mio parere ha un implicito significato etico e civile”, cosa evidente “quando l’oggetto è per esempio il negazionismo rispetto alla Shoah. Sconfiggere l’indifferenza alla clausola della ricerca della verità si è rivelato un terreno impegnativo, dove la risposta non nasce solo dall’epistemologia, ma anche come etica. La negazione dell’Olocausto può essere anche stilisticamente elegante, ma diventa una fiction e non può essere storia … il récit, abbandonato alle arroganze dell’ipotesi, può diventare una tetra negazione del principio di verità connesso al mestiere dello storico come pratica sociale” (Ricuperati 2005, p. 135). A proposito degli “eccessi dell’interpretazione” (così Eco) e delle derive del senso credo valga la pena ricordare che Lacan dichiarava nel Seminario del 1963-64:
È falso che si possa dire che l’interpretazione, come s’è scritto, sia aperta a ogni senso, con il pretesto che non si tratta che del legame di un significante con un significante, e di conseguenza di un legame folle. L’interpretazione non è aperta a ogni senso. E’ una concessione a chi si erge contro i caratteri incerti dell’interpretazione analitica, che tutte le interpretazioni sarebbero possibili, il che è propriamente un assurdo. Non è perché ho detto che l’effetto dell’interpretazione è di isolare nel soggetto un cuore, un Kern per esprimersi come Freud, di non-sense, che l’interpretazione è in se stessa un non senso. L’interpretazione è una significazione, e non una qualunque. […] L’interpretazione non è aperta a tutti i sensi. Non è affatto una qualunque. (Lacan [1963-64], trad. it. [1979] 2003, pp. 253-4)
Aggiungo, a mo’ di esempio, queste parole (inequivocabili) pronunciate da Jacques Lacan a Bordeaux già nell’aprile 1968: “Il y a la structure et il y a l’histoire. Les gens qu’on a mis dans le pot de la structure – je le suis, ce n’est pas moi qui m’y suis mis, on m’y a mis comme ça – sont censés cracher sur l’histoire: C’est absurde. Il n’y a évidemment pas de structure sans référence à l’histoire” (Lacan 2005, p. 88).
La questione dell’etica della responsabilità viene a imporsi a questo livello. Lo storico che “tende alla ricerca della verità” (Momigliano) deve poter scrivere sui “fatti di Bologna” così come sulla Shoah (si veda il recente Manifesto degli storici, su cui cfr. Engramma n. 54) senza indulgere nel “mito dell’Altro” (Rella). E ciò nella misura in cui lo storico opera “dentro la polis”, tendendo a tenersi al di qua di quel “demonico” che pure è parte di noi e che dà luogo al disagio della civiltà [1]. E lo deve fare consapevole di stare metaxy (o, per dirla con Didi-Huberman, “entre deux”), dunque sul bordo, come argomenta de Certeau ne L’assente della storia (De Certeau 2006, pp. 182-191). Già nella relazione annuale del 1925 Warburg affemava significativamente che:
Solo se si abbraccia in un solo sguardo la sua [id. di Cassirer] filosofia del simbolo nell’azione pratica e nella creazione artistica con il fatto singolo stabilito dalla filologia storica, possiamo sperare di strappare alla grande sfinge Mnemosyne, se non il suo segreto, almeno la formulazione del suo enigma: che cosa significa la funzione della memoria individuale e sociale? La specifica analisi geografica dell’elemento figurativo nella pratica religiosa, nella creazione artistica e nel pensiero associativo deve quindi servire a fornire i materiali per la critica, non ancora scritta, della sragion pura [Kritik der reinen Unvernunft] a una posterità più consapevole; senza aver compiuto il postulato di una tale opera non si potrà pensare a un metodo affidabile nella scienza della cultura.
Assumere da parte dello storico la complessità della temporalità (“rizomatica”) non significa assecondare quelle aberrazioni che comprensibilmente suscitano le critiche di Ginzburg, la cui figura intellettuale incarna questa tensione lacerante anche in relazione all’opera di un suo maestro, Delio Cantimori, che cito in quanto recentemente è stato oggetto di aspre polemiche, che purtroppo travalicano l’ambito professionale per colorarsi di stanche valenze politico ideologiche francamente deprimenti. E’ tuttavia singolare che anche le correnti oggi variamente criticate da Ginzburg siano state anch’esse oggetto di analoghe cacce alle streghe in nome di un revisionismo codino. Penso in particolare alle pubblicazioni recentemente apparse in Francia sulla psicoanalisi. Suona strano che figure lontane come Cantimori e Lacan possano venire accostate in relazione ad un avversario comune che rischia di avvilire la vicenda intellettuale contemporanea. Eppure, intorno a esse in fondo verte quel momento (intendo i secondi anni Settanta) che anche Ricuperati, come Eric Hobsbawm e lo stesso Ginzburg ravvisano come turning point nel panorama italiano.
Note
[1] Sulla necessità di elaborare la mitologia negli anni Venti e Trenta nel senso della Ent-dämoniesierung di cui parlava Warburg rimando a de Certeau, L’uomo Mosé; all’introduzione di Lea Ritter Santini a Giuseppe e i suoi fratelli, Milano, Mondadori 1990 visto come “il suo tentativo di strappare il mito al fascismo” (p. 10); cfr. inoltre Furio Jesi, Germania segreta. Miti nella cultura tedesca del ‘900, Milano, Feltrinelli 1995; utile Aby Warburg. La dialettica dell’immagine, a cura di Davide Stimilli, “ aut aut” 321/322 (2004), in particolare i contributi di Cavalletti e di Vinco, secondo cui Warburg si poneva in aperto contrasto con il “germanesimo” e scritti quali Divinazione antica pagana possono venire intesi come una “vittoria personale contro i propri demoni” e “opposizione all’uso ‘di destra’ che in quegli anni veniva fatto dei materiali storici e dei materiali mitologici” (ivi, p. 141).
Bibliografia
- Agamben 1978
G. Agamben, Infanzia e storia. Distruzione dell'esperienza e origine della storia, Torino 1978 - Bloch 1993
M. Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier de l’historien, Paris 1993 - Braudel 1973
F. Braudel, Scritti sulla storia, tr. it. Milano 1973 - Cantimori 1971
D. Cantimori, Lucien Febvre, in Storici e storia. Metodo, caratteristiche e significato del lavoro storiografico, Torino 1971 - Chartier 1998
R. Chartier, Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris 1998 - De Certeau 2004
M. de Certeau, La scrittura della storia, tr. it. Milano 2004 - De Certeau 2006
M. de Certeau, Storia e psicoanalisi tra realtà e finzione, tr. it. Torino 2006 - De Certeau 2007
M. de Certeau, La presa di parola, tr. it. Roma 2007 - Derrida 1995
J. Derrida, Mal d'Archive, Paris 1995 - Didi-Huberman 2002
G. Didi-Huberman, L'image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris 2002 - Didi-Huberman 2006
G. Didi-Huberman, L'immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte, tr. it. Torino 2006 - Didi-Huberman 2007
G. Didi-Huberman, Storia dell’arte e anacronismo delle immagini, tr. it. Torino 2007 - Dosse 2007
F. Dosse, Paul Ricoeur, Michel de Certeau et l’histoire: entre le dire et le faire, Paris 2007 - Ginzburg 2006
C. Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero falso finto, Milano 2006 - Lacan [1963-64], trad. it. [1979] 2003
J. Lacan, Il seminario XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi (1963-64), tr. it. Torino [1979] 2003 - Lacan 2005
J. Lacan, Mon enseignement, Paris 2005 - Le Goff, Nora 1974
J. Le Goff, P. Nora, a cura di, Faire de l’histoire, 3 voll., (vol. I, Nouveaux problèmes, vol. II, Nouvelles approches, vol. III, Nouveaux objets), Paris 1974 - Loraux 1993
N. Loraux, Éloge de l’anachronisme en histoire, “Le Genre humain”, n° 27, 1993 - Mannoni [1963] 1969
O. Mannoni, Je sais bien, mais quand même (1963), in Clefs pour l’imaginaire, ou l’autre scène, Paris 1969 - Momigliano [1969] 1984
A. Momigliano, Historicism revisited in “Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico”, Roma 1969, pp. 24-25; ora in A. Momigliano, I fondamenti della storia antica, Torino 1984 - Rancière 1996
J. Rancière, Le concept d’anachronisme et la vérité de l’historien, “L’inactuel”, n° 6, 1996, pp. 67-68 - Rella 1978
F. Rella, Il mito dell’altro. Lacan, Deleuze, Foucault, Milano 1978 - Ricuperati 2005
G. Ricuperati, Apologia di un mestiere difficile. Problemi, insegnamenti e responsabilità della storia, Roma-Bari 2005 - Sereni [1961] 1976
E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Roma-Bari [1961] 1976
English abstract
Review of the book “Storia dell’arte e anacronismo delle immagini“ written by Georges Didi-Huberman and published by Bollati Boringhieri. The present Italian translation of the volume by Georges Didi-Huberman, together with the very recent one of “La prise de parole“ by Michel de Certeau (2007), the last stage of a new attention in publishing for the work of this scholar, leads to to insist on reflecting on the statute of the historical discipline, increasingly invested by heated debates, such as that on denial, which perhaps it would be appropriate to bring back to the more distant controversies surrounding revisionism, starting with the passionate discussions that took place in the 1960s between and Trevor-Roper on gentry ("rising" or "declining"?), to those, equally heated, on the general crisis of the seventeenth century and on the causes of the English revolution (was it "rebellion" or "revolution"?), to arrive at the controversial and the debated notion of proof, understood both in the technical sense of proof and in the current one of evidence.
keywords | Storia dell’arte e anacronismo delle immagini; Didi-Huberman; Bollati Boringhieri; Review.
Per citare questo articolo / To cite this article: Giuseppe Cengiarotti, Devant le temps. Etica della responsabilità e scrittura della storia Recensione a: Georges Didi-Huberman, Storia dell’arte e anacronismo delle immagini, tr. it., Bollati Boringhieri, Torino 2007, “La Rivista di Engramma” n. 61, gennaio 2008, pp. 92-101 | PDF of the article