In memoriam Gertrud Bing
Donald Gordon, edizione, traduzione e postfazione a cura di Chiara Velicogna
Testo originale inglese | English abstract
Questo testo fa parte dell’opuscolo che fu pubblicato dal Warburg Institute come omaggio a Gertrud Bing in occasione della sua morte nel 1964. Lo presentiamo qui per la prima volta in traduzione italiana insieme alla postfazione: Gertrud Bing, Donald Gordon e il giardino di Dulwich.
In una delle poche fotografie che la rappresentano in modo giusto – davvero rare, comunque – Gertrud Bing è seduta al tavolo del giardino a Dulwich; la porta-finestra alle sue spalle, la sigaretta in mano, i capelli un po’ spettinati. La memoria la rievoca sempre seduta a un tavolo – che fosse la scrivania nella minuscola stanza all’Imperial Institute, o quella nel nuovo, elegante edificio che non le interessava gran che, o anche l’enorme scrivania nera in stile post-Bauhaus nella sua stanza a Dulwich (con il busto di Warburg e la collezione di gialli in edizione economica); oppure più tardi, dopo cena, seduta alla scrivania di Saxl nel suo studio; oppure, ancora, sempre seduta alla tavola da pranzo, rotonda con la tovaglia bianca; o al tavolino di un caffè in Piazzetta, durante la sua ultima visita a Venezia – del tutto stremata e veramente felice – i capelli un po’ spettinati; la sigaretta in mano – ferma ed esplicita sul perché stesse distogliendo lo sguardo dai vari cari amici che continuavano ad attraversare il suo set, e con i quali non aveva voglia di parlare.
A quel tavolo in giardino immaginava, naturalmente, di essere in Italia, qualunque fosse la temperatura; soltanto un fermo rifiuto avrebbe potuto salvarti dal freddo del giugno inglese e dalla malinconia del rigoglio della vegetazione in un prolungato crepuscolo. Ma che paesaggio vedeva, lei? La prospettiva forzata era, per il mio gusto, troppo pesantemente incorniciata e chiusa: troppe siepi, troppi alberi, troppo verde. Un amico tedesco di Amburgo, un illustre giardiniere che lei spesso consultava, lamentava che quel giardino fosse ‘troppo pittoresco’ per lo spazio in cui si trovava. L’effetto desiderato era ‘inglese’ – un giardino all’inglese – immaginato dapprima da Saxl e molto caro ad entrambi (“Preferirei prendermi cura di un giardino che di una tomba” disse una volta, in un momento piuttosto insolito, guardando dall’alto della finestra dello studio). Ma Saxl amava il giardinaggio, quando era ad Amburgo? (Aveva iniziato, com’era tipico, una volta in Inghilterra, abbonandosi alla rivista della Royal Horticultural Society.) E anche Bing?
Non lo so; e a dire il vero non conosco nemmeno il significato di quel giardino all’inglese (il filare di alberi, per quanto fitti, non occultava mai del tutto la presenza dei giocatori di tennis, impeccabili in bianco, le cui voci risuonavano nell’oscurità dell’estate suburbana; e nel prato, sulla destra, asimmetrico, spiccava l’amato acanto – eppure, a dire il vero, per le prospettive all’inglese a scala intera è sempre stata d’obbligo una scura essenza esotica: leccio o cedro). Tutto questo anche per dire quante cose io non sia mai riuscito a sapere o comprendere; e quanto sia così strano aver potuto, per un quarto di secolo, dare per buoni il malinteso e la stranezza di tutta quella vicenda.
Il senso della casa, ad ogni modo, non era mai stato inglese, né tantomeno progettato come tale. Bing aveva disprezzo per i forestieri che desideravano indossare una maschera inglese: con il passare degli anni diventava se non altro più schietta, e non so fino a che punto Bing fosse realmente interessata all’Inghilterra dal punto di vista storico, culturale, visivo. O almeno, se mai aveva avuto un interesse di quel genere, via via era scemato. Aveva messo un punto fermo sulle convenzioni delle istituzioni inglesi, sulla struttura di classe, sulle famiglie, sulla lettura di ricordi (che era abitudine più di Saxl che sua) – sebbene qualche lampo di curiosità la colpisse di tanto in tanto. Tornava da una rara sortita nelle periferie più agiate con la pretesa di sapere chi fossero tutte le persone con le quali aveva parlato, e come mai vivessero e parlassero in quel modo: sul tema, come su altri aspetti dello stile di vita inglese, la sua conoscenza era molto limitata; e non le interessava allargarla. Le erudite opere della letteratura inglese nel padiglione del giardino formavano una collezione piuttosto bizzarra: doni da parte di amici e acquisti piuttosto casuali da librerie di seconda mano – ma tutto questo apparteneva a una sua prima fase (compreso l’acquisto di Dickens). I paesaggi inglesi l’avevano commossa; ma era diventato difficile convincerla a viaggiare – in Inghilterra – fuori da Londra. E non era affatto la conseguenza dell’età e dell’affievolirsi della curiosità: perché in Bing era proprio la persistenza della sua curiosità che restava straordinaria. Non dipendeva neppure del tutto dal fatto che dal 1949 l’Italia le avesse aperto le porte, e dal fatto che per lei l’Italia fosse reale in un modo in cui l’Inghilterra non era mai stata. Quella comunque era una relazione più facile da comprendere. Anche se ritornarci, nel triste periodo successivo alla morte di Saxl, era difficile per lei: forti erano le resistenze. Ritornando in Italia non soltanto rimetteva in scena la storia del Warburg Institute; era piuttosto – come indicava lo shock del piacere che ogni volta si rinnovava – un rimettere in scena quella storia così nota e purtuttavia sempre vera che tanti tedeschi e tanti inglesi hanno impersonato nel corso di molti secoli: l’Italia allo stesso tempo casa e vacanza. Certo, sì, era una questione di monumenti (in quell’ultima visita a Venezia nel 1962 era completamente assorbita dal San Lorenzo di Tiziano ai Gesuiti) ma anche di stile, di milieu, di persone, di un senso di crescita.
Se il suo rapporto con l’Inghilterra è problematico e quello con l’Italia più intelligibile, la relazione con la Germania è pressoché un buco nero. E questo è un grave limite, visto che esisteva ancora una Bing che parlava tedesco. E qui entrano in gioco diversi livelli di ignoranza. C’è la mancanza di testimoni, e anche la reticenza di Bing, forte su questa come su altre questioni. È sorprendente come ad amici e colleghi sia noto così poco della sua vita prima del suo arrivo all’Istituto di Amburgo (ma del resto anche del suo primo periodo là). Non ero il solo, ad esempio, a restare interdetto nell’apprendere, solo dopo la sua morte, del suo periodo come maestra di scuola. E qualcuno dovrebbe registrare che dovevano esserci state notevoli tensioni nella sua famiglia; Siegfried Bing de L’Art Nouveau – che insieme a Morris e Liberty fu uno dei grandi mercanti d’arte del suo tempo – era suo zio; lei non sapeva molto di lui, se non qualcosa del suo primo contatto con il Giappone (e abbastanza da correggere, gentile ma con fermezza, ne sono sicuro, uno studioso Americano che aveva scritto inesattezze su di lui in un articolo recente sull’Art Nouveau); e ricordava con rimpianto che nella sua gioventù più austera aveva distrutto una grande quantità delle stampe giapponesi prodotte dallo zio; e aveva tentato, senza successo, di trovarne testimonianze o documentazione a Parigi.
Ma Bing teneva le sue amicizie divise in compartimenti stagni: e può essere che parlasse più liberamente della sua famiglia e della sua vita tedesca in contesti che a me, e ad altri, erano ignoti. E certamente era dell’idea che i suoi amici inglesi non fossero interessati e non volessero sentir parlare di Germania (affermando “ora che Warburg è in traduzione in italiano i nostri amici inglesi non avranno alcuna scusa per non leggerlo” toccava uno specifico nervo scoperto, ed era la spia di una sua percezione più ampia e generale). Nel mio caso era in parte vero. Vi era una conoscenza miserevolmente limitata della lingua tedesca, e nessun vero desiderio di leggerla o parlarla. A parte il fattore del carattere o della pigrizia, questo poteva ben accadere a chi era cresciuto negli anni ’30: l’ossessione della condanna della Germania poteva portare al rifiuto totale di andarci, o di avere a che fare con qualunque tedesco, fatta eccezione per i rifugiati – i quali per la gran parte non avevano alcun desiderio di parlare tedesco con noi. Inoltre – come arrivai a capire in seguito – c’era l’ignoranza di quello speciale milieu tedesco che era Amburgo, di cui invece Bing aveva una coscienza così profonda; con Berlino e Monaco si rifiutava di avere a che fare (eccetto, negli ultimi tempi, per la Galleria); e nei confronti di Vienna, aveva una scarsa dose di sopportazione: era tornata da una sua visita a Vienna nel 1963 (ed era solo la seconda) con la conferma di quel che aveva già deciso prima di partire (“Non vedo cosa ci sia di così eccitante. Davvero noiosa”). E cosa ho mai saputo – me ne rendo conto ora – dell’ebraismo tedesco – di come potesse essere stato crescere in quel paese, a quel tempo. Quanto era bizzarro, riflettevo, che Bing non avesse mai parlato per tanti anni a qualcuno nella sua lingua madre (ma l’avrebbe voluto?). E forse il mio interrogativo su Bing e l’Inghilterra è solo la declinazione particolare di una domanda generale, rinnovata ora che si ripresenta come proponibile, dopo essere stata per tanto tempo messa a tacere, dapprima deliberatamente, e poi per abitudine: come l’avevano vissuta loro, quella situazione? Allora, nel 1938-39, all’età che avevamo, era il presente della comunità ebraica tedesca che era lì, insieme a noi. Le domande storiche rimasero inespresse.
In quel presente ero cresciuto. Nella primavera del 1933, recatomi ad Edimburgo per sostenere un esame per una borsa di studio, comprai una copia della studentesca e vi trovai un articolo sui roghi dei libri. Quell’autunno erano comparsi i primi studenti ebrei tedeschi. L’anno accademico 1938-39 lo trascorsi a Firenze: la prima o seconda notte che ero là vidi una camionetta piena di giovani che distruggeva le vetrine di un grande negozio: un negozio di ebrei, mi dissero il giorno seguente, quando chiesi che cosa fosse successo. Durante l’inverno e la primavera di quell’anno i segnali si erano accumulati nelle vetrine delle librerie così come nell’interesse nervoso della mia padrona di casa nei confronti degli ebrei. E nei salotti e nei caffè dei poeti e degli intellettuali dissidenti, così come negli studi, solenni, brutti e marrone scuro, dei professori si moltiplicavano i resoconti di ciò che stava accadendo nelle università, e della fuga, talvolta soltanto tentata, di tedeschi, austriaci, cechi, italiani: una società in dissoluzione. E molte città si dissolvevano per collocare queste figure nei caffè o nei salotti: si trattava di espatriati, turisti, rifugiati? Chi mai più sapeva chi si fosse o chi si potesse essere, quando l’amico morente di Oscar Wilde si attardava per un momento sulla scalinata del quindicesimo secolo, e il poeta americano (che era stato definito “il miglior fabbro”) andava dicendo quanto fosse splendido il Fascismo, perché i gerarchi citavano Catullo; e un dimenticato piccolo uomo raccontava delle sue serate con Kafka a Praga e l’uomo dietro al bancone faceva spallucce all’assegno che gli veniva porto, dicendo “Ma l’Austria non c’è più”, e l’amante del famoso poeta, isterica, la filodiffusione a tutto volume tra i suoi chintz inglesi sotto all’enorme de Chirico (rovine e figure senza volto) diceva “Stiamo aspettando di sentire i bombardamenti”; e quando l’ufficiale inglese gentile e devoto aveva scritto elogi del regime e uno dei professori dissidenti consegnava il suo regolare rapporto settimanale alla polizia? A Cambridge c’era Auden che leggeva la sua Spagna – (C’era stata la Spagna per così tanto tempo): “Domani le corse in bicicletta / fuori porta le sere d’estate: ma oggi la lotta…Rimaniamo soli col nostro giorno, e il tempo è breve e la Storia agli sconfitti/ può dire Ahimè ma non darà aiuto né perdono”. [1] E nella stessa casa vi era un austriaco che ogni sera aveva bisogno di essere consolato a causa degli insulti e delle persecuzioni sempre nuove che subiva durante il giorno e il cui padre, madre, fidanzata e mobilio avevano dovuto, in qualche modo, essere trasportati via da Vienna.
Questo frammento di curriculum vitae è qui solo per una ragione: per ricordarci, per rispetto della storia, del contesto in cui avvenne l’incontro con Saxl e il Warburg Institute, con Dulwich e Bing (e i miei primi ricordi di Bing sono per lo più collegati a Dulwich). Quell’incontro è stato parte, in modo importante, del mio essere cresciuto negli anni Trenta, dell’avere avuto ventiquattro anni nel 1939. Eccitazione e adesione, curiosità e i limiti stessi di quella curiosità, erano parte di quel mondo liquido di presagi e destini, di migrazioni, passaggi, esili e di sorprese che esistevano al di là della porta di una casa suburbana. La grandezza di Saxl – userei ancora questo termine – e il suo carisma, con tutto ciò che l’Institute e la biblioteca avevano da offrire sarebbero stati meno potenti se non fosse stato per il modo in cui essi affrontavano quella situazione. C’era un senso di novità e di grata sorpresa, e una specie di intimità familiare: tutto combinato in modo da far convergere in una sola esperienza libri e conoscenza e persone e luoghi. Nelle scuole umanistiche che avevo frequentato ero cresciuto nella tradizione della storia ‘positivista’ del diciannovesimo secolo, e nelle polemiche nei confronti del ‘new criticism’ (delle quali ero già stanco, sebbene dovessi loro molto); mi ero molto concentrato (e lo eravamo già tutti) sull’‘immagine’, ed ero insoddisfatto dei modi che avevamo di parlarne: ero più interessato a questo e alla nuova ‘storia delle idee’, che arrivava alle scuole – per lo più e direttamente – dall’America – cosa che mi rendeva altrettanto insoddisfatto; ed ero anche profondamente coinvolto nelle faccende italiane (e in Italia si offriva Croce, quando io preferivo di gran lunga Marx) – insomma, ero decisamente pronto per la biblioteca e per Saxl.
Dopotutto, ero in possesso, perché l’avevo bene appreso, di un metodo rigoroso per la ricerca storica. La novità stava nei generi di testi e documenti, nelle giustapposizioni di materiali che erano offerte (quell’impressionante disposizione della biblioteca), nei nuovi generi di domande. Tutto ciò corroborato dalla mera presenza fisica di quei volumi, e di quelle persone. Ero in confidenza, sì, con vari studiosi in esilio – studiosi, intellettuali, poeti in transito: ma qui (in quelle orribili stanze, in quel mostruoso e decadente monumento imperiale, già obsoleto al momento della sua costruzione), al contempo assimilata e controcorrente, vi era un intero grandioso pezzo dell’intelligenza europea, che portava con sé sia il presente sia il passato infinitamente complesso che l’aveva generata. In questo circolo era in scena il dramma del fluire, della precarietà, dei pericoli: elementi familiari, quando si doveva convivere con l’inaspettato e il provvisorio. Ma era allo stesso tempo solido, un ambiente in cui poter lavorare senza drammi, ad eccezione del dramma dell’arrivo di nuovi libri e di nuove domande, il tanto desiderato dramma in funzione del quale eravamo stati cresciuti. Qui, prezioso in quel momento quasi più di qualsiasi altra cosa, era l’esempio della tenacia: tenacia nel leggere, nel porre domande, nel lavorare. Un esempio molto più prezioso di quanto io, e molti altri, avessimo trovato a Cambridge, dove la tenacia era tenuta blandamente in conto, abitudine da non considerare, oppure era un ben determinato campanilismo, calcolato al meglio per offendere anziché per rafforzare i giovani; dove erano giardini ed edifici a parlare con una voce più emozionante.
La solidità dell’ambiente era, naturalmente, un’illusione, il gioco di prestigio di un mago sapiente, o una magia mimetica che doveva essere preesistente prima che la realtà potesse seguirla. Corrispondeva a qualcosa che stava nella natura di entrambi, sia di Bing sia di Saxl; e che era evocata anche a Dulwich. Bing narrava dell’elusività di Saxl, della sua buona disposizione al provvisorio, del suo desiderio di libertà: e veramente l’immagine del viandante [2] gli si addiceva bene: eppure, eppure, c’era sempre quel giardino progettato, piantumato e curato non per la fioritura della stagione in corso ma per una maturità che avrebbe impiegato anni per svilupparsi. Credo di essere stato invitato a Dulwich forse già al nostro secondo incontro. W. B. Yeats disse delle scale di una casa di campagna, abbastanza modesta, che Balzac avrebbe impiegato cento pagine per descriverle. Molte storie si potrebbero scrivere a partire dalla descrizione del soggetto e dell’allestimento di quell’alto, brutto, angusto, ordinario edificio collocato in una anonima strada. Ma nessuno ora può più scriverle. C’era un tempo in cui non si potevano fare domande; e un tempo in cui ci si dimenticava di farle perché tutto era diventato così familiare. Al tempo, ciò che impressionava era la combinazione di austerità, di miscellanea e di vero e proprio disordine, d’‘avanguardia’ e borghese, e le accumulazioni da gazza ladra di Saxl (delle quali amava davvero parlare). Saxl amava l’oggetto umile, dimenticato, non certo a causa di un culto del ‘contadino’ o del neoprimitivo, ma perché erano frammenti di una storia più ampia, una toccante testimonianza della sopravvivenza e della durevolezza di importanti immagini e concetti (come il frammento di cotone indiano posto dietro al divano nel padiglione in giardino, che aveva comprato, mi raccontò Bing, perché l’aveva visto come un ultimo autentico esemplare che discendeva da modelli tardoantichi). Non sono certo di quanto tutto ciò corrispondesse davvero al gusto di Bing; credo che un ambiente da lei stessa creato sarebbe stato più austero: c’era contrasto tra la prima stanza in cui aveva vissuto e lavorato (con la grande scrivania nera) e il disordine dello studio di Saxl; il nero vaso Sung era quello che lei voleva. E nel caso, sebbene amasse sia Roma sia Venezia, era a Firenze che voleva sempre ritornare.
In quelle prime visite, Bing certo accentuava – la mia memoria insiste su questo punto – una delle note che colpivano sia nell’Istituto sia nella casa di Dulwich: era, per dirla chiaramente, un campanello di allarme. C’era il terribile problema di essere all’altezza di Saxl. La mia prima serie di quelle che divennero poi lezioni intensive con Saxl fu tenuta là a intermittenza fino all’estate del 1940 – sessioni durante le quali Bing versava il caffè che diventava sempre più freddo (ricordo di essermi domandato se il caffè freddo fosse un’abitudine tedesca oppure solamente un’idiosincrasia della casa) e che continuavano a lungo dopo che lei si era ritirata nella sua stanza, con la conseguenza che le poche ore residue della notte erano per lo più insonni. (Ad ogni modo c’era il problema del piumino alla tedesca, che avevo incontrato là per la prima volta e del quale non sono mai riuscito ad essere entusiasta.) Ma se Saxl mi metteva ansia, Bing mi incuteva timore. Era l’immagine della severità, e in un modo che sembrava del tutto riconoscibile: i capelli scuri tagliati corti, le innumerevoli sigarette, gli abiti scuri e austeri, il ricorso ai cognomi, la sua prontezza, l’acume delle sue domande: tutto mi evocava, anche a quell’epoca, la donna emancipata degli anni Venti. L’immagine di lei che porta una bandiera rossa è probabilmente un mio abbellimento, che io comunque credo gradevole; che lei abbia partecipato, schierata a sinistra, ad agitazioni politiche in Germania alla fine della prima guerra è certo: le ricordava, insieme alla sua ‘gioventù rivoluzionaria’, con divertimento ma senza alcun dispiacere. Comunque, qualunque potesse essere stata la portata delle sue idee e della sua militanza, la mia prima impressione non era del tutto sbagliata. Un certo che dell’aria di quella generazione di donne, Bing se lo portò con sé fino alla fine. Con gli anni, naturalmente, la sua postura si era rilassata; e l’immagine della severità si era via via attenuata per essere sostituita da un aspetto di generale benevolenza che accompagnò i notevoli cambiamenti nel suo aspetto nell’età matura e nella vecchiaia. Mi sembrò che si chiudesse il cerchio quando un mio allievo, dopo averla incontrata in un contesto informale, circa un anno prima della sua morte, mi disse in seguito, “Che cara anziana signora”.
Non riuscii a rispondere. Bing era affabile, è vero, e molto gentile verso i giovanotti piacevoli e intelligenti che rispondevano con prontezza e sensibilità ma senza essere troppo loquaci, ed era molto disposta, ora, a divertire e divertirsi; eppure, nonostante tutto, faticavo a credere che un’ora di conversazione potesse produrre quello specifico cliché inglese, suggerendo un’immagine così completamente estranea a Bing da farmi d’improvviso realizzare, in quel momento, che esisteva un mondo di linguaggi ed esperienze nel quale non mi era possibile inserirla – un mondo che non era né suo né mio.
Neppure il più verde dei giardini né la più quieta periferia inglese potevano farla assimilare a quel mondo (eppure quel giovane non era affatto ottuso). Qualche nota di severità, perfino di fierezza, era ancora necessaria per definizione in quella benevola vecchiaia; e c’era anche qualche frase, se fosse stato possibile individuarla con precisione, che insisteva sul non-inglese. (L’orecchio mi aveva suggerito che una parte – sintomo e causa – dell’evidente ‘rallentamento’ verso la fine della sua vita fosse linguistica, che la lingua le riuscisse con meno facilità.) Inalterata era la sua capacità di disprezzo, sebbene fosse via via sempre più collegata al suo apprezzamento per l’assurdo, o per quel che è semplicemente comico, nel comportamento umano. Disprezzo per burocrazie, ‘istituzioni’, macchine, messinscene sociali ed intellettuali, per i talenti corrotti dal denaro o dalla pubblicità; sdegno – e quello sempre – per la slealtà; oltre a ciò, per i grandi tradimenti degli anni Trenta, che non aveva mai dimenticato. (Spesso un suo giudizio aspro era mitigato dal ricordo di un comportamento corretto che la persona aveva tenuto durante quegli anni.)
Un costante flusso di energia morale era una delle fonti della sua forza. Trascurare ciò sarebbe tanto errato quanto immaginarla in un costante atteggiamento di giudizio. L’immagine, insistentemente rievocata, di Bing seduta a una scrivania o ad un tavolo, non ha questo significato; tanto quanto non implica la semplice nozione di una donna di quella particolare generazione investita di un ruolo direttivo. Aveva infatti un ruolo direttivo e lo svolgeva, dato che poteva e doveva. Ma non sempre lo voleva. Oltre a un certo punto non era disposta a prendere decisioni per altri; o a giudicare. È qui che entra in gioco la sua famosa frase – pronunciata in qualsiasi lingua fosse appropriata al momento. “Perchè no”, avrebbe detto, oppure “Non c’è nessuna legge che ti obbliga”. Era il modo con cui ti riportava alla concretezza del momento: alla tua libertà (e al tuo dovere) di decidere: e poteva anche applicarla a se stessa: disse “Dopotutto, perché no” quella sera in cui decise di aprire lo studio di Saxl e rimanere lì dopo cena (le sue pipe erano ancora alla sua scrivania, e anche il pentolino di rame che usava come contenitore per il tabacco). Empirica e pragmatica, diffidava delle ampie formulazioni sulla storia, sulle esperienze o i comportamenti, e di tutta la ‘sovrainterpretazione’, fosse di un testo o di un’immagine o di una situazione. Destinava lo stesso genere di attenzione sia a manoscritti sia a situazioni. La ragione e i semplici fatti (purché verificabili, per quanto potessero dimostrarsi esotici); e l’eleganza (così come la intendono i matematici) di esposizione ed espressione, erano ciò a cui lei voleva farti arrivare. Non che ‘razionalista’ sia il termine giusto per descriverla.
Le origini della sua indimenticabile fortezza di spirito inevitabilmente ci sfuggono: ma non affondavano nella convinzione che ragione, verità e giustizia prevarranno, né tantomeno qualsiasi tipo di credenza in un fondamento ultimo o nella irrazionalità divina. Non penso che per lei il mondo avesse un senso, e certamente nessun senso trascendentale (“Quella via ci è preclusa”, disse con fermezza, bruscamente rifiutando di discuterne oltre). Conosceva i limiti della ragione nelle faccende umane. La sua vita l’aveva portata a conoscere, con acuta intensità, menti inquiete e a osservare l’angoscia dell’irrazionale; e in situazioni come questa era sensibile e forte. Eppure ho la sensazione che tutto le fosse estraneo e che, sebbene ne fosse conscia non avesse mai accettato di buon grado che talvolta la ferita deve camminare insieme con l’arco. L’ossessione per l’irrazionale la preoccupava. Qualche anno fa, quando ero immerso nel mondo della magia e delle ‘piccole religioni’ degli anni Novanta del XIX secolo mi rimproverò per aver passato così tanto tempo su del ‘nonsense’; e reagì molto bruscamente quando avevo ipotizzato che un tale interesse per il simbolo in Europa a quel tempo, in quel mondo sospeso a metà, doveva aver avuto un qualche influsso sulla formazione di Warburg e sulla direzione delle sue ricerche. Ultimamente, su quest’ultimo punto era più accondiscendente, per senso di equanimità; ma preferiva comunque tenere in conto Darwin, per esempio (aveva sviluppato un grande entusiasmo per The Expression of the Emotions in Man and Animals). L’avversione [per l’irrazionale] rimaneva. Avrebbe preferito vedere più razionalità.
Solo nel suo ultimo anno di vita l’ho sentita lamentarsi che si annoiava. La mia sorpresa al momento sembrava sproporzionata: eppure, ripensandoci, avevo ragione a sconcertarmi. Nel caso di Bing si trattava di qualcosa di molto serio. Poco importava che avesse cessato di comprare o leggere i giornali: molte persone più giovani di lei facevano così (“Non c’è nessuna legge che…”). Erano anche in molti a condividere la sua avversione per gran parte di ciò che accade nel mondo accademico, nonché la sua paura che fossimo a rischio di dimenticare il senso ultimo del nostro lavoro, per l’erosione sia dei tradizionali campi della conoscenza sia delle modalità di ricerca (aveva recentemente sviluppato una formula che premetteva all’annuncio che c’era qualcosa che le interessava: “Se è importante che qualcuno lo sappia, allora…”). Il fatto che in generale si lamentasse di annoiarsi era un'altra cosa. Perché con Bing il punto è che non si annoiava. Esausta a volte, stravolta, altre volte sfinita (perfino lei), annoiata abbastanza spesso e con una certa dose di indignazione in qualche occasione particolare, ma mai annoiata fino in fondo. Il nucleo della sua forza, di quell’energia morale e potenza critica che ne definiva l’orizzonte e l’impegno era, suppongo, contenuto in questo: in un, ma le parole sono vaghe, quando ciò che si cerca è l’opposto della vaghezza e forse è più facile procedere alla definizione e contrario – in un continuo, ininterrotto senso di vita: di qui ed ora, spazio e tempo, di presenza, di un passato che precipita nel presente. Il mondo esistente era infinitamente reale per lei: uno sfaccettato mondo di individualità, con le loro esperienze, cosa producono e con la varia superficie della solida terra sulla quale vivono. È davvero un dono molto raro. Da qui il fervore vitale e la curiosità che ci mancheranno così tanto. Questa presa la dimostrava in molti modi – ad esempio, nella sua notevole capacità di sentire ed evocare luoghi, forme e colori in paesaggi o città. O ancora, penso, si dimostrava nei suoi gusti in letteratura, di cui segnava forse i limiti (di tutti i miei primi amici al Warburg Institute solo Bing aveva un vero interesse per la letteratura moderna; Saxl sosteneva che il suo romanzo preferito fosse l’Hypnerotomachia, ed era vero, ne sono sicuro; ma non era propriamente di aiuto). Nei confronti della letteratura del ventesimo secolo le sue affinità erano meno perfette, ed era poco interessata alle opere scritte in inglese che più ci avevano coinvolto (a parte Conrad e qualcosa di Forster), ma in tedesco c’era Thomas Mann (detestava Hoffmansthal, e non le importava molto di Rilke: su Kafka era solita alzare le spalle); nel diciannovesimo secolo c’era Dickens, che, dopo Shakespeare, era lo scrittore inglese che più ammirava, c’era Zola (un’ammirazione dell’ultima fase della sua vita che non condividevo) e forse sopra tutti, Ibsen, per il quale aveva una vera devozione (si sentiva in teatro il suo esplosivo “ach!”, che era il suo modo di esternare profonda commozione). Quello che cercava, penso, era audacia nella sperimentazione linguistica e nell’esecuzione, una restituzione coerente del milieu, verosimiglianza psicologica. Era alla ricerca di una “solidità di specificazione”, per dirla con Henry James – non che lei avrebbe mai voluto avere qualcosa a che fare con lui.
Si sarebbe potuto girare la proposizione da una parte o dall’altra. E, ritornando a Dulwich nel 1939 – 40, domandarsi di nuovo perché ‘solido’ sembrasse, paradossalmente, in quel mondo fluido, la parola giusta. Ciò non era collegato solo all’integrità del milieu: ciò avrebbe piuttosto messo l’accento sull’esilio e sul transito, così come era per altre case e appartamenti ‘di rifugiati’ stipati di mobilio austriaco e tedesco; poteva darsi che il motivo principale fosse che Saxl e Bing fossero oberati di lavoro, ma come era possibile che avessero potuto attuare questo trasferimento? Che loro fossero presenti qui già da sei anni poco importava: altri nella stessa posizione non vi erano riusciti (e molti non sarebbero mai stati capaci di farlo). Il risultato di tutto questo è, naturalmente, ed è chiaro ora, che non ho mai considerato Saxl e Bing come ‘rifugiati’.
L’inconfondibile odore di esilio non era mai aleggiato in quella casa. Alla base sia della loro casa che del loro giardino, così come del mantenimento in funzione dell’Istituto stava l’‘ispirato opportunismo’ di Saxl e ciò non era privo di collegamento con le sue qualità, con i suoi obiettivi e con i suoi metodi nel fare scuola, con la sua capacità di ‘cogliere l’attimo’ – ma anche con la pazienza di Bing (che lei, forse, aveva dovuto apprendere) in stretto contatto con il suo senso del reale. Non esuli, ma nemmeno inglesi. Potevo accettare loro, la casa, l’Institute (inconsapevole, e destinato a rimanere tale, di così tanto di ciò che accadeva in Boemia, a Vienna, Amburgo o a Brunswick) come parte di un’esperienza dell’Europa che era urgente e necessaria. Queste parole potrebbero essere esagerate. Saxl e Bing erano arrivati sempre più a detestare paroloni come ‘Europa’, ‘l’Occidente’, ’tradizione’, ‘internazionale’ a causa degli usi che ne erano stati fatti, i pretesti, le falsità, le volgarizzazioni, o peggio altro ancora, che avevano mascherato; eppure, con tutte le esitazioni possibili, la parola Europa e la parola tradizione (per quanto intese in modo imperfetto) affioreranno, se connesse con lei, per significare qualcosa di reale, tangibile ed esperito, per arricchimento e forza oltre che sofferenza, ed erano interamente necessarie: quando lei c’era. E Bing (per quanto – o, per quel che so, poiché – appartata e riservata per gran parte della sua vita) c’era sempre. Questo è il motivo per cui mi si ripresentano le immagini di tavoli e scrivanie, ed ecco cosa suggeriscono realmente. Il mondo era reale per lei e lei era reale. La maggior parte di noi è presente solo a singhiozzo, intermittentemente; Bing (a qualunque costo) era sempre, incontestabilmente, presente. Il dialogo con lei non garantiva né sicurezza né comodità, ma realtà, di momento, di esperienza, di tradizione, di comunità.
In memoriam Gertrud Bing
Donald Gordon, new edition by Chiara Velicogna
One of the few photographs of Bing that seems right – there are very few, anyhow – shows her sitting at the garden table in Dulwich, the french window behind her, a cigarette in her hand, her hair slightly dishevelled. She always seems to have been behind a table – memory suggests – that desk in the tiny room in the Imperial Institute, or in the genteel new building she scarcely cared for, the huge black post-Bauhaus desk (with the bust of Warburg, and the collection of paper-back detective stories) in her room in Dulwich, later at Saxl’s desk in the study there after dinner or, always, it seems, at the round dining table with the white cloth; or at a café table in the piazzetta, on het last visit to Venice, completely exhausted and very happy (her hair slightly dishevelled), a cigarette in her hand, being firmly explicit about why she was looking away from various cari amici who kept crossing the scene, and whom she did not want to talk to.
At the garden table she was, of course, pretending to be in Italy; temperature did not matter; only firm refusal could save you from the chill of an English June and the melancholy of too many greens in the too-long twilight. The landscape she saw? The contrived vista was, for my taste, too heavily framed and closed: too many bushes, too many trees, too many greens. A German friend from Hamburg, a distinguished gardener who was often consulted, complained that the garden was ‘too picturesque’ for its space. The effect desired was English, an English landscape garden: imagined first by Saxl; and very dear to both (‘I would rather look after a garden than a grave’, once, in a most unusual moment, as she looked down from the study window). But did Saxl garden in Hamburg? (He began characteristically in England by subscribing to the Royal Horticultural Society’s journal.) Or did Bing?
I do not know; and I do not really know the meaning of that English garden (the screen, dense though it was, never shut out the presence of the correct tennis players, calling, in white, into the suburban summer darkness; and, conspicuous, asymmetrically, in the lawn, to your right, was a cherished acanthus – yet, indeed, full-scale English vistas have always demanded a dark exotic: ilex or cedar). All of which is a way of saying how much I never knew or understood; and how very odd that one should, for a quarter of a century, have taken incomprehension for granted and the oddness of the whole affair.
The sense of the house, anyhow, never was and was never intended to be English. For aliens who wished to wear an English mask Bing reserved scorn: growing, if anything, more forthright with the years, I doubt how far Bing was really interested in England, historically, culturally, visually. Or, what interest there had been grew less. Those conventions about English institutions, class-structure, families, the reading of memoirs (which had been Saxl’s more than hers) stopped – though a flash of curiosity would strike her. She would come back from a rare foray into the more expensive suburbs requiring to know who all the people were she had been talking to and why they lived as they did and talked as they talked; her knowledge of this, as of other kinds of English life was very limited; and she did not care to extend it. The English works of polite literature in the garden room were a queer enough collection: gifts from friends and fairly casual acquisitions from second-hand bookshops: but all this really represented an early phase (even buying Dickens). English landscapes had moved her; but it became very difficult to get her to travel – in England – from London. This was hardly just the effect of age and failing curiosity: because it was Bing’s persistence in curiosity that was so striking. Nor was it entirely because after 1949 Italy was open to her: and Italy was real to her in ways that England never was. That was a relationship, however, easier to understand. To return, in that sad period after Saxl’s death, was difficult for her: there were many resistances. But, returning, she was not only re-enacting the history of the Warburg Institute; but – the shock of pleasure constantly renewed pointed to it – re-enacting that so familiar yet always true story which so many Germans and so many Englishmen have acted out through so many centuries, Italy was both home and holiday. It meant monuments (on that last visit to Venice in 1962 she was deeply absorbed in the Titian St. Lawrence in the Gesuiti), yes of course, but also a style, milieu, people, a sense of enlargement.
If the relationship with England is problematical and the relationship with Italy more intelligible, the relationship with Germany is almost a plain blank. This is a very severe limitation, for there was still a Bing who spoke German. Several sorts of ignorance are involved. There is the absence of witnesses, and there is Bing’s reticence, strong here as in other matters. That so little seems to be known by her friends and colleagues of her life before she went to the Institute (or of her early life there, for that matter) must surprise. I was not alone, for example, to be taken aback, rather, to learn, only after her death, about her period as school-mistress. And someone should record that there must have been a remarkable strain in her family; Siegfried Bing of L’Art Noveau, along with Morris and Liberty one of the great creative shop-keepers of his time, was an uncle: she did not know very much about him, but something about his first contact with Japan (and enough to put right, kindly but firmly, I am sure, an American scholar who had written inaccurately about him in one of the recent articles on Art nouveau); and she recalled regretfully that in her austerer youth she had destroyed a great pile of the Japanese prints he issued; and she had tried, unsuccessfully, to find records or papers in Paris.
But Bing kept her friends in compartments: and she may have talked more freely about her family and her German life in contexts that I, and others, did not know. And she certainly had the idea that her English friends were not interested in and did not want to hear about Germany (“Now that Warburg is being translated into Italian our English friends won't have any excuse for not reading him” – touched a particular sensitive point, but was characteristic enough of a wider feeling). In my case it was partly true. There was a miserably limited knowledge of the German language, and no real desire to read or speak German. Apart from temperament or laziness, this could happen to someone growing up in the thirties: doomed preoccupation with Germany could lead to a blank refusal to go there or have to do with any Germans except refugees – who for the most part had no wish at all to speak German with us. Then – as I came to realize later – an ignorance of a very special German milieu, Hamburg: of which Bing was so very conscious; Berlin and Munich (except, lately, for the Gallery) she would have nothing to do with; as for Vienna, that she had little patience with, and she came back from her 1963 visit (her second only) confirmed in the decisions she had made before she went (“I don’t see what there is to make a fuss about. Very boring”). And what did I ever know – I realize now – about German Jewishness – of what it had been like to grow up in those places at that time. How strange, reflecting, never, in so many years, to have spoken to someone in her native tongue (but would she have wanted it?). And perhaps my question about Bing and England is only a special form of a generalized question, renewed after it had been allowed – first, deliberately, and then from habit – for so long to lapse: what did they, really, what have they, made of it all? Then, in 1938-39, and at that age, it was the present of German Jewry that was here, with us. The historical questions went unasked.
With that present I had grown up. In the spring of 1933 when I went to Edinburgh to take an entrance scholarship examination I bought a copy of the undergraduate magazine and found in it a piece on the burning of the books. That autumn the first German Jewish students appeared. The session 1938-39 I spent in Florence: on my first or second night there I saw a lorry load of young men breaking the windows of a large shop: a Jewish shop, I was told next day, when I asked what could have been happening. That winter and spring the evidence accumulated in the bookshop windows and the nervous interest of my landlady in Jews; and in the salons and cafés of the dissident poets and intellectuals, and the solemn ugly dark brown studies of professors, the stories multiplied of what was happening in the universities, and of the new or the renewed or the attempted flight of German, Austrian, Czech, Italian: a dissolving society, And many cities had dissolved to furnish those figures in café or salotto: expatriate, tourist, refugee? Who knew any longer who anyone was or what anyone might be when the dying friend of Oscar Wilde’s paused for a moment on the fifteenth-century steps, and the American poet (“il miglior fabbro” he had been called) said how splendid Fascismo was because the gerarchi could quote Catullus, and a forgotten little man talked of evenings with Kafka in Prague and the man behind the counter shrugged at a proffered cheque and said “Ma l’Austria non c’è più”, and the famous poet’s mistress, hysterical, the wireless screaming among her English chintzes under the huge di Chirico (ruins and faceless figures) said “We are waiting to hear the bombers”, and the gentle devout official Englishman had written in praise of the régime, and one of the dissident professors was turning in his regular weekly report to the police? In Cambridge there was Auden reading his Spain – (there had been Spain for so long): “Tomorrow the bicycle races / Through the suburbs on summer evenings: but today the struggle… We are left alone with our day, and the time is short and History to the defeated / May say Alas but cannot help or pardon”. And in the same house an Austrian who every evening required consolation for the fresh insults and persecutions he found during the day and whose father, mother, fiancée and furniture had, somehow, to be got out of Vienna.
This bit of curriculum vitae is here only for one reason: to remind ourselves, for the record’s sake, of that context into which came the encounter with Saxl, the Warburg Institute, Dulwich and Bing (and my first memories of Bing are mostly linked with Dulwich).That encounter was part, emphatically, of growing up in the thirties, of being twenty-four in 1939. Excitement and acceptance, curiosity, and the limits of that curiosity, were part of that liquid world of presages and dooms, migrations, transitions, exiles, and surprise behind the suburban door. Saxl’s greatness – I would still use the word – and fascination, and all that Institute and library had to offer would have been less powerful but for the ways they went with that situation. There was newness and a grateful surprise, and a kind of familiarity: all combined, so that books and scholarship and persons and places all went together in one experience. Brought up in schools of literature in the traditions of nineteenth-century ‘positivist’ history, and in the polemics about the ‘new criticism’ (of which I was already tired: though much in their debt) much concerned (as we already were) with the ‘image’, and not happy about the ways we had of talking about it: most interested in that and in the new ‘history of ideas’, which was coming to the schools from – mostly and directly – America – and not very happy about that either; and deeply involved with Italian things (and in Italy offered Croce, when I much preferred Marx) – I was very ready for the library and for Saxl.
Strict methods of historical enquiry, I had, after all been taught, and well taught. What was new was the kinds of texts and documents, the juxtapositions of material that were offered (that startling arrangement of the library), new kinds of questions. All this reinforced by the mere physical presence of those books, and those people. Exiled scholars, yes, I was familiar with, scholars, intellectuals, poets, moving: but here, part of, but standing against the flow (in those hideous rooms, in that monstrous derelict Imperial monument, beside the point even when it was put up), was a whole great chunk of inventive Europe, carrying both present and the infinitely complex past that made it. Here were dramatized the flux, the precariousness, the dangers: in this familiar, when the unexpected and the provisional were what you lived with: at the same time solid, an environment you could work in, without drama, except the drama of new books and new questions, the wished for drama you had been brought up for. Here was, more valuable at that moment, almost, than anything else, the example of persistence: persistence, in reading, in asking, in working. An example more valuable than I, and many more, found in Cambridge, where persistence too often was only blandly unexamined habit or a determined parochialism, better calculated to affront than fortify the young; where gardens and buildings spoke with a more moving voice.
The solidity was, of course, an illusion, a master-conjurer’s piece of sleight-of-hand, or mimetic magic which had to be there before the reality could follow. It corresponded to something in the natures both Bing and Saxl; and was conjured up in Dulwich too. Bing spoke of Saxl’s elusiveness, his acceptance of the provisional, his wish to be free: and indeed the image of the wanderer was characteristic of him: yet, and always yet, there was that garden designed and planted and cherished not for this season’s flowers but for a maturity that would take years to come. I must have been invited to Dulwich perhaps the second time we met. W. B. Yeats said of the staircase of a sufficiently unassuming country house that Balzac would have taken a hundred pages to do it. Several histories might be made from descriptions of the contents and arrangement of that high, ugly, narrow, commonplace affair in its anonymous street. But no one can write them now. There was a time when one could not ask questions; and a time when one forgot to because all had become so familiar. At that time what impressed was the combination of austerity and miscellaneous and downright clutter, of ‘advanced’ and bourgeois, and Saxl’s magpie’s nest accumulations (which he did like to talk about). Saxl liked the humble, the forgotten object, not out of any cult of the ‘peasant’ or the neo-primitive, but because they were fragments of a large history, touching evidence of the survival and durability of large images and schemes (like the piece of Indian cotton on the wall behind the divan in the garden-room which he bought, Bing told me, because he saw in it a last and true descendant of late antique models). I am not sure how much of all this really corresponded to Bing’s taste; I think that an environment she had herself created might have been more austere: there was the contrast between the room she first lived and worked in (the great black desk) and the clutter of Saxl’s study; the black Sung vase was what she wanted. And in the event, though she loved both Rome and Venice it was Florence she always wanted to go back to.
Bing certainly accentuated, memory insists, one of the notes struck by both Institute and Dulwich, in those early visits: this was, to put it plainly, alarm. There was the terrible problem of living up to Saxl. My first series of what turned out to be intensive tutorials with Saxl went on there at intervals until the summer of 1940 – sessions when Bing poured coffee that got colder and colder (I remember wondering whether cold coffee was a German habit, or just an idiosyncrasy of the house) and that lasted long after she had gone to her room, and meant that what few hours were left of the night were mostly sleepless. (Anyhow there was the problem of the plumeau, which I first met then, and never could be happy with.) But if Saxl alarmed me, Bing frightened me. She was the image of severity: in what seemed a recognizable way; dark cropped hair, the endless cigarettes, the dark austere clothes, the use of surnames, her quickness, the sharpness of her questions: all to me, even at that age, suggested the advanced woman of the twenties. That she had ever carried a red flag is probably an embroidery of mine, though I think a pleasing one: that she had participated, on the side of the left, in political disturbances in Germany at the end of the first war is certain: she recalled this and her ‘revolutionary youth’ with amusement but no displeasure. Whatever the scope of her beliefs and activism may have been, those first impressions of mine were not wholly wrong. Something of the air of that generation of women Bing had with her to the end. With the years, of course, the manner relaxed; and the image of severity receded to be replaced by that general aspect of benignity which accompanied the very marked changes in her appearance in late middle age and in old age. The wheel seemed to have come full cycle when a pupil of mine who met her, in an unofficial context, about a year before her death said to me afterwards, “What a dear old lady”.
I was hard put to it to respond. Bing was benign, it is true, and very kind to personable, intelligent young men who responded quickly and sensitively but did not talk too much, and very ready, now, to amuse and be amused, yet even so I could hardly believe that an hour’s conversation could yield that particular English cliché, with suggestions so wholly inapposite that I was jerked at that moment into realizing a world of language and experience which I could not possibly fit Bing into, which was neither hers nor mine.
Not the greenest of gardens or the stillest English suburbia could accommodate her to it (and yet the young man was by no means obtuse). Some note of the stern, of the fierce, even, was still needed for definition in that benign old age; and some phrase, if it could be found, that insisted on the not-English. (My ear suggested that part – symptom and cause – of the ‘slowing down’ apparent towards the end of her life was linguistic, that the language came less readily.) Her capacity for scorn was undiminished, though it had been increasingly linked with an appreciation of the absurd, the simply comic, in human behaviour. Scorn for bureaucracies, ‘establishments’, machines, pretences, social and intellectual, for talents corrupted for money or advertisement: of, and always, disloyalty; and that apart from the great treacheries of the thirties, which she never forgot. (Often harsh judgements would be mitigated by memories of conduct during those years.)
A continuous moral energy was one of the sources of her strength. To miss this would be as wrong as to envisage her as continually sitting in judgement. The image that memory insists on of Bing behind a desk or a table does not mean that; any more than it implies the simple notion of a managing woman of that particular generation. Manage she could and did, and had to. But she did not always want to. Beyond a certain point she was not willing to make people’s decisions for them; or to judge. It is here that her famous phrase – uttered in whatever language was appropriate – comes in. “Why not”, she would say, or “There is no law that says you must”. She was recalling you to the concreteness of the moment: to your freedom (and your duty) to decide: and she could apply it to herself: “After all, why not” is what she said that evening when she decided to open up Saxl’s study and sit there after dinner (his pipes were still on his desk, and the copper cooking pot he used as a tobacco jar). Empirical and pragmatic, she distrusted large formulations about history or experience or conduct, and all ‘over-interpretation’, whether of a text or an image of a situation. Her attention to a manuscript was of a piece with her attention to a situation. Reason and the plain facts (as far as they could be ascertained and exotic as they might turn out to be); and elegance (as the mathematicians understand it) of exposition and expression, were what she wanted you to arrive at. Not that ‘rationalist’ describes her.
The sources of that memorable fortitude must elude us: but a belief that reason, truth and justice will prevail was not among them; nor any belief in a final ground of reason or divine unreason. I do not think the world made much sense to her, and certainly no transcendental sense (“That way is closed to us”, she said firmly, sharply refusing a discussion). She knew about the limits of reason in human affairs. Her life had brought her to know, poignantly enough, haunted minds and to watch the anguish of the irrational; and in such situations she was perceptive and strong. Yet I have the feeling that it was all alien to her and that, though she knew, she never very willingly admitted that sometimes the wound had to go with the bow. Preoccupation with the irrational worried her. Some years ago when I was immersed in the world of magic and the ‘little religions’ in the eighteen-nineties she rebuked me for spending so much time on ‘nonsense’; and reacted very sharply when I suggested that such concern for the symbol in Europe in that time, in that half-world, must have had something to do with the formation of Warburg and the direction of his enquiries. This point she was, latterly, willing, and quite equably, to concede ; but she still preferred to consider, for example, Darwin (she developed a great enthusiasm for The Expression of the Emotions in Man and Animals). Distaste remained. She would have liked to see more sense.
Only in her last year did I hear her complain she was bored. My surprise at the time seemed disproportionate: yet, thinking back, I was right to be disconcerted. With Bing this was very serious. That she had ceased to take or read the newspapers, mattered little: many younger than herself were in the same position (“What law is there that says…”). While many too shared her dislike of much that is happening in the academic world and her fear that we are in danger of forgetting what we are supposed to be doing, of the erosion of traditional fields of knowledge and modes of enquiry (she had now evolved a formula to preface news of a piece of work that interested her: “If it is important for anyone to know, then…”). A general complaint about being bored was something else. Because the point about Bing is that she was not bored. Exhausted at times, oppressed, worn down at times (even she), bored often enough and indignantly enough on particular occasions, but not radically bored. The centre of her strength, of that moral energy and critical power, and defining their range and application, was, I suppose, here: in, but the words are vague, when what is wanted is the opposite of vagueness, and definition by contraries would be easier, a continuous unintermittent sense of life: of here and now, place and time, of being here, past precipitated in present. The actual world was endlessly real to her: a multifarious world of individuals and their experiences and what they make and the various surface of the solid earth they live on. It is a very rare gift. Hence the vivid eagerness and curiosity that we are going to miss so much. This grasp showed in many ways. In, for example, her remarkable power of feeling and evoking place, shape and colour in landscape or city. Or in, I think, her preferences in literature and marking perhaps their limits (of all my early friends at the Warburg Institute only Bing had a real care for modern literature; Saxl said his favourite novel was the Hypnerotomachia, which was, I am sure true, but hardly helped). With the literature of the twentieth century her sympathies were imperfect, and in what written in English that has most engaged us she was little interested (except Conrad and some Forster), but in German there was Thomas Mann (Hofmannsthal she detested, and she did not greatly care for Rilke: about Kafka she was apt to shrug her shoulders); in the nineteenth century, there was Dickens, whom, after Shakespeare, she most admired of English writers, there was Zola (an admiration of her later years which I did not share) and, perhaps first, Ibsen, to whom she had a true devotion (you would hear in the theatre the explosive “ach!” that came when she was deeply moved). What she was looking for, I think, was boldness of search and execution, a substantial rendering of milieu, psychological veracity. “Solidity of specification” she was after, in Henry James’s phrase – not that she would have anything to do with him.
One could turn the phrase this way and that. And, returning to Dulwich in 1939-40, ask again, why ‘solid’ seemed, paradoxically, in that fluid world, a word for it. This did not have to do only with the completeness of the milieu: that might just as well have emphasized exile and transit, as other ‘refugee’ houses and flats crammed with furniture from Germany and Austria did; that Saxl and Bing were stretched at work had much to do with it, but how was it that they had been able to make this transfer? That they had already been here for six years was little to the point: others in that position had not managed (and many never were to). The upshot of all this is, of course, that, it is clear now, I never thought of Saxl and Bing as ‘refugees’ at all.
The unmistakable smell of exile was never in that house. Basic for the making of house and garden as for the establishment of the Institute in working order was Saxl’s ‘inspired opportunism’, and this was not unconnected with his gifts and goals and methods in scholarship, with his apprehension of the ‘moment’, and also Bing’s patience (which she had had, perhaps, to learn) and closely related sense of the actual. Not exiles, but not English. I could accept them, the house, the Institute (ignorant, and to remain so, of so much of what lay behind in Bohemia, Vienna, Hamburg or Brunswick) as part of an experience of Europe that was urgent and necessary. The words may be too big. Saxl and Bing came increasingly to hate big words like ‘Europe’, ‘the West’, ‘tradition’, ‘international’ because of the uses they were put to, the pretences, falsities, trivialities or worse they masked, yet, with every hesitation, the word Europe and the word tradition (however imperfectly understood) will suggest themselves in connexion with her as meaning something real and tangible and experienced, for enrichment and strength as well as suffering, and wholly necessary: and here when she was here. And Bing (however – or, for all I know, because – remote and secret so much of her life) was always here. That is why the images of desks and tables offer themselves, and what they really suggest. The world was actual to her and she was actual. Most of us are present only by fits and starts, intermittently; Bing (whatever the cost) was always, incontestably, here. Dialogue with her guaranteed, not safety, not comfortableness, but actuality, of moment, of experience, of tradition, community.
Gertrud Bing, Donald Gordon, e il giardino di Dulwich
Chiara Velicogna
Entra in gioco un particolare genere di ironia se, nel presentare la traduzione italiana di questo omaggio In memoriam di Gertrud Bing, si rileva che il suo autore Donald James Gordon, uno scozzese “italianato” (così definito da Luigi Meneghello 1997, 81), è attualmente poco noto nel nostro paese. La modesta pubblicazione commemorativa del 1965 in cui il saggio è inserito e di cui costituisce l’unico contributo originale è già stata analizzata in “Engramma” (Centanni 2020); questa breve postfazione vuole essere anche la ricostruzione di una sorta di caccia al tesoro, da Dulwich a Reading passando per Firenze e Malo, per dare conto sia della figura dell’autore sia del suo rapporto con Bing.
Occorre fare un primo passo indietro, all’In memoriam che Gertrud Bing scrive a seguito della morte di Saxl nel 1948, pubblicato nel 1957 in apertura della raccolta di contributi dedicata a Saxl e curata dallo stesso Gordon. Si tratta di un lungo saggio biografico, nel quale Bing ripercorre cronologicamente la vita dello studioso, intersecando gli aspetti personali a quelli professionali, mettendo in luce l’attività intellettuale, il metodo, l’approccio sia di Saxl sia di Warburg. Circa una decina di anni dopo, Gordon affronta il tema dell’omaggio all’amica in modo all’apparenza diametralmente opposto, in maniera diacronica, per dettagli, per allusioni e per sottintesi: ma sono proprio questi ultimi ad aprire squarci sulla vita di Bing, oltre che dello stesso Gordon. La divergenza tra i due saggi è solo apparente: l’ultima parte del ricordo di Saxl scritta da Bing abbandona il tono biografico e adotta uno stile più personale
It must be admitted that he did not keep to the rules; he lacked the proper respect for conventions; the claims of institutional authority exasperated him; and he especially disliked being tied down to any expected course of behavior; why should conditions that fitted yesterday set tomorrow’s standards? (Bing 1957, 37)
Nel suo omaggio a Bing, Gordon sembra a tratti voler ricalcare lo stesso stile sincopato, ricorrendo agli stessi brevi periodi, separati dal punto e virgola, in cui Bing condensa il carattere di Saxl:
Scorn for bureaucracies, ‘establishments’, machines, pretences, social and intellectual, for talents corrupted for money or advertisement: of, and always, disloyalty; and that apart from the great treacheries of the thirties, which she never forgot (Gordon 1965, 18).
Chi era, però, Donald James Gordon? Poco si ricava dalla asettica voce del Who’s Who britannico (Who’s Who 2007), ma un’altra, più vitale, voce è quella di Luigi Meneghello. Lo scrittore vicentino, infatti, aveva ottenuto nell’immediato Dopoguerra un posto all’Università di Reading, dove aveva fondato, alcuni anni dopo, il Dipartimento di Italian Studies sotto l’egida proprio dello studioso scozzese. Meneghello considera Gordon un (se non il) mentore dei suoi anni inglesi, “una sorta di bizzarro Santo patrono dei nostri Studi Italiani” (Meneghello 1997, 19), e scriverà nel 1977 un in memoriam dello studioso britannico apparso sull’“Osservatorio Olimpico” e ripubblicato in La Materia di Reading (Meneghello 1997, 81–88); ma soprattutto ne fa rivivere la figura brillante ed eccentrica, per aneddoti e dettagli, in molti dei suoi scritti.
Gordon, scozzese di nascita, si laurea in Letteratura inglese a Edimburgo (ed è qui che nel ’33 sostiene l’esame per la borsa di studio citata nel testo) per poi proseguire con il dottorato al Trinity College di Cambridge (1941). Meneghello fa risalire al periodo delle ricerche dottorali il contatto con l’ambiente del Warburg e l’incontro – si immagina folgorante – con Saxl e Bing; nel testo, infatti, Gordon allude alla minuscola stanza di Gertrud Bing all’Imperial Institute, che verrà evacuato per timore dei bombardamenti nella primavera del 1941. La biblioteca è momentaneamente trasferita in un rifugio poco fuori Londra, a Denham, ed è probabile che Gordon fosse nel novero dei “many friends, and casual acquaintances who became friends, gathered on summer evenings in the garden, and used the spare rooms to rest in from the bombing of London” (Bing 1957, 30)
Gordon, all’epoca venticinquenne, era da poco rientrato da un soggiorno italiano a Firenze: è proprio questo il semestre evocato nel saggio e definito propedeutico all’incontro con Saxl, Bing e il Warburg Institute, nel corso del quale aveva frequentato l’ambiente letterario di opposizione al Fascismo, stringendo amicizia con vari intellettuali fra i quali anche anche Eugenio Montale (Meneghello 1997, 84). La ricostruzione della fitta rete di intrecci e conoscenze attorno alla figura di Gordon ha permesso di cogliere in parte alcune allusioni presenti nel testo dedicato a Bing: l’amante del “famous poet” è con tutta probabilità Irma Brandeis, amante e musa di Montale; l’amico in fin di vita di Oscar Wilde è quasi sicuramente Reginald Turner, morto a Firenze nel 1938; un dimenticato piccolo uomo che narrava delle serate passate in compagnia di Kafka a Praga potrebbe essere Max Brod, l’esecutore testamentario dello scrittore ceco che sarebbe da lì a poco fuggito in Israele; va da sé che il poeta americano definito “il miglior fabbro” è Ezra Pound. Altre allusioni rimangono troppo vaghe per essere sciolte con un minimo grado di certezza, là dove l’intento dell’autore sembra piuttosto essere quello di dipingere a grandi tratti un quadro generale del clima, intellettuale e umano, di Firenze in quegli anni.
Il fluire del racconto e il tono del ricordo di Gertrud Bing lo rendono quasi più affine a un monologo teatrale che a un testo destinato alla lettura, e ben si allineano con la personalità di Gordon, che Meneghello chiama ‘Sir Jeremy’ in Il Dispatrio:
Peso non di rado opprimente della compagnia di Sir Jeremy. Non si poteva parlare “con” lui, neanche “a” lui, solo nella sua direzione, e non serviva a molto. Se per un istante si creava un contatto, un passaggio di cose umane, ne nasceva una vaga reazione di imbarazzo, quasi di ribrezzo… Meglio tornare al tedio della non conversazione. Strano: era certamente tedio, ma non era vera noia, anzi. Era un tedio stimolante (Meneghello 1993, 56).
Gordon sembra parlare ‘nella direzione’ del lettore, entrando in medias res, riconoscendo il limite di una interlocuzione, pur intima e intensa, quando ammette che di Bing, nonostante i trent’anni di amicizia, sapesse soltanto ciò che lei aveva consciamente deciso di rivelare. La questione linguistica e la casa a Dulwich sono co-protagonisti di questo scritto e rappresentano il mezzo attraverso il quale Gordon traccia poco a poco il ritratto di Gertrud Bing. La lingua inglese abbraccia anche una serie di abitudini, costumi, attitudini che l’espatriato più o meno consciamente adotta nell’ambientarsi a un nuovo contesto: nel disprezzo di Bing per chiunque volesse indossare questa maschera Gordon riconosce un rapporto ambivalente e complesso, un “compartimento stagno” che includeva persone, luoghi, relazioni, completamente separati dall’altro compartimento, quello “tedesco”.
Il giardino all’inglese della casa di Dulwich appare nelle parole di Gordon una terra di confine, che nell’immaginazione di Bing è trasfigurato in un paesaggio italiano: un luogo intrinsecamente inglese nelle sue caratteristiche e nelle intenzioni dei suoi creatori, ma al contempo senza patria; non mero sfondo ma luogo vivo, nel quale si superano diffidenze linguistiche, si stringono relazioni durature. Non è chiaro a quale giardino, se quello di Denham o di Dulwich (o forse entrambi?), si riferisca Bing in una lettera del 1942 a Edgar Wind, il giardino dal quale il circolo warburghiano aveva tratto forza e sostentamento negli anni di guerra:
We are all busy working in the garden in our spare time, and besides making us independent of green-grocers and nurserymen this had a very good effect on the team spirit and general temper of the community (cit. in Takaes de Oliveira 2018).
Ben lontano dall’essere un luogo contemplativo, il giardino a Dulwich (un lotto rettangolare contornato da alberi) appare un luogo di incontro dove il gruppo di studiosi dell’Istituto Warburg in Inghilterra costituisce una vera e propria comunità. Gordon, inoltre, restituisce con visione acuta un ulteriore parallelo, quello tra casa e giardino e tra lingua tedesca e lingua inglese: là dove lo spazio esterno, naturale, è volutamente inglese anche se mai abbastanza ‘naturale’ e incolto, gli interni della casa non lo sono né diverranno mai (ma senza mai essere nemmeno totalmente tedeschi), tanto quanto la vita inglese e la vita tedesca di Bing rimarranno due poli opposti, tenuti per lo più separati, dove il secondo è collegato a una dimensione privata, di interiorità. Il giardino, nella cui presenza nel ricordo di Bing si può leggere anche un'allusione al giardino veneziano di Palazzo Soranzo Cappello in The Aspern Papers, accoglie numerosissimi visitatori già illustri – o che lo diventeranno – come Pevsner, Baxandall, Wittkower, Kitaj (che abitava anch'egli a Dulwich, nelle vicinanze), Meneghello, e proprio quest’ultimo ricorda:
[…] una memorabile visita alla casa di Saxl e della Bing che vivevano insieme, e di un lungo giro per Londra con loro, le zone orientali e meridionali di Londra, fino a Greenwich, a vedere un luogo e un momento cruciale per la trasmissione della cultura del nostro Rinascimento, la Queen’s House, la casa della Regina a Greenwich. Fu una specie di rivelazione per me, e sono memorie vivissime.
Nella sua biografia di Nikolaus Pevsner, Susie Harries riporta l’apertura e accoglienza del mondo intellettuale che si raccoglieva a Dulwich:
It was known in the emigré world as ‘the elastic house, because there was always room for still another refugee’ (Harries 2011, 148).
Gordon tuttavia rifiuta abbastanza drasticamente la definizione di casa di rifugiati, come altre ve ne erano in Inghilterra in quel periodo: la casa di Dulwich non è né tedesca né inglese, e tuttavia è un ambiente solido in un mondo fluido fatto di personalità in transito (per molti l’Inghilterra sarà solo una tappa intermedia). Anche Max Warburg sembra aver trascorso qualche tempo ospitato da Saxl e Bing, come testimonia una lettera inviata a Bertolt Brecht (Haarmann, Hesse 2014, 640) nel 1937 da 162, East Dulwich Grove: a questo indirizzo casa e giardino esistono ancora, come pure i campi da tennis separati da un filare d’alberi.
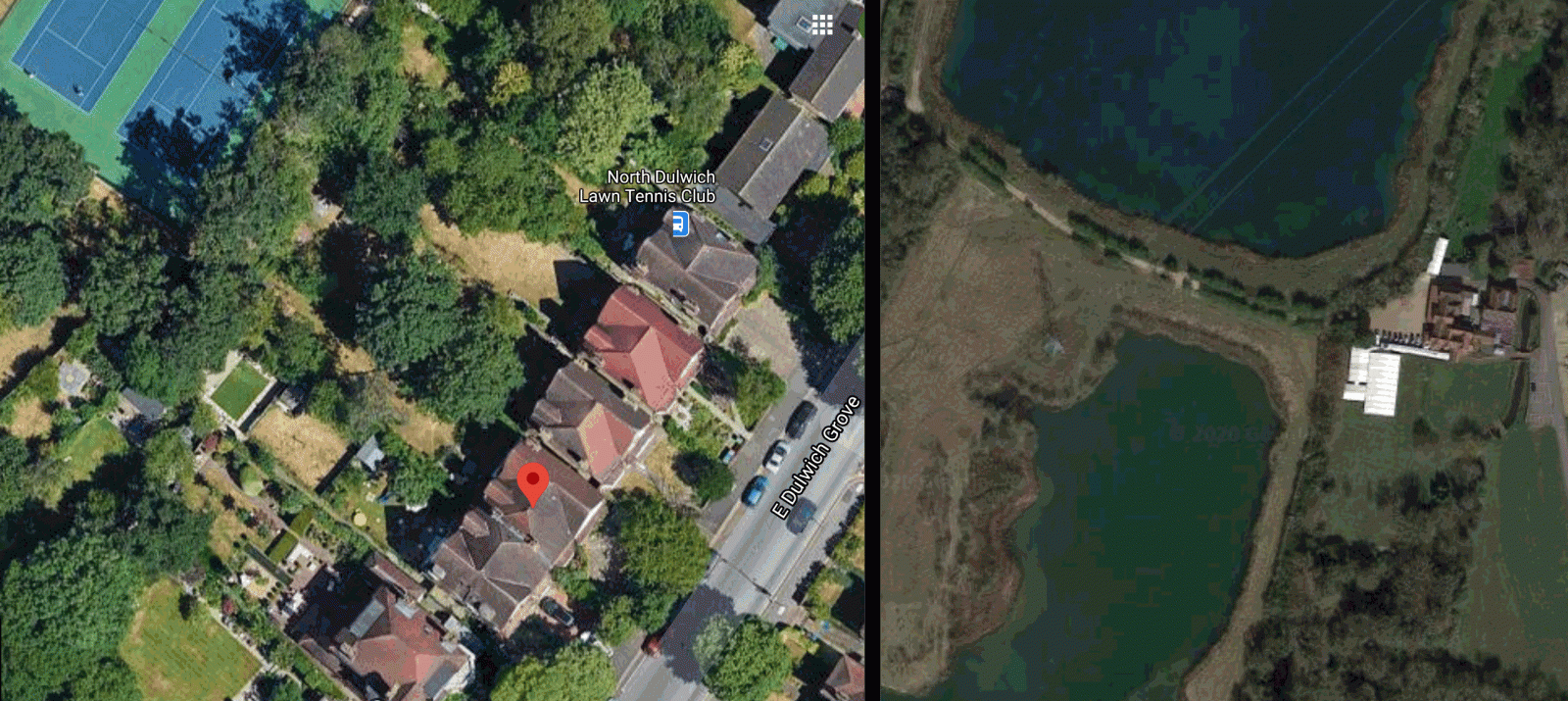
A sinistra, la residenza a Dulwich di Bing e Saxl. A destra, il riparo temporaneo a Denham della Biblioteca Warburg
Michael Baxandall definisce questo testo di Gordon come di gran lunga il migliore ricordo di Gertrud Bing (Baxandall 2012), e sottolinea come Gordon abbia colto e saputo esprimere un sentimento comune a molti degli amici di Gertrud, dopo la sua morte: ossia che poco o nulla si sapesse della sua vita pre-Warburg, e che tenesse le sue amicizie in compartimenti stagni. Il ricordo di Baxandall riprende quello di Gordon e allo stesso tempo gli è complementare, confermando alcune immagini (come quella di Bing seduta sempre a una scrivania) ed espandendone altre, familiari e domestiche: come Bing desse completa attenzione al suo interlocutore, e come, in un momento prezioso della giornata, al termine della cena, finito il dessert e la conversazione, si iniziasse davvero a parlare ed emergesse un suo lato più privato, allo stesso tempo indiscreto e distaccato. Allo stesso modo, nella narrazione di Gordon, sembrano esistere due Gertrud Bing, una ‘pubblica’ e una ‘privata’, riservata agli amici più stretti. Baxandall sottolinea anche, in maniera meno criptica di Gordon, la forza della personalità di Bing, la sua risolutezza nei confronti delle avversità:
To some extent she too moved like someone who had moved through dark and real dangers, but someone who had decided long ago to tough it out. She seemed to travel very resolutely through an only provisionally friendly territory (Baxandall 2012, 25).
Che Bing avvertisse l’ambiente intellettuale in cui viveva come inaffidabile e solo parzialmente amico (un fatto riflesso dalla modestia della commemorazione dedicatale dal Warburg Institute al quale aveva dedicato la vita) ha una conferma nelle sue preoccupazioni per le sorti del Warburg Institute una volta dimessa da direttrice e lasciato il posto a Ernst Gombrich. I ricordi di Gordon e Baxandall, in questo senso, restituiscono la personalità di Gertrud Bing nel suo acume e nella sua forza intellettuale, nonché nel suo ruolo fondamentale per la storia dell’Istituto Warburg, dal trasferimento della Biblioteca Warburg da Amburgo a Londra fino all’insediamento del Warburg Institute a Woburn Square che avviene, non casualmente, nel 1958, ossia negli anni della direzione Bing.
Gordon ricorda Bing senza quasi mai parlare di Warburg, la cui figura appare solo in forma di busto sulla scrivania. Gertrud Bing è perno della narrazione, punto fermo (e severo) in un flusso di coscienza che coinvolge numerose polarità: l’Inghilterra, la Germania e l’Italia, l’Università di Cambridge e il Warburg Institute, la lingua inglese e quella tedesca, la casa e il giardino, il mondo esterno e quello interno. A questa commemorazione, poetica ed accorata, speriamo di avere reso sufficiente giustizia con questa nuova edizione e prima traduzione in lingua italiana.
Si ringraziano Elisa Bizzotto e Massimo Stella per il preziosissimo e preciso aiuto nella preparazione della presente edizione e traduzione.
Note
[1] W.H. Auden, Spagna 1937, traduzione italiana di Nicola Gardini (Auden [1940] 1997, 171-173)
[2] Saxl stesso si era definito così in una delle ultime conferenze prima della sua morte nel 1948: l'episodio è citato da Bing nel suo saggio commemorativo di Saxl (Bing 1957, 46) che Gordon riprende.
Riferimenti bibliografici
- Auden [1940] 1997
W. H. Auden, Un altro tempo [Another time, London 1940], traduzione di Nicola Gardini, Milano 1997. - Baxandall 2012
M. Baxandall, Is durability itself not also a moral quality?, "Common Knowledge" 18 (2012), 22-31. - Bing 1957
G. Bing, Fritz Saxl (1890 - 1948): A biographical memoir., in D. J. Gordon (ed.), Fritz Saxl, 1890-1948; A volume of memorial essays from his friends in England, London 1957, 20-46. - Centanni 2020
M. Centanni, “Purtroppo non abbiamo trovato molto tra le carte della nostra cara amica Gertrud Bing che si potrebbe salvare”. Testo e contesto di Ernst Gombrich, Lettera a Delio Cantimori, 29 ottobre 1964, “La Rivista di Engramma” 171 (gennaio/febbraio 2020). - Gordon 1965
D. J. Gordon, In memoriam, in E. Gombrich (ed.), Gertrud Bing: 1892-1964, London 1965, 11-22. - Haarmann, Hesse 2014
H. Haarmann, C. Hesse, Briefe an Bertolt Brecht im Exil (1933-1949), Berlin 2014. - Harries 2011
S. Harries, Nikolaus Pevsner: the life, London 2011. - Meneghello 1993
L. Meneghello, Il dispatrio, Milano 1993. - Meneghello 1997
L. Meneghello, La materia di Reading e altri reperti, Milano 1997. - Takaes de Oliveira 2018
I. Takaes de Oliveira, “L’esprit de Warburg lui-même sera en paix”. A survey of Edgar Wind’s quarrel with the Warburg Institutewith: Appendix of Warburgkreis’s correspondence, “La Rivista di Engramma” 153 (febbraio 2018). - Who’s Who 2007
Gordon, Prof. Donald James, (19 July 1915–22 Dec. 1977), FRHistSoc; Professor of English in the University of Reading, 1949–76, now Emeritus, in WHO'S WHO AND WHO WAS WHO, Oxford University Press 2007.
English abstract
Donald J. Gordon’s memoir of Gertrud Bing, first published in 1965 in a commemorative volume published by the Warburg Institute, is presented here in its first Italian translation. The text is accompanied by an afterword by the translator that sketches a brief portrait of the author, traces some of the themes and provides context to the allusions present in the text.
keywords | Gertrud Bing; Donald James Gordon; Dulwich.
Per citare questo articolo/ To cite this article: D. Gordon, In memoriam Gertrud Bing, traduzione e postfazione a cura di C. Velicogna, “La Rivista di Engramma” n. 177, novembre 2020, pp. 131-165 | PDF of the article