“Ah, sistema di segni / escogitato ridendo”
Pier Paolo Pasolini, Poesia in forma di rosa, 1963
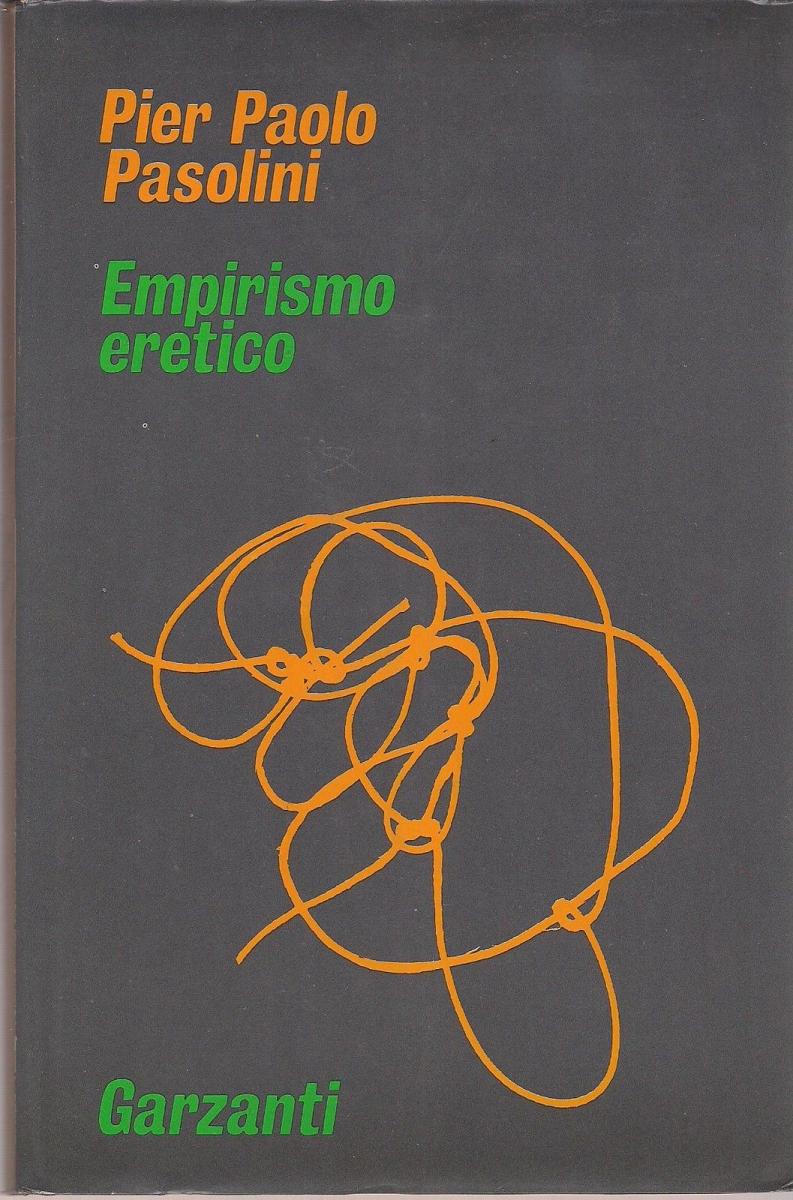
1 | la copertina della prima edizione di Empirismo eretico
Una singolare equivalenza
È nota l’equivalenza – originale, provocatoria, indisciplinata, curiosa – proposta da Pier Paolo Pasolini: così come la scrittura ripresenta l’oralità, il cinema restituisce la realtà. Quattro termini vaghi – ‘scrittura’, ‘oralità’, ‘cinema’ e soprattutto ‘realtà’ – che rinviano a concetti fortemente problematici, ma che, nel loro articolarsi reciproco, trovano una qualche luce, un più preciso significato. Dalla prima proporzione ne discende difatti un’altra: il cinema sta alla scrittura come la realtà all’oralità. Ne deriva la celebre ipotesi teorica per cui il cinema sarebbe la “lingua scritta della realtà”. Dibattiti senza fine, lunghe perplessità, precisazioni scolastiche, scomuniche senza appello: nei confronti di uno dei pochi scrittori/cineasti che si aprono senza remore, e con enorme creatività, alla linguistica e alla semiotica, la teoria dei segni e dei linguaggi, della comunicazione e della significazione risponde accigliatamente, tacciando l’ipotesi pasoliniana di ingenuo naturalismo. L’unico ad arruolarlo nell’esercito irregolare della semio-linguistica sembra sia stato invece un pensatore come Gilles Deleuze; il quale, coniugando a suo modo teoria dei segni e linguaggio filmico, ritrova in Pasolini un appoggio, se non costitutivo, comunque essenziale per la sua filosofia del cinema. E la cosa sembra essersi chiusa così. Potrebbe essere arrivato invece il momento di tornare sulla questione, rileggendo l’apporto di Pasolini alla semiotica dell’immagine e del cinema, dell’immagine cinematografica, alla luce degli sviluppi e degli esiti della semiotica stessa come anche, più in generale, di quella che, per momentaneo amore di sintesi, potremmo chiamare l’epistemologia delle scienze umane. Partiremo perciò da una rapida ricostruzione della controversia d’allora, per giungere ad alcune problematiche dell’attuale congiuntura socio-culturale[1].
Pensieri e parole
In un saggio del ’66 intitolato Il cinema di poesia, Pasolini avvia la propria riflessione a partire da una constatazione: la lingua letteraria poggia la sua inventività – insieme stilistica e semantica, dunque storica e politica – sulla lingua comune quotidiana, trasformando quello che è uno strumento di comunicazione in un prodotto estetico. Il cinema, invece, non si ritrova bell’e fatti un lessico e una grammatica dai quali, analogamente, erigere il proprio linguaggio. Ciò che ha a disposizione è il serbatoio caotico di immagini dell’esperienza quotidiana, già dotate di un proprio significato, che riadatta a suo modo. Tali immagini possono essere dei più diversi tipi: innanzitutto legate alla fisiognomica e ai gesti, alla mimica facciale e somatica, ma poi anche le azioni e i comportamenti, in sé fortemente significativi, per non parlare della miriade di segni e segnali che l’ambiente ci rimanda, e per giungere a tutti quegli “oggetti e cose che si presentano cariche di significato e quindi ‘parlano’ brutalmente con la loro stessa presenza” (Pasolini [1966b, 1972] 1999, 1463).
A costituire un tesoro semiotico per il cinema sono inoltre tutti quegli elementi che provengono dalla memoria e dal mondo dei sogni, anch’essi stracarichi di immagini significanti (che Pasolini, con una qualche inventiva metalinguistica, chiama “im-segni”): “ogni sforzo ricostruttore di memoria è un ‘seguito di im-segni’, ossia, in modo primordiale, una sequenza cinematografica”; “ogni sogno è un seguito di im-segni, che hanno tutte le caratteristiche delle sequenze cinematografiche: inquadrature di primi piani, di campi lunghi, di dettagli ecc. ecc.” (Pasolini [1966b, 1972] 1999, 1463). Tutto materiale “strumentale” che, come la lingua comune per la letteratura, costituisce una base, per quanto eteroclita e disordinata, ossia priva di regole grammaticali e istituzionalizzazioni del lessico, per il linguaggio che il cinema si trova a utilizzare.
Ora, dato che “non esiste un dizionario delle immagini” (Pasolini [1966b, 1972] 1999, 1464), il lavoro dell’autore cinematografico, secondo Pasolini, è duplice: deve innanzitutto ripescare dalla propria esperienza – individuale e collettiva – quelle icone che potranno essergli utili, inserendole in un proprio dizionario personale e dotandole di una qualche grammatica idiosincratica; solo successivamente costui può darsi all’invenzione stilistica e semantica.
Insomma, mentre l’operazione dello scrittore è una invenzione estetica, quella dell’autore cinematografico è prima linguistica e poi estetica (Pasolini [1966b, 1972] 1999, 1465).
L’ipotesi teorica di Pasolini è abbastanza chiara: il cinema è un linguaggio che si fonda su un linguaggio precedente, mettendo in moto ciò che, più avanti, potremo chiamare una traduzione; o forse, più esattamente, il cinema è un sistema di segni che erige se stesso a partire da un insieme (non sistematico) di elementi significanti che gli preesistono, e che si trovano già nella nostra esperienza quotidiana, dove vengono da noi usati come strumenti per orientarci, muoverci, interpretare, capire, vivere; dove svolgono cioè, molto semplicemente, la funzione di segni. Se non avessimo già una qualche idea del significato di una certa smorfia del viso, di un certo modo di camminare, di una certa organizzazione del paesaggio, il cinema non potrebbe comunicare alcunché. Esso è invece un linguaggio, perché affida la propria attività significante al fatto che tutto ciò, per noi, nel nostro vissuto, ha un qualche senso e un determinato valore.
Se questa idea ha dato adito però, come vedremo, a un certo numero di equivoci, e a una vera e propria levata di scudi da parte di semiologi e filmologi, è anche perché, con buona probabilità, la terminologia adoperata da Pasolini per illustrare quest’analogia zoppicante fra letteratura e cinema è assai variegata, piena di lessicalizzazioni azzardate, di espressioni infelici o, quanto meno, assai ambigue. Abbiamo già visto termini come “brutalmente” o espressioni come “in modo primordiale”; e nel saggio in questione leggiamo di “unico sistema di segni mimici come unico strumento umano di comunicazione”, “archetipi comunicativi naturali”, “comunicazione rozza, quasi animale”, “irrazionalistica”, “meccanica”, “elementare”, “sordo caos delle cose”; e ritroviamo anche termini fortemente connotati come “realtà” e “natura”. Sembra d’essere dentro una specie di psicologismo junghiano eretto a partire da una qualche forma di naturalismo positivistico. E su ciò insisterà, criticandolo fortemente, Umberto Eco (Eco 1968).
A rileggere con attenzione il saggio si comprende però che i presupposti epistemologici, neanche tanto impliciti, di Pasolini sono di tutt’altro genere. La ‘natura’ di cui si parla, infatti, non è qualcosa di separato dall’uomo ed esistente a prescindere da lui, la natura delle scienze della natura insomma; piuttosto, si tratta della naturalezza nel senso dell’abitudine, di ciò che accade per lo più, o se si vuole del senso comune. Leggiamo: “le immagini o im-segni […] sono patrimonio comune [...]; non esistono dunque, in realtà, degli ‘oggetti bruti’: tutti sono abbastanza significanti in natura per diventare simbolici (Pasolini [1966b, 1972] 1999, 1467)”[2].
Così, l’operazione dell’autore cinematografico è abbastanza chiara:
Egli sceglie una serie di oggetti o cose o paesaggi o persone come […] segni di un linguaggio simbolico che, se hanno una storia grammaticale storica inventata in quel momento – come in una specie di happening dominato dall’idea della scelta e del montaggio –, hanno però una storia pre-grammaticale già lunga e intensa (Pasolini [1966b, 1972] 1999, 1467; corsivi dell’autore).
La natura in questione è dunque già sempre una storia, pre-grammaticale ma comunque già all’interno di una qualche forma di cultura.
Lingua, cinema, realtà
Prima di rievocare le critiche che sono state avanzate a questa tesi, vediamo come essa è stata approfondita nel famigerato saggio del ’66 “La lingua scritta della realtà”, dove la pletora degli equivoci, già dal titolo, si arricchisce di ulteriori elementi. Anche qui infatti si parla molto di ‘natura’ e di ‘realtà’, ma leggendo bene è affatto chiaro che si tratta di entità già semioticamente formate. Scopo del saggio è quello di discutere l’idea di Christian Metz (1964) secondo cui il cinema sarebbe non una lingua (nel senso strutturale di un sistema di segni dotato di una doppia articolazione di fonemi e monemi) ma soltanto un linguaggio artistico; secondo Pasolini invece il cinema è una vera e propria langue, e ha pure una doppia articolazione, dove i cinèmi (corrispondenti ai fonemi della verbalità) sarebbero gli oggetti del mondo, mentre i monemi le singole inquadrature di tali oggetti. Se dunque secondo Metz la comunicazione cinematografica provoca un’“impressione di realtà” senza di fatto appartenervi, secondo Pasolini quella che viene investita dalla comunicazione generalmente audiovisiva è “una realtà tout court” (Pasolini [1966a, 1972] 1999, 1508).
Il saggio risente di questo tipo di tecnicismi – oggi ampiamente superati da una visione testuale complessiva del film e dell’esperienza cinematografica – e soggiace alla convinzione per cui l’immagine sarebbe un segno comprensibile a tutti e sempre, e dunque a sua volta “il cinema [sarebbe] una lingua internazionale o universale, unica per chiunque l’adoperi” (Pasolini [1966a, 1972] 1999, 1511) – idea anch’essa soggetta a forte revisione negli studi successivi. Si tratta di controversie teoriche e terminologiche assai sentite all’epoca, ma oggi del tutto ininteressanti. Quel che più importa, in questo saggio, è altro, e cioè l’idea che prima ancora della lingua verbale, anche nella sua versione orale, secondo Pasolini ci sarebbe un’altra lingua, quella dell’azione umana, che già di per sé ha una forma cinematografica: “la realtà – scrive – non è che del cinema in natura” (Pasolini [1966a, 1972] 1999, 1505)[3] . Dove tale ‘natura’, ancora una volta, non ha nulla a che vedere con quella che lo stesso Pasolini chiama “la realtà fisica” (Pasolini [1966a, 1972] 1999, 1505), volgendosi piuttosto verso l’esperienza vissuta, individuale come sociale. Il cinema, osserva Pasolini, “lo facciamo vivendo, cioè esistendo praticamente, agendo” (Pasolini [1966a, 1972] 1999, 1514). Da cui l’idea secondo cui
l’intera vita, nel complesso delle sue azioni, è un cinema naturale e vivente; in ciò, è l’equivalente della lingua orale nel suo momento naturale e biologico. Vivendo, dunque, noi ci rappresentiamo, e assistiamo alla rappresentazione altrui. La realtà del mondo umano non è che questa rappresentazione doppia, in cui siamo attori e insieme spettatori: in gigantesco happening, se vogliamo (Pasolini [1966a, 1972] 1999, 1514, corsivi nostri)[4].
E così come la tecnica della scrittura non fa che riafferrare l’oralità ‘naturale’ fissandola su carta, analogamente la tecnica cinematografica riprende – nel senso tecnico per cui ne fa una ripresa – il mondo umano già carico di significati e lo fissa nel film. Insomma, “il cinema non è che il momento ‘scritto’ di una lingua naturale e totale che è l’agire nella realtà” (Pasolini [1966a, 1972] 1999, 1514), di modo che il “linguaggio dell’azione ha trovato un mezzo di riproduzione meccanica, simile alla convenzione della lingua scritta rispetto alla lingua orale” (Pasolini [1966a, 1972] 1999, 1514)[5].
Le conseguenze teoriche, ma anche politiche e ideologiche, di questa idea, sono molteplici. Pasolini chiude il saggio sostenendo che “bisogna ideologizzare, bisogna deontologizzare”, combattendo “fino all’ultimo sangue” l’idea di una supposta “innocenza della tecnica” (Pasolini [1966a, 1972] 1999, 1540). Per quel che ci riguarda, scorrendo gli altri scritti pasoliniani sul cinema presenti in Empirismo eretico, appare curiosa, perciò avvincente, l’idea per cui, se il cinema scrive la realtà, da una parte, esso permette di “riscoprirla” (Pasolini [1966a, 1972] 1999, 1548), ossia di ridefinirla e interpretarla, e d’altra parte, un’analisi semiotica del cinema sfocia in una vera e propria “semiologia della realtà”: “il cinema, riproducendo la realtà, ne evidenzia la sua espressività, che ci poteva essere sfuggita. Ne fa, insomma, una semiologia naturale” (Pasolini [1966a, 1972] 1999, 1548). Da cui l’adagio “è la semiologia della realtà che bisogna fare”: “questo è lo slogan che vado gridando, fra me, da mesi” (Pasolini [1966a, 1972] 1999, 1543)[6].
Oltre natura e cultura
Come abbiamo detto, questa ipotesi di Pasolini ha ricevuto molteplici critiche, oltre che per ragioni relative alla terminologia tecnica della semiotica, adoperata con una certa esibita disinvoltura, soprattutto per quel che riguarda l’idea di sovrapporre il linguaggio cinematografico all’esperienza vissuta[7]. Per economia di spazio e tempo, possiamo qui evocare tali critiche ricorrendo alla sola voce di Umberto Eco, che in qualche modo le riprende e le sintetizza in alcune pagine de La struttura assente (Eco 1968)[8].
Quel che più disturba il semiologo è ciò che in qualche modo Pasolini presuppone nel suo discorso: la presunta spontaneità delle immagini, prive perciò di codici che le costituiscano e ne permettano il riconoscimento, di modo che la comunicazione iconica non sarebbe fondata su segni arbitrari, come quelli delle lingue, ma su significanti motivati da ciò che rappresentano (Eco 1968, 112). L’idea che l’immagine sia l’analogon della realtà è, secondo Eco, del tutto da rifiutare, in nome di una radicale convenzionalità del codice cosiddetto iconico. All’interno del grosso dibattito sull’iconismo che s’è sviluppato negli anni ’60 e ’70[9], la posizione di Eco – a quell’epoca (assai modificata in Eco 1997) – è tutta dal lato della culturalità dell’immagine. Motivo per cui egli ritrova in Pasolini “una discutibile nozione di ‘realtà’” (Eco 1968, 151) derivata da “una singolare ingenuità semiologica” che collide “con le più elementari finalità della semiologia”, consistenti nel “ridurre i fatti di natura a fenomeni di cultura, e non di ricondurre i fatti di cultura a fenomeni di natura” (Eco 1968, 152). Così, secondo Eco, quando Pasolini parla di un linguaggio dell’azione come linguaggio primo di tipo naturale starebbe dando del linguaggio gestuale una definizione scorretta perché dimenticherebbe che “i gesti sono altrettanti atti di comunicazione coi quali dico qualcosa agli altri, o dai quali gli altri inferiscono qualcosa su di me” (Eco 1968, 153), dunque prodotti della cultura e non elementi della natura. Di modo che “tutto l’universo dell’azione che il cinema trascrive è già universo di segni” (Eco 1968, 154).
Come si vede, Eco cade nell’equivoco generato per molti versi da Pasolini stesso, e legge i saggi pasoliniani sul cinema come esempio plateale di naturalismo spontaneistico. In realtà, l’idea che ciò che preesiste al cinema sia in sé significativo, che Eco rivendica, è proprio ciò che Pasolini porta avanti. E che ribadisce ulteriormente in un saggio del ’67, apparso per la prima volta in Empirismo eretico, intitolato Il codice dei codici, dove risponde punto per punto alle obiezioni di Eco, approfondendo al contempo la sua riflessione. Al di là delle critiche di ingenuità, che Pasolini rivendica anzi con convinzione (“che io sia ingenuo, non c’è dubbio […], e poiché non sono […] un piccolo-borghese, non ho paura dell’ingenuità” (Pasolini [1967, 1972] 1999, 1614), le argomentazioni pasoliniane riguardano due punti: l’accusa di naturalismo e quello che, usando una terminologia echiana, chiama Ur-codice.
Per quel che riguarda il primo punto, Pasolini ribadisce a più riprese che le sue tesi “intendono portare la semiologia alla definitiva culturalizzazione della natura” (Pasolini [1967, 1972] 1999, 1614), ma in modo ancora più intenso e radicale di quello proposto da Eco, ritrovando segni e linguaggi in qualsiasi entità della realtà sociale ma anche fisica e biologica. Secondo Pasolini – ed è il secondo punto – occorre prendere sul serio quello che Eco chiama “il sogno dello strutturalista”, quello di un “codice dei codici” che ci permette non solo di interpretare i segni che la realtà ci rimanda ma di ammettere che, se c’è una qualche realtà, è perché c’è una sua intrinseca segnicità che ci permette di conoscerla. Questo codice dei codici, o Ur-codice, in fondo, non sarebbe altro che il “codice conoscitivo della realtà” (Pasolini [1967, 1972] 1999, 1616) che consente agli oggetti, alle cose, alle persone di essere innanzitutto segni iconici di se stessi, portatori cioè di una semioticità visiva che permette loro di esserci, di esistere, e di essere riconoscibili come tali e, perciò, di divenire in seguito materia d’altri segni e d’altri linguaggi. Se possiamo spingerci verso “una totale culturalizzazione della realtà fisica e umana” (Pasolini [1967, 1972] 1999, 1617) è proprio perché ci sarebbe, per Pasolini, questo codice dei codici che sta alla base di ogni nostra azione e conoscenza.
Sembra insomma che, nella diatriba tra iconofili e iconofobi, come la definirà Eco 1997, Pasolini indichi una terza via, quella per cui le immagini sarebbero naturali, ma la natura sarebbe già in sé culturale. Ancora una volta Pasolini, con la sua proverbiale, rivendicata ingenuità, spinge la riflessione oltre sè stessa, là dove l’immaginazione teorica ha – con terminologia kantiana – una vera e propria funzione regolativa: porta il pensiero più avanti, anticipando ciò che altri semiologi come Algirdas Greimas diranno espressamente di lì a poco, e che ancora più avanti, e cioè da pochi anni a questa parte, è divenuta materia del contendere: l’oltrepassamento dell’opposizione fra Natura e Cultura. Già Barthes 1974 aveva descritto l’ideologia piccolo-borghese, quella che Pasolini ha tanto in odio, come una retorica della pseudo-physis, di una naturalità cioè costruita ad hoc per mezzo dei segni e dei linguaggi, mediatici e no. E, in un’intervista sul cinema che Pasolini cita a più riprese nei suoi saggi, lo stesso Barthes insiste sul fatto che la maggior parte del cinema occidentale preferisce appoggiarsi su una implicita poetica naturalistica piuttosto che abbordare l’astrazione simbolica. Così se nel teatro cinese “per significare che si piange, si afferra l’estremità della manica e la si porta agli occhi inclinando la testa, da noi per significare che si piange, bisogna piangere” (Barthes 1994, 59), trattandosi però di un pianto fittizio, frutto di accorta mimesi. Di modo che “il rifiuto della convenzione porta con sé un rispetto non meno draconiano della natura” (Barthes 1994, 59, corsivo dell’autore).
Più radicale la posizione di Greimas 1970, per il quale il mondo naturale (che è poi il mondo del senso comune) non è altro che un immenso serbatoio di linguaggi non linguistici, di sistemi di significazione altri che le lingue verbali, parlandone, traducono al loro interno. La relazione fra lingua e mondo non è dunque di carattere rappresentativo, da un referente a un segno, ma traduttivo, da un segno a un altro, da un linguaggio a un altro. Posizione assai vicina a quella espressa da Pasolini nei suoi saggi sul cinema[10].
Non a caso, fra i primi sistemi di significazione che si trovano nel mondo naturale, per Greimas, ci sono proprio quelli relativi alla gestualità: dove occorre ben distinguere una significazione somatica (quei movimenti del corpo, corrispondenti a ciò che Pasolini chiamava ‘azione’, dai quali possiamo inferire le forme e i significati del comportamento umano) da una vera e propria comunicazione gestuale (l’uso cioè del corpo per produrre specifici atti espressivi). I cinèmi di Pasolini, che tanto irritavano Eco, non hanno in questo senso nulla di naturalistico perché risultano fondati giusto su una tale significazione somatica che ha sempre e comunque carattere antropologico.
Per quel che riguarda l’attuale oltrepassamento dell’opposizione fra natura e cultura, oggi assai dibattuto soprattutto in antropologia (Descola, Viveiros de Castro, Ingold etc.) e in filosofia delle scienze (Stengers, Latour) possiamo qui dire assai poco. Limitandoci a sottolineare che esattamente ciò che negli anni ’60 appariva, nella migliore delle ipotesi, come una teoria visionaria – quella di Pasolini sul cinema – va oggi riletta anche in funzione di questi attuali orientamenti di pensiero che la semiotica, per quel che ci riguarda, sta cominciando anch’essa a far propri (cfr. per es. Marrone 2011a).
Condizioni di possibilità
Più utile in questo contesto ricordare la lettura che di queste teorie pasoliniane hanno dato Deleuze e, poi, Fabbri. Per il filosofo francese, che come si sa ha molto usato Pasolini nella sua teoria del cinema, coniugandolo creativamente con Peirce, Bergson e molti altri, l’idea pasoliniana del cinema come lingua scritta della realtà è da intendere più che altro sullo sfondo della glossematica di Louis Hjelmslev, linguista molto presente anche in opere più ampie come Mille plateaux. Riprendendo la polemica fra Pasolini e Eco, Deleuze comincia col ricordare che l’accusa di “ingenuità semiologica” rivolta a Pasolini è per quest’ultimo, in fondo, un complimento strategicamente atteso: “È il destino dell’astuzia – scrive perfidamente Deleuze 1989, 40) – di sembrare troppo ingenua a ingenui troppo dotti”[11].
La tesi pasoliniana della doppia articolazione cinematografica, tale per cui il cinema scrive a suo modo ciò che nel mondo è già significante, si attaglia bene alla teoria dell’immagine-movimento proposta dello stesso Deleuze; a patto di non considerare il sostrato significante del linguaggio cinematografico come una lingua ma come una virtualità, una condizione di possibilità che sta a monte del cinema e che deve essergli presupposta per indicarne i meccanismi di funzionamento. Quella che Pasolini chiama linguaggio dell’azione, degli oggetti o della realtà è allora per Deleuze una “materia segnaletica che comporta tratti di ogni tipo, sensoriali (visivi e sonori), cinestetici, intensivi, affettivi, ritmici, tonali, e anche verbali (orali e scritti)” (Deleuze 1989, 42). Una materia, perciò, nel senso prettamente hjelmsleviano (espressamente citato), da intendere come “condizione virtualmente anteriore a ciò che condiziona. Non è una enunciazione, non sono degli enunciati. È un enunciabile” (Deleuze 1989, 42-43). Insomma: qualcosa a partire da cui ogni lingua e ogni linguaggio possono darsi, andando a formarla in modi – espressivi e semantici – assai diversi, potenzialmente infiniti. La teoria pasoliniana trascende così l’universo del cinema per farsi ipotesi semiotica a tutti gli effetti: una semiotica, accetta pienamente Deleuze, della realtà.
Così, osserva appunto Paolo Fabbri, Deleuze riprende da Pasolini l’idea della semiotica come “scienza descrittiva della realtà”, pensandola proprio per questo come una teoria della traduzione. Così come per Pasolini il cinema scrive il reale, cioè traduce una lingua in un’altra, analogamente ogni regime di significazione vive “in una costante attività di traduzione”. Deleuze, lettore di Spinoza, nega, proprio come Pasolini, l’idea di un’arbitrarietà dei segni perché “ogni segno è traduzione di altri segni e – soprattutto – i segni rinviano sempre ai segni”; in tal senso “non c’è alcun tipo di realtà esterna ai segni, giacché i segni sono costitutivi di oggetti e nominativi di eventi, e quindi sono essi stessi la realtà” (Fabbri 1997, 114). Hjelmslev, “oscuro principe spinozista” secondo Deleuze e Guattari (1980; cfr. Fabbri 1998), diviene – con Pasolini – l’alfiere di una teoria della significazione che, eludendo la vecchia questione della relazione fra parole e cose, pensa il senso in termini di diagrammi e piani di consistenza, forme che plasmano materie per farsi sostanze[12].
Soggettività libera indiretta
Un altro punto assai noto della teoria pasoliniana sul cinema che ha avuto una certa risonanza in ambito semiotico è la questione del discorso indiretto libero – istanza enunciativa a metà strada fra il discorso diretto e quello indiretto, dove l’autore riporta parole e pensieri dei suoi personaggi senza cedere loro la voce, combinando di fatto i due soggetti parlanti in un solo discorso (per esempio “Le raccoglie la propria energia: soffrirà la tortura piuttosto che perdere la propria verginità” di Bachtin che se n’è occupato nel libro su Dostoevskij e in Marxismo e filosofia del linguaggio, ed è ripreso da Deleuze 1984, 93). Vale la pena di osservare che questa opposizione tecnica fra ‘prosa’ e ‘poesia’ nel cinema, legata al ‘non far sentire’ o al ‘far sentire’ la macchina da presa, è del tutto analoga a quella che Eco 1983 userà per distinguere fra la paleo-tv (dove quasi mai si guarda in macchina) e la neo-tv (dove invece l’imperativo comunicativo è quello di guardare il più possibile in macchina). In termini più generali, la semiotica distinguerà a questo proposito fra un’enunciazione enunciata e un enunciato enunciato (Marrone 2011b). Strada maestra per affrontare, se non risolvere, il nesso fra linguaggio e cinematografia, o più precisamente fra letteratura e cinema, sottolineandone, dal punto di vista degli esiti comunicativi, alcune differenze sostanziali e alcune similitudini formali profonde.
In un noto scritto del ’65 intitolato Intervento sul discorso libero indiretto (Pasolini [1965, 1972] 1999, 1345-1375) Pasolini si accosta a questo curioso fenomeno grammaticale da un punto di vista più che altro socio-linguistico, alla ricerca non tanto dei suoi meccanismi formali di funzionamento ma dei suoi presupposti e dei suoi esiti in termini di gerarchie, conflitti e contaminazioni fra regimi linguistici; anche quando interviene – da Dante ad Ariosto, da Verga a Morante etc. – il lavoro stilistico dello scrittore a pigiare il pedale dell’esteticità. Così, nei celebri infiniti di Lorenzo Da Ponte (“Notte e giorno faticar / […] / piova o vento sopportar / mangiar male e mal dormir…”) al di sotto della voce di Leporello c’è una “coralità di destinatari” che si riconoscono in una specie di destino condiviso, e cioè nella “esperienza comune di umili, di servi (faticare, sopportare, mangiar male e dormir male)” che sfocia in “una specie di sentimento filosofico della realtà” (Pasolini [1965, 1972] 1999, 1346).
Analogamente, l’uso del passato remoto ha nei Malavoglia – libro che secondo Pasolini consiste per intero in un discorso indiretto libero – un carattere ‘epico’: si tratta del tempo “di un discorso rivissuto collettivamente da tutti i personaggi” (Pasolini [1965, 1972] 1999, 1348). Così, più che una semplice tecnica di riproduzione dei pensieri dei personaggi romanzeschi, secondo Pasolini il discorso indiretto libero “implica una coscienza sociologica, chiara o no, nell’autore” (Pasolini [1965, 1972] 1999, 1349); coscienza che conduce a esiti anche molto diversi, come la comunicazione obliqua dell’ironia, oppure la denuncia delle condizioni sociali di un personaggio, oppure ancora la surrettizia riaffermazione di un’ideologia prettamente borghese. Sovrapporre due o più regimi linguistici, quello dell’autore e quello dei personaggi, ha indubbi effetti stilistici ma, al contempo e per lo più, sociologici.
Il tema viene ripreso, fra l’altro, nel già citato saggio sul “cinema di poesia” (non a caso dello stesso anno), dove il dispositivo letterario del discorso indiretto libero viene ripensato alla luce delle questioni sulla natura linguistico-comunicativa del cinema, di cui s’è detto. L’uso di quella che, per analogia, Pasolini chiama “soggettiva libera indiretta” nel linguaggio cinematografico è difatti la più stretta conseguenza del fatto che il cinema copre il ruolo di lingua scritta della realtà. Per quanto infatti convenzioni narrative e istanze del mercato provino a condurre e confinare il cinema entro una qualche forma di oggettività, esso resta sempre fortemente soggettivo. Se il regista, come s’è detto, deve prima trascegliere dalla realtà le immagini significanti che ritiene pertinenti al proprio progetto poetico e poi farne materia di linguaggio nel proprio film, una qualche dose di soggettività al cinema non potrà mai mancare, soggettività che si incontra e si scontra con un’altra soggettività: quella dei personaggi che viene messa in scena nel racconto filmico enunciato. Ed ecco apparire il discorso indiretto libero come forma che, mediando fra i due poli estremi e astratti della massima obiettivazione e della massima soggettivazione, finisce per divenire la forma comunicativa più frequente, per non dire più naturale, del linguaggio cinematografico. Così, da un lato può accadere che in un film si presenti, o addirittura prevalga, la ripresa in soggettiva, corrispondente al discorso diretto della lingua (oppure, in taluni casi, al monologo interiore letterario), dove ciò che lo spettatore vede corrisponde esattamente a ciò che vede un determinato personaggio; ma dietro questo tipo di ripresa accade che riemerga – in quello che Pasolini chiama “cinema di poesia” – la soggettività dell’autore (diremmo oggi, meglio, dell’enunciatore), la sua istanza personalistica, a carattere stilistico, sociologico e a volte anche ideologico. Si tratta, dice Pasolini, della “tentazione di fare un altro film” (Pasolini [1965, 1972] 1999, 1480), di un “bisogno di libertà irregolare, provocatoria, per un diversamente autentico o delizioso gusto dell’anarchia” (Pasolini [1965, 1972] 1999, 1486) – che, però, diviene ben presto canone diffuso.
Registi assai diversi come Antonioni, Bertolucci o Godard usano esattamente questa tecnica, che Pasolini chiama semi-soggettiva oppure, appunto, soggettiva libera indiretta, utilizzando una serie di tecniche (accostamento di diversi punti di vista, ritmo incalzante del montaggio, camera fissa a formare tanti ‘quadri’, uso eccessivo dello zoom etc.) che segnalano, al di sotto della narrazione, la loro presenza autoriale, l’istanza enunciativa che sorregge l’intera impalcatura filmica. Così, in fondo, il cinema di poesia, dice Pasolini, non è altro che un tipo di linguaggio che “fa sentire la macchina”, che enuncia l’enunciazione diremmo oggi: al fine di intrecciare alla parola dei personaggi, o se si vuole alla loro soggettività, in modo spesso indistinguibile, la parola di una seconda istanza soggettiva, che, non senza una qualche forma di autoritarismo, dice la sua sulla storia raccontata, sovrapponendo una seconda rete di possibili significati a quelli che la storia stessa già esprimeva. Laddove il cinema precedente (da Chaplin al primo Bergman) mirava a non far percepire la presenza inevitabile della cinepresa nella produzione del film, nascondendo qualsiasi segnale dell’apparato tecnico del cinema, e rivelandosi per questo come un ‘cinema di prosa’, il cinema di poesia portato avanti dalla generazione contemporanea a Pasolini la cinepresa vuol farla inequivocabilmente percepire, in modi molto vari, tutti comunque miranti a gestire il discorso indiretto libero proprio del cinema[13].
Indecidibilità
Discutendo dello statuto dell’immagine-percezione al cinema, Deleuze riprende la teoria pasoliniana della soggettiva libera indiretta come elemento essenziale dell’immagine cinematografica. Pasolini, secondo Deleuze, avrebbe usato un’analogia linguistica – quella del discorso indiretto libero come forma intermedia fra discorso diretto e indiretto – per cercare di rendere l’idea di una percezione cinematografica che “non ha equivalenti nella percezione naturale”. Ora, il discorso indiretto libero non è, precisa Deleuze riprendendo con Pasolini Bachtin/Volosinov, in senso stretto una mescolanza fra due soggetti di enunciazione già dati, ognuno appartenente a un dato regime comunicativo; esso è semmai “un concatenamento enunciativo che opera allo stesso tempo due atti di soggettivazione inseparabili, uno che costituisce un personaggio alla prima persona, l’altro che assiste alla sua nascita e lo mette in scena” (Deleuze 1984, 93); ne viene fuori un dispositivo costitutivamente eterogeneo, in costante disequilibrio: motivo per cui, più che con l’ausilio di vere e proprie categorie linguistiche, esso va inteso come un procedimento di stile – come appunto Pasolini sosteneva. Per certi versi, tale dispositivo, sostiene Deleuze, può essere accostato al “Cogito” della filosofia, secondo il quale nessun soggetto empirico viene alla luce se non a partire da un soggetto trascendentale, travasato però nel mondo dell’arte, dove “non vi è un soggetto che agisca senza un altro che lo guardi agire, e che lo colga in quanto agito, assumendo la liberta di cui lo priva” (Deleuze 1984, 94).
Trasferito nella comunicazione cinematografica, questo dispositivo manifesta tutta la sua potenza espressiva, dando conto della immagine-percezione tipica di tale forma comunicativa. Così, c’è innanzitutto un personaggio che agisce sullo schermo e guarda al mondo in un certo modo; ma nello stesso tempo costui è inquadrato dalla cinepresa che, dal proprio punto di vista, lo vede vedere, di fatto trasformandone, con la visione, l’intero mondo affettivo e intellettivo. In tal modo non si tratta soltanto di due visioni che si incrociano, ma di una forma autonoma di percezione che oltrepassa l’opposizione fra soggettivo e oggettivo.
Non ci troviamo più di fronte a immagini soggettive o oggettive; siamo presi in una correlazione fra un’immagine-percezione e una coscienza-cinepresa che la trasforma (Deleuze 1984, 94).
Si tratta, in altre parole di un’immagine ‘semi-soggettiva’, ma “questa semi-soggettività non indica più niente di variabile o di incerto. Non segna più una oscillazione fra due poli, ma un’immobilizzazione secondo una forma estetica superiore”. Superiore nel senso, ovviamente, di una raggiunta autonomia comunicativa e stilistica, propria dell’immagine cinematografica e soltanto di essa.
Così, commenta Fabbri, la questione, per Pasolini e per Deleuze, non è più semplicemente quella di sottolineare un’analogia formale fra la letteratura e il cinema ma, per così dire, di porla per poterla subito dopo oltrepassare; andando oltre il ricatto teorico che a lungo ha imposto alla semiotica di scegliere fra, da un lato, l’ipotesi di una peculiarità dei vari linguaggi artistici e, dall’altro, l’idea di plasmare tutti i sistemi di segni secondo i modelli della linguistica:
non si tratta solo di pensare all’immagine, ma al punto di vista sull’immagine; in tal modo l’immagine è sottoposta ai principi di enunciazione, non comparabili al linguaggio ma in qualche modo specifici (Fabbri 1997, 123).
Il discorso indiretto libero permette così, in modo per così dire normale, senza alcuna trasgressione momentanea di norme già date ma norma a sua volta, di porre “l’indecidibilità del punto di vista sulla soggettività”, o per meglio dire un’“inassegnabilità della soggettività produttrice del discorso”. Via Pasolini, ripensato alla luce di problematiche non sue, accade in tal modo che il cinema, passando per la teoria semiotica dell’enunciazione, ritrovi forme espressive che sono al tempo stesso simili e diverse da quelle della lingua, letteraria e no.
Fabbri fa, a questo proposito, un altro esempio di un certo interesse, ripreso da Prova d’orchestra di Fellini, dove c’è un piano sequenza in cui una ripresa in soggettiva diventa progressivamente oggettiva, passando per un lungo momento in cui la posizione enunciativa risulta inassegnabile. Il direttore d’orchestra viene inquadrato da dietro, come visto da un altro personaggio; a poco a poco la camera gli gira intorno finendo per mostrarlo di fronte, con una inquadratura che diviene ‘normale’, cioè oggettiva.
Che cosa è successo? Mentre la camera faceva il giro, chi stava effettivamente guardando? Quale categoria del linguaggio verbale è capace di rendere, cioè di tradurre, quel momento intermedio (eppure lento, continuo, e di una certa lunghezza temporale) in cui la ripresa non è ancora diventata impersonale ma già non è più soggettiva? (Fabbri 2001, 105-106)
E la risposta è tranciante: non c’è nessuno che parla, nel senso linguistico del termine, ma lo spettatore non fa fatica a capire cosa è successo. Si tratta di un discorso indiretto libero? Può darsi, dice Fabbri, che non si dia però per scarti enunciativi discontinui, per inneschi e disinneschi, per passaggi di parola da un soggetto dato a un altro anch’esso già costituito, ma semmai, proprio come diceva Pasolini quando indicava i due film che scorrono l’uno sull’altro, in una dimensione processuale, in una dinamica continua, in cui l’indecidibilità diviene tanto palese quanto intraducibile. Solo che, ribadisce ancora Fabbri, occorre intendersi sull’idea stessa di intraducibilità. Niente a che fare con un’impermeabilità ontologica di un linguaggio rispetto ad altri, con una mistica specificità che mira al silenzio, ma un grumo di senso che attende di essere detto altrimenti, al momento opportuno, con nuove abilità comunicative. Così,
l’intraducibile è la fonte di informazione per le traduzioni future. […] Siccome non smettiamo mai di tradurre, un giorno tradurremo quel testo che ci era sembrato intraducibile e scopriremo che è diventato traducibile: sarà cambiato lo stato del linguaggio o avremo tradotto in un altro sistema di segni (Fabbri 2001, 105-106).
L’indecidibile non va confuso con l’indicibile: Pasolini lo sapeva bene.
Ricerche in corso
Si apre, con la rilettura di questi saggi di Pasolini e dei suoi principali interpreti, un terreno molto vasto e complesso d’azione e di teorizzazione. L’idea – squisitamente semiotica – di riversare un fenomeno linguistico-stilistico tipicamente letterario in un linguaggio assai differente nella materia d’espressione, per farne un dispositivo formale unico, dà molti frutti. Ritrovando omologie formali fra altri linguaggi. Così, in una mia recente analisi testuale di una trasmissione televisiva che si farebbe fatica a definire poetica, la celebre MasterChef, ho ritrovato forme evidenti di discorso indiretto libero, soprattutto a partire dal montaggio, non solo delle inquadrature, ma anche del nesso fra colonna visiva e colonna sonora. Forme che, però, risultano invertite dal punto di vista dell’asse comunicativo, riguardando difatti non più il soggetto enunciante, come in Pasolini, ma quello ricevente:
nella frontiera fra dire e pensare, esprimersi e tacere, perennemente indeterminata e cangiante, si produce lo spazio in cui si inserisce l’enunciatario, attorializzato nei pensieri dei concorrenti più che nelle loro azioni, nella percezione più ancora che nella passione. Si tratta, con ogni probabilità, di un caso molto particolare di testualizzazione della classica identificazione fra spettatore e personaggio, tutta giocata però sulle sole dimensioni cognitiva ed estesica (Marrone 2016, 349).
Un accostamento fra letteratura e fotografia, via discorso indiretto libero, lo ha proposto invece (Mangano 2019) nel suo studio su Vivian Maier e i suoi celebri autoritratti. In particolare, Mangano accosta l’intreccio di inneschi e disinneschi che Greimas (2019) aveva ritrovato in un passaggio di un racconto di Maupassant – “Morissot mise la guancia a terra per sentire se qualcuno camminava nei paraggi. Non udì nulla. Erano proprio soli, completamente soli” – al gioco di specchi e di prospettive adoperato dalla fotografa americana per rappresentare, con la sua figura esteriore fatta a pezzi, la propria dimensione affettiva a dir poco problematica.
È così che la Maier fa in modo di rendere conto ‘della messa in discorso dei molteplici aspetti della vita interiore’ […], di fatto realizzando una forma di discorso indiretto libero attraverso una sostanza espressiva di tipo visivo, ma soprattutto attraverso una rappresentazione ‘meccanica’ che, in linea di principio, non può avvalersi delle libertà che sono concesse al pittore. Sarà semplice a questo punto riscontrare come una struttura del genere si ripeta in moltissimi degli autoritratti pubblicati (Mangano 2019, 85, traduzione nostra).
Ma è soprattutto Paolucci (2020, 239-282) a conferire al discorso indiretto libero un ruolo di primo piano nella teoria generale dell’enunciazione semiotica, considerandolo come il meccanismo principe nella produzione della soggettività nel linguaggio, nei linguaggi. Si tratta, dice, di
[...] un concatenamento enunciativo, un composto in cui scompare la piena discernibilità dei termini in rapporto, un assemblaggio in cui non si può assegnare nettamente il punto di vista delle voci riunite in assemblea (Paolucci 2020, 244).
Il punto è che questa modulazione di un punto di vista attraverso un altro, questo divenire diretto del discorso indiretto e divenire indiretto del discorso diretto, questa processualità in cui si mescolano più voci e più prospettive non sarebbe da intendere come una trovata stilistica, una messa in mostra dell’autore dietro o accanto i suoi personaggi, ma, al contrario, come un assetto abbastanza normale della soggettività linguistica, o per meglio dire semiotica, valida cioè per ogni tipo di linguaggio, sia esso verbale o audiovisivo. In fondo, sostiene Paolucci, l’atto enunciativo è sempre molteplice, eterogeneo, sociale, carico cioè di voci e di rumori che la cultura – l’enciclopedia, in termini echiani – fornisce a una soggettività che, manifestandosi nel linguaggio, rivela tutta la sua complessità, la sua costitutiva ‘impersonalità’. L’io emerge allora, per Paolucci, solo quando, in qualche modo, si fa egli nel discorso e nessuna soggettività può darsi se non in questo basico concatenamento. In definitiva, l’enunciazione sarebbe “transpersonale”, esito di un “essere insieme”, di una struttura ‘partecipativa’ che coniuga l’impersonalità della cultura e la personalità del singolo. Chi parla in me e con come? Come diceva Bachtin, non a caso più volte citato da Deleuze, è sempre un soggetto plurimo, punto di incontro momentanei e cangiante di voci differenti, eteroclite, in dialogo o in conflitto fra di loro. Un costante bricolage, insomma.
Pasolini avrebbe allora l’enorme merito di aver suscitato, con la sua rivendicata ingenuità, col suo dilettantismo programmatico, con la sua riflessione impura, una profonda riflessione non solo in una teoria del cinema, ma più in generale nella teoria dei segni e dei linguaggi, in vista di una continua traduzione di voci e concetti, di affetti e percetti che guarda, con assoluto cipiglio, al futuro – prossimo e no.
Note
[1] Per una prima ricognizione del contesto storico e del portato concettuale di questa problematica, cfr. Casetti 1993, 143-150 e 306-310). Per una prima ricostruzione dei rapporti fra Pasolini e la semiotica cfr. Buttitta 1980.
[2] Vale la pena di riportare uno dei numerosi esempi proposti in questo senso da Pasolini: “Tutti noi, con i nostri occhi, abbiamo visto la famosa vaporiera con le sue ruote e i suoi stantuffi. Essa appartiene alla nostra memoria visiva e ai nostri sogni: se la vediamo nella realtà ‘ci dice qualcosa’: la sua apparizione in una landa desertica, ci dice, per es., quanto sia commovente l’operosità dell’uomo e quanto sia enorme la capacità della società industriale, e quindi del capitalista, ad annettersi nuovi territori di utenti; e, insieme, ad alcuni di noi, dice che il macchinista è un uomo sfruttato che, ciononostante, compie dignitosamente il suo lavoro, per una società che è quella che è, anche se sono i suoi sfruttatori a identificarsi con essa ecc. ecc. Tutto questo può dire l’oggetto vaporiera come possibile simbolo cinematografico, in una comunicazione diretta con noi stessi: e indirettamente, in quanto patrimonio visivo comune, per gli altri” (Pasolini [1966b, 1972] 1999, 1466-1467, corsivi dell’autore)
[3] Le prime informazioni di un uomo io le ho dal linguaggio della sua fisionomia, del suo comportamento, del suo costume, della sua ritualità, della sua tecnica corporale, della sua azione, e anche, infine, dalla sua lingua scritto-parlata (Pasolini [1966a, 1972] 1999, 1506)
[4] L’idea di un cinema naturale, si ricorderà, è stata ripresa in un senso abbastanza simile da Celati 2001. La vita come rappresentazione, pirandellismo di risulta, tornerà invece in Goffman 1969.
[5] È molto probabile che in questa idea del cinema come scrittura ci sia un’influenza dell’idea di écriture di Barthes 1985), come sembra di capire leggendo alcune dichiarazioni successive di Pasolini: “Barthes, che ha così allargato la nozione di ‘scrittura’, dovrebbe essere ingolosito da questa mia idea del cinema come ‘scrittura’” (Pasolini [1966a, 1972] 1999, 1553).
[6] Dove, ripetiamo ancora, tale ‘realtà’ non è quella fisica o biologica ma la esperienza umana e sociale. L’essere, leggiamo ancora, “è portentoso, misterioso e semmai assolutamente innaturale” (Pasolini [1966a, 1972] 1999, 1565). Idea che appassionerà Gilles Deleuze, e per altri versi anche studiosi come Bruno Latour e Paolo Fabbri.
[7] Per una puntuale ricostruzione dell’intero dibattito, che ha visto impegnati, con Eco, studiosi come Metz, Garroni e Bettetini, cfr. Desogus 2018, 59-95.
[8] Per la precisione, Eco muove le sue critiche a Pasolini già nella sua dispensa universitaria Appunti per una semiologia delle comunicazioni visive, del’66, Pasolini le leggerà e alle quali risponderà, che confluisce con poche variazioni ne La struttura assente (Eco 1968), volume tutt’ora in circolazione al quale faremo qui, per comodità, riferimento.
[9] Per una ricostruzione di questo dibattito cfr. Polidoro 2012.
[10] Del “cinema come traduzione” parla anche Dusi 2003, anche se in un senso un po’ diverso.
[11] Per una difesa della posizione di Eco cfr. Paolucci 2008 che, alla luce di Peirce, insiste anche lui sui grossi fraintendimenti fra Pasolini ed Eco, ma anche in Deleuze che rilegge Pasolini.
[12] Così per esempio Barthes 1994 legge nel Salò di Pasolini non la presenza di un “sistema del fascismo” come epigono di Sade, ma di una “sostanza-fascismo” da poter intrecciare diagrammaticamente alla “sostanza sadiana”. Per i frequenti richiami di Fabbri al nesso Hjelmslev-Deleuze, cfr. anche Fabbri 2021.
[13] Vale la pena di osservare che questa opposizione tecnica fra ‘prosa’ e ‘poesia’ nel cinema, legata al ‘non far sentire’ o al ‘far sentire’ la macchina da presa, è del tutto analoga a quella che Eco 1983 userà per distinguere fra la paleo-tv (dove quasi mai si guarda in macchina) e la neo-tv (dove invece l’imperativo comunicativo è quello di guardare il più possibile in macchina). In termini più generali, la semiotica distinguerà a questo proposito fra un’enunciazione enunciata e un enunciato enunciato (cfr. Marrone 2011b).
Riferimenti bibliografici
- Barthes [1953] 1985
R. Barthes, Il grado zero della scrittura [Le dégré zéro de l’écriture, Paris 1953], traduzione di Giuseppe Bartolucci, Renzo Guidieri, Franco Maria Ricci, Rosetta Loy, Leonella Prato Caruso, Torino 1985. - Barthes [1957] 1974
R. Barthes, Miti d’oggi [Mythologies, Paris 1957], traduzione di Lidia Lonzi, Torino 1974. - Barthes [1960] 1994
R. Barthes, Il problema della significazione nel cinema [Le problème de la signification au cinéma, “Revue internationale de filmologie” 32-33 (1960)], in Id. Sul cinema, a cura di Sergio Toffetti, Genova 1994. - Barthes [1976] 1994
R. Barthes, Sade - Pasolini [Sade - Pasolini, “Le Monde” 16 giugno 1976], in Id. Sul cinema, a cura di Sergio Toffetti, Genova 1994. - Buttitta 1981
A. Buttitta, La semiotica impura di P.P. Pasolini, in P. Lendinara e C. Ruta (a cura di), Per una storia della semiotica. Teorie e metodi, Palermo 1981, 315-320. - Cassetti 1993
F. Casetti, Teorie del cinema. 1945-1990, Milano 1993. - Celati 2001
G. Celati, Cinema naturale, Milano 2001. - Deleuze [1983] 1984
G. Deleuze, L’immagine-movimento [L’image-mouvement, Paris 1983], traduzione di Jean Paul Manganaro, Milano 1984. - Deleuze [1985] 1989
G. Deleuze, L’immagine-tempo [L’image-temps, Paris 1985], traduzione di Liliana Rampello, Milano 1989. - Desogus 2018
P. Desogus, Laboratorio Pasolini. Teoria del segno e del cinema, Macerata 2018. - Dusi 2003
N. Dusi, Il cinema come traduzione, Torino 2003. - Eco 1968
U. Eco, La struttura assente, Milano 1968. - Eco 1983
U. Eco, Tv: la trasparenza perduta, in Id. Sulla televisione. 1956-2015, Milano 2018. - Eco 1993
U. Eco, Kant e l’ornitorinco, Milano 1997. - Fabbri 1997
P. Fabbri, Come Deleuze ci fa segno, in Salvo Vaccaro (ed.), Il secolo deleuziano, Milano 1997. - Fabbri 1998
P. Fabbri, L’oscuro principe spinozista. Deleuze, Hjelmslev, Bacon, “Discipline filosofiche” VIII, n. 1 (1998), 212-221. - Fabbri 2001
P. Fabbri, La svolta semiotica, Roma-Bari 2001. - Fabbri 2017
P. Fabbri, L’efficacia semiotica, Milano 2017. - Goffman [1959] 1969
E. Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione [The Presentation of Self in Everyday Life, New Yorn 1959], traduzione di Margherita Ciacci, Bologna 1969. - Greimas [1970] 1974
A. J. Greimas, Del senso [Du sens, Paris 1970], traduzione di Stefano Agosti, Milano 1974. - Greimas [1976] 2019
A. J. Greimas, Maupassant [Maupassant, Paris 1976], traduzione di Gianfranco Marrone e Stefano Montes, Milano 2019. - Mangano 2019
D. Mangano, This is not Vivian. The Photographer as a Form of Life, “Versus “128 (2019), 73-93. - Marrone 2011a
G. Marrone, Addio alla Natura, Torino 2011. - Marrone 2011b
G. Marrone, Introduzione alla semiotica del testo, Roma-Bari 2011. - Marrone 2016
G. Marrone, Semiotica del gusto, Milano 2016. - Metz 1964
Ch. Metz, Cinéma langue ou langage, “Communications” 4 (1964), 62-90. - Paolucci 2008
C. Paolucci, La ‘lingua scritta della realtà’ tra visibile e dicibile. Pasolini, Eco, Peirce e Deleuze, “Versus” 106 (2008), 67-83. - Paolucci 2020
C. Paolucci, Persona. Soggettività del linguaggio e semiotica dell’enunciazione, Milano 2020. - Pasolini [1965, 1972] 1999
P. P. Pasolini, Intervento sul discorso libero indiretto, poi in Empirismo eretico, Milano 1972. ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, 2 voll., Milano 1999, vol. I, 1461-1489. - Pasolini [1966a, 1972] 1999
P. P. Pasolini, La lingua scritta, Milano 1972. ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, 2 voll., Milano 1999, vol. I, 1461-1489. - Pasolini [1966b, 1972] 1999
P. P. Pasolini, Il cinema di poesia, “Marcatré” n. quadruplo 19-20-21-22 aprile 1966, poi in Empirismo eretico, Milano 1972. ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, 2 voll., Milano 1999, vol. I, 1461-1489. - Pasolini [1967, 1972] 1999
P.P. Pasolini, Il codice dei codici, in Empirismo Eretico, Milano 1972 (con data in calce 1967), ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, 2 voll., Milano 1999, vol. I, 1611-1622. - Polidoro 2012
P. Polidoro, Umberto Eco e il dibattito sull’iconismo, Roma, 2012.
English abstract
This paper reconstructs the debate raised by the thesis on cinema proposed by Pier Paolo Pasolini. In particular, two basic notions are addressed: the idea of cinema as a 'written language of reality' and the role of free indirect discourse for the establishment of a 'poetry cinema'. Pasolini is put into dialogue with Gilles Deleuze, Paolo Fabbri and other semiologists.
keywords | orality/literacy; cinema/reality; prose/poetry; free indirect discourse.
Per citare questo articolo/ To cite this article: Gianfranco Marrone, Traduzione e soggettività. Ancora su Pasolini e il cinema, “La Rivista di Engramma” n. 181, maggio 2021, pp. 175-197. | PDF dell’articolo