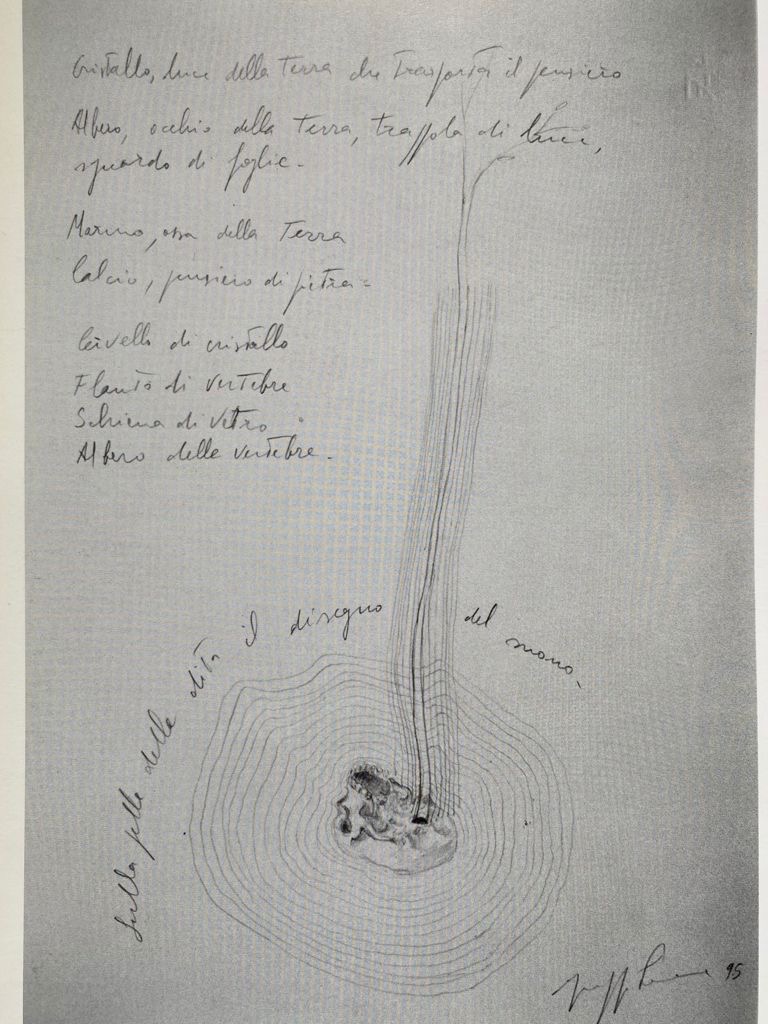Incursioni. Arte contemporanea e tradizione di Salvatore Settis (Feltrinelli, 2020)
Una lettura corale
a cura di Monica Centanni e Giuseppe Pucci
con contributi di Anna Anguissola, Maurizio Bettini, Marilena Caciorgna, Maria Luisa Catoni, Monica Centanni, Maria Grazia Ciani, Claudia Cieri Via, Gabriella De Marco, Giuseppe Di Giacomo, Elisabetta Di Stefano, Eva Di Stefano, Roberto Diodato, Dario Evola, Claudio Franzoni, Maurizio Harari, Franco La Cecla e Anna Castelli, Alessandro Poggio, Valentina Porcheddu, Daniela Sacco, Antonella Sbrilli, Salvatore Tedesco
English abstract
Del buon uso delle incursioni. Presentazione della lettura corale del volume di Salvatore Settis
Monica Centanni, Giuseppe Pucci
A un archeologo classico il termine ‘incursioni’ richiama immediatamente un aneddoto, più volte citato da Ranuccio Bianchi Bandinelli. Quando nel 1895 Franz Wickhoff, storico dell’arte medievale, pubblicò una rivoluzionaria storia dell’arte romana che ne individuava i caratteri di originalità rispetto a quella greca, il più famoso archeologo classico dell’epoca, Adolf Furtwängler, la paragonò, assai poco benevolmente, a una “incursione di Ussari a cavallo”. E tuttavia quello scritto corsaro di un autore che non era istituzionalmente uno specialista della materia conteneva – forse proprio per questo – intuizioni preziose, da mettere a frutto. Lo stesso si può dire di queste Incursioni nell’arte contemporanea.
Le incursioni – scrive Salvatore Settis – “dovrebbero farsi partendo da un luogo familiare e sicuro” (Incursioni, alla pagina 36) che nel suo caso dovrebbe essere la disciplina in cui si è formato, che per molto tempo ha insegnato, per la quale ha conseguito importanti riconoscimenti, nazionali e internazionali: l’archeologia classica. L’incursione, atto coraggioso quando non temerario, di solito ha un obiettivo mirato e preciso. Ma qual è l’obiettivo di queste incursioni di un archeologo classico nell’arte contemporanea? Non certo garantire la rassicurante iscrizione delle forme artistiche della contemporaneità entro i binari della tradizione classica, rintracciando nobili genealogie e appiccicando blasoni posticci a un presente avvertito, sempre, come nano e difettoso rispetto alle gigantesche altezze del passato. Ma l’obiettivo non è neppure, nell’altro senso, rispolverare modelli e icone dal repertorio dell’antico per passarci sopra una mano di smalto ammiccante all’attualità. Il punto è un altro e riguarda direttamente il metodo e la responsabilità deontologica del ricercatore; si tratta di mettere in gioco la propria strumentazione analitica e la specifica metodologia di indagine, per applicarla e insieme sottoporla al vaglio di una verifica, rigorosamente praticabile e scientificamente confutabile, sui manufatti che popolano il paesaggio della nostra contemporaneità. Si tratta, in altre parole, di verificare la funzionalità e l’applicabilità del metodo e verificare se un’estetica affinata sulla specialistica (e gloriosa) strumentazione disciplinare dell’archeologia classica (e più in generale delle varie filologie e scienze dell’Antichità) possa produrre non solo esercizi di stile brillanti ed eruditi, ma sia anche, soprattutto, positivamente fruttifera sul fronte ermeneutico, per proiettare una nuova luce di senso sulla contemporaneità. Proprio l’archeologia, per altro, nello studio della relazione inquieta tra ‘originali’ e ‘copie’, tra modello ed esemplare, antigrafo e apografo (per dirla in termini filologici), ci ha insegnato che si attivano continuamente cortocircuiti e che la nozione di un andamento continuo e lineare del tempo è messa in crisi a ogni passaggio; ci insegna altresì che la creazione artistica – comunque sia definita all’interno della costellazione di termini semanticamente ardui come ποίησις e inventio, complicati dalla dialettica con la nozione di μίμησις – smentisce l’opposizione secca tra ‘vero’ e ‘falso’, rilanciando a ogni artista, a ogni opera, la valenza estetica e creativa della fictio. Di fatto, nella produzione artistica non solo non è mai possibile stabilire cosa sia ‘autentico’ e cosa no, ma non è mai neppure tracciabile una ricostruzione genealogica basata su linee definite e su derivazioni e ascendenze chiare e univoche. E, nei rari casi in cui lo è, la storia è molto meno interessante e l’agency dell’opera – la capacità di interazione con il mondo in forza dell’intensità della sua energia interiore – è certo meno potente.
In questo senso, sul piano del metodo, diventa irrilevante la differenza tra il manufatto antico e il contemporaneo: lo sguardo del ricercatore si concentra, immanentisticamente, sull’esistente. Contro le derive indiscrete delle teorie del Postmoderno, la sfida è difendere l’acribia della lettura storica dell’opera, tenendo viva la coscienza dei filtri e degli effetti di distorsione generati dalla distanza e dalla prossimità dello sguardo, e nel contempo trattare ogni opera d’arte che ha titolo di esistenza nel nostro mondo con lo stesso rispetto, la stessa cura, sia essa antica o contemporanea. E, soprattutto, coinvolgendola come soggetto della stessa interrogazione. Ogni oggetto archeologico che abita il nostro mondo è, anche, un’opera a noi contemporanea. E, all’inverso, riprendendo il titolo del numero di Engramma che ospita questa lettura corale, “all art has been contemporary”: ogni manufatto artistico è stato, a suo tempo, contemporaneo. Un’alta intenzione ermeneutica, dunque, unita a un metodo preciso e rigoroso e, soprattutto un elevato tasso di discrezione, estetica e metodologica. Vale infatti il principio che ogni opera d’arte è “sintomo del tempo”, del suo proprio tempo e del tempo in cui viene scoperta o vista, studiata o riscoperta, riletta o restaurata, integrata o riallestita; ma ogni manufatto va trattato con la debita e specifica attenzione perché non tutto vale per tutto: anzi niente vale – mai – per un’altra cosa. Possiamo mutuare la lezione che Giorgio Pasquali ha dato alla disciplina filologica: “ogni esemplare è un originale”.
Ma, come si è visto, il dispositivo che Settis mette in campo nel suo Incursioni non mira a ‘fare filologia’, perché non si tratta di risalire allo stemma genealogico dei modelli e ricostruire le suggestioni che possono aver influenzato la creazione artistica contemporanea; ma neppure, su altro fronte, mira a ‘fare iconologia’ in senso semplificatorio, alla caccia delle fonti e delle matrici formali della creazione dell’artista, e dei significati profondi che si celerebbero dietro la superficie dell’opera e che lo studioso sarebbe chiamato a svelare. L’obiettivo delle incursioni di Settis è liberare la ricchezza del potenziale semantico dell’opera, senza ridurlo alla misura di una sua unica determinazione. In questo senso, il raid è la strategia giusta per illuminare l’opera con il lampo di una nuova luce che avrà come fine ultimo non già l’acquisizione erudita e la ricostruzione del palinsesto sotteso all’opera, ma l’accrescimento del godimento estetico dell’opera stessa. Vale, sempre, quel che scrive Edgard Wind:
C’è una prova sola – e soltanto una – dell’importanza artistica di una data interpretazione: essa deve intensificare la nostra percezione dell’oggetto e in questo modo accrescere il nostro piacere estetico. Se l’oggetto continua a presentare lo stesso aspetto di prima, salvo il fatto che ad esso è stata aggiunta una sovrastruttura ingombrante, quella data interpretazione è inutile dal punto di vista estetico, per quanto grandi possano essere i suoi meriti storici o di altro tipo (E. Wind, Arte e Anarchia [ed. or., London 1963; New York 19642], trad. it. a cura di Rodolfo Wilcock, Milano 1986, 91).
L’incursore è quindi methorios, nel senso che sta sull’horos, sul confine a presidiare il proprio territorio, ma è anche attento a ciò che sta metá, al di là di quello, riuscendo così ad allargare il suo orizzonte e a cercare sempre nuovi ambiti da esplorare. Ma dopo il raid – la fugace scorribanda in territori che di norma non presidia e non controlla – l’incursore si dovrebbe assicurare di poter far ritorno presto ‘a casa’, garantendosi preventivamente una rapida e sicura ritirata; l’incursore, per la stessa natura episodica e strategica della sua azione, dovrebbe avere una sponda a cui tornare dopo l’avventura. Quella sponda, dice Settis, parlando per sé e per tutti noi, il “luogo familiare e sicuro” a cui tornare di tanto in tanto, “dovrebbe essere la cultura classica, l’arme absolue per intendere la storia culturale europea” (è una frase di Lord Milo Parmoor; Incursioni, alle pagine 36-37). Ma il nostro incursore dichiara con la freschezza e la temerarietà del giovane studioso che no, quella sponda non ce l’ha, non si è curato di garantirsela. O forse nel corso dell’impresa di ricerca durata una vita, nel labirinto della ricerca lo studioso ha perso, felicemente, la via di casa: “dopo tanti viaggi di andata e ritorno non sono più sicuro che sia così [che si debba far ritorno a casa]. Rivedendole in sinossi, quelle allineate in questo libro sono, piuttosto, ‘incursioni’ da un avamposto all’altro”. Incursioni molto anomale, dunque, perché senza previsione di riparo finale nel “luogo familiare e sicuro”; incursioni senza ritorno a casa. Incursioni il cui obiettivo non è la distruzione o la costruzione di schemi interpretativi ma l’avventura dello spaesamento e l’attivazione di cortocircuiti “di avamposto in avamposto” che disegnino traccianti non genealogie e illuminino di una nuova intelligenza, insieme storica e critica, il fenomeno artistico. “Non so quale merito o vantaggio potranno averne i lettori o gli studi. So però quale è stato il mio vantaggio: di sentirmi straniero in ogni luogo, con tante insicurezze ma anche, ogni volta, con molta curiosità”. Insicurezza e curiosità: è un bel binomio, una definizione seria e importante del movente della ricerca scientifica: solo il sentirsi, sempre, stranieri in terra straniera, solo l’esperienza dell’incertezza, vissuta in modo intellettualmente coraggioso, è la fonte dell’energia che porta lo studioso a esplorare sentieri impervi della ricerca, l’impulso che lo induce a non fermarsi ma a muoversi, allenando la mente al piacere dell’avventura.
“Sentirsi straniero in ogni luogo”. Per comporre questa lettura polifonica e collettiva del volume Incursioni abbiamo invitato compagni di studio e di ricerca adottando per gli inviti due criteri. La prima, ma non la più importante, guida alla selezione degli invitati è stata l’amicizia degli autori con Salvatore e fra di loro: non tanto l’amicizia praticata nella dimensione intima, famigliare e quotidiana, ma soprattutto l’amicizia stellare, coltivata leggendoci e studiandoci a distanza (perché, sì, l’amicizia intellettuale può anche essere felicemente libresca). Ma il criterio più importante che abbiamo adottato è stato scegliere di invitare amici e colleghi che siano in armi contro i “grenzpolizeilichen Befangenheit” (l’espressione è di Warburg), studiosi che non si sentono a casa nelle sigle dei SSDD (il “monstrum tutto italiano dei settori scientifici disciplinari” parole di Settis); studiosi che, forti di un metodo consolidato, di una loro specifica tool box, nella loro pratica di studio e di ricerca si siano però esercitati in proprio alle incursioni in altri campi del sapere. E perciò in grado di apprezzare l’esercizio, di stile e di metodo, di cui Settis in Incursioni dà prova.
Incursioni attraversa i confini della storia dell’arte, contemporanea e non solo, della filologia e dell’Antichità, della filologia e della storia della tradizione classica, della filologia e dell’antropologia. Perciò abbiamo invitato archeologi, storici dell’arte, filologi e antichisti, antropologi e filosofi a leggere con noi questo libro, a intervenire liberamente, fuori binario e secondo quel che il loro daimon suggeriva, dando parole e forma alle sollecitazioni che il testo provoca. Le risposte sono state varie, belle e plurali, ciascuna nello stile dell’autore: interventi in forma di breve saggio, con bibliografia sostanziosa e immagini; disamine generali dell’impianto del volume; affondi su uno dei temi trattati; riflessioni sui termini della tradizione e della contemporaneità, della memoria e del monumentum. Alcuni hanno offerto la loro lettura richiamando passaggi puntuali del testo, altri hanno reagito con altre immagini, altre suggestioni. Alcuni testi si richiamano l’un l’altro attraverso la comune origine in una pagina, una citazione o un capitolo, delle Incursioni di Settis, e in molti casi si è attivato un dialogo a distanza: in risposta al suo titolo, il libro di Settis ha provocato diverse incursioni nelle sue pagine, nel suo corredo di immagini, nel repertorio di fonti raccolte, nelle connessioni suggerite, attivando approfondimenti e derive, digressioni e sviluppi in una quantità di campi pari alla somma delle risonanze fra le argomentazioni di Settis e gli interessi dei singoli lettori: filosofia, musica, scienze dell’antico e dell’arte, ma anche l’impegno politico, il teatro, il museo, la città, il tempo. Emergono ricorrenze, la ripresa di passi e citazioni particolarmente eloquenti, alcune asserzioni a chiasmo, ma anche differenze di tipo teorico e metodologico. Il risultato di questi sguardi incrociati è il disegno delle dorsali e dei temi, e la perimetrazione del lessico stesso di Incursioni: è questa la lettura corale che si legge nel volumen qui sotto.
Sullo sfondo, una questione. Interpretatio, imitatio, aemulatio; traduzione fedele, versione libera con la combinazione di più fonti; competizione creativa con il modello. Con quale di questi dispositivi concettuali si cimenta l’artista del XXI secolo che lavora, più o meno esplicitamente, in dialogo con l’antico? La risposta è sospesa e forse il nostro tempo richiede una formulazione più complessa dello stesso lessico categoriale del fare artistico. Ma questa è l’interrogazione che innerva l’atlante dell’arte contemporanea che Settis propone in Incursioni, un atlante molto tagliato, molto suo: non oggettivo, non descrittivo, non esaustivo. Sono tutti artisti, però, che in qualche misura hanno trovato in Italia una sponda importante per il loro lavoro: artisti che, per dirla ippocraticamente, hanno trovato nel cielo italiano, non sempre direttamente ma quanto meno nell’accoglienza critica, una buona ‘costituzione’ per i loro umori.
Si tratta di circostanze, di attimi propizi. Non in tutte le opere ci sono riferimenti diretti all’antico. Il nostro tempo è “out of joint”: come sa già Amleto, è fuori dai cardini, è disarticolato, non procede secondo una traiettoria predeterminata e irreversibile ma per scarti. E il kairos genera ‘al volo’ insospettati incroci, fulminanti cortocircuiti di senso. Grazie a questi cortocircuiti però lo spettatore non è più passivo ma – per dirla con Jacques Rancière – è convocato a interagire, in quanto “agisce, osserva, sceglie, paragona, interpreta”. Non dovrebbe essere sempre questo il fine dell’arte, di tutte le epoche e in tutte le epoche? La risposta che Settis con le sue Incursioni ci indica è sì, e non è solo per la felicità, a tratti scintillante, della sua scrittura, ma soprattutto, principalmente, per il metodo. Perché Settis insegna che se il metodo è rigoroso, l’illuminazione è assicurata anche su ciò che pare lontano. E si ottiene l’obiettivo primo dell’archeologo classico e non solo: comprendere il passato per progettare il futuro.
Chiudiamo con una battuta che il professor Henry Walton Jones una volta rivolse ai suoi studenti: “L’archeologia non si occupa della verità. Se vi interessa la verità, l’aula di filosofia è in fondo al corridoio”. Ha certo ragione il più celebre tra gli archeologi del nostro tempo, più noto come Indiana Jones: l’archeologia, essendo una scienza, non si occupa della verità. Ma della luce dell’intelligenza sulle cose del mondo, sì. Brilla dalle pagine di Incursioni una certezza: l’archeologo tratta, rigorosamente e politicamente, del nostro presente.
NOTA PER PINO PUCCI: Trama e ordito di questa introduzione, e più in generale il progetto stesso di questa lettura corale sull’importante lavoro di Salvatore Settis, è stata disegnata insieme a Pino Pucci tra fine dicembre 2020 e il 15 febbraio 2021. Spunti diversi e puntuali citazioni che si leggono sopra sono tratti dalle conversazioni con lui e da alcuni dei suoi scritti; fra gli altri: G. Pucci, La profezia retrospettiva. Metodo archeologico e cultura materiale, in Mondo classico: i percorsi possibili, Ravenna 1985, 165-173; G. Pucci, La prova in archeologia, “Quaderni storici” 85, a. XXIX, 1 (aprile 1994), 59-74; G. Pucci, Agency, oggetto, immagine. L’antropologia dell’arte di Alfred Gell e l’Antichità classica, “Ricerche di Storia dell'arte” 94 (2008), 35-40; G. Pucci, Warburg e l’archeologia classica, in Aby Warburg e la cultura italiana. Fra sopravvivenze e prospettive di ricerca, a cura di C. Cieri Via e M. Forti, Milano 2009, 139-147; G. Pucci, I Romani e l’arte greca: originali e copie, in L’Antichità. Roma arti visive, Letteratura, a cura di U. Eco, Milano 2009, 291-301; G. Pucci, Arte antica e disgiunzione. Il nuovo Museo dell’Acropoli di Atene, “Studi di estetica” 45 (2012), 229-242; G. Pucci, Il più antico dei moderni: un profilo di Igor Mitoraj, “teCLa. Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica” 13 (giugno 2016), 43-71; G. Pucci, I ragazzi europei reinventano il nostro passato, “il manifesto” ALIAS domenica (8 gennaio 2017), 8; G. Pucci, Chi è il barbaro? I disastri della guerra sulla Colonna Traiana, in Uomini contro. Tra l’Iliade e la Grande Guerra, a cura di A. Camerotto, M. Fucecchi, G. Ieranò, Milano 2017, 51-66; G. Pucci, Pollak. Intuizioni ed epilogo di un connoisseur, “il manifesto” ALIAS domenica (17 febbraio 2019), 7; G. Pucci, Etruschifano. Guerrieri tombe templi del ragazzo pop, “il manifesto” ALIAS domenica (3 marzo 2019), 7; G. Pucci, Eterna Niobe da Omero alla Body Art, il manifesto” ALIAS domenica (24 marzo 2019), 5; G. Pucci, La copia degli Antichi e dei (post) Moderni, in Una lezione di archeologia globale. Studi in onore di Daniele Manacorda, a cura di M. Modolo, S. Pallecchi, G. Volpe, E. Zanini, Bari 2019, 99-104; G. Pucci, Canova. Plasmare il Moderno facendo propria la lezione dell’antico, “il manifesto” ALIAS domenica (16 giugno 2019), 9; G. Pucci, L’antico nell’era della post verità. A proposito di una mostra di Damien Hirst, “Forma urbis”, a. XXIV, 5-6 (maggio/giugno 2019), 30-35; G. Pucci, Nel segno di Kronos e Kairos, quindici artisti, fra cui Jimmie Durham, Kasia Fudakowski, Rä Di Martino, creano cortocircuiti di senso nel sito degli imperatori, “il manifesto” ALIAS domenica (6 settembre 2019), 9; G. Pucci, Apollo Kounellis. La vena dionisiaca dell’artista-ierofante, “il manifesto” ALIAS domenica (9 agosto 2020), 12; G. Pucci, Jackowski. Intervista sul classico, “il manifesto” ALIAS domenica (13 settembre 2020), 6.
Non sarebbe stato possibile portare a termine il lavoro di raccolta dei contributi dei diversi autori e, soprattutto, la stessa stesura della Presentazione pubblicata qui sopra, senza il sostegno e il prezioso e puntuale supporto, pratico e scientifico, di Mara Sternini: a Mara i curatori di questa lettura corale e la redazione di Engramma esprimono tutta la loro gratitudine.
Per citare questo articolo / To cite this article: M. Centanni, G. Pucci, Incursioni. Arte contemporanea e tradizione di Salvatore Settis (Feltrinelli, 2020). Una lettura Corale, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 189-196 | PDF

1 | Sacha Sosno, Le bon gutteur, 2008. Esposto alla mostra di Londra, The Classical Now, 2018.

2 | Edward Allington, Victory Boxed, 1987. Allestito alla mostra di Londra, The Classical Now, 2018.

3 | Banksy, Adonis with Teargas, 2017, Bethlehem, The Walled Off Hotel.

4 | Mimmo Jodice, Il compagno di Ulisse, Baia, 1992.
La straordinaria efficacia de Le bon gutteur (La buona sentinella, 2008) di Sacha Sosno risiede nelle assenze messe in scena dall’opera – e nel cortocircuito che esse creano rispetto alla nozione di autorevolezza [Fig. 1]. La replica della testa antica, alla quale il colore del bronzo artificialmente ‘invecchiato’ conferisce il sapore di un venerando reperto, è interrotta, nella zona centrale del volto, da una vuota cornice poligonale. L’osservatore non può che domandarsi se la sentinella stia indossando un futuristico modello di occhiali, in grado di potenziarne la visione, o sia del tutto cieca, priva dell’organo stesso della vista. La sentinella vigila, imperscrutabile, sul rispetto di una millenaria tradizione artistica e intellettuale, oppure il suo ruolo è piuttosto quello di un segno, inanimato e privo di volontà, di un passato la cui forza normativa è negli occhi di chi guarda? Nel recente Incursioni (per i tipi di Feltrinelli, 2020), Salvatore Settis costruisce un percorso di riflessione su questi nodi e, in ultima analisi, sul concetto di ‘tradizione’, con la paziente cura per i meccanismi di scoperta, catalogazione e lettura che costituiscono l’essenza stessa del lavoro di un archeologo. Attraverso saggi dedicati a una varietà di autori e, soprattutto, di mezzi espressivi, Settis invita il lettore a interrogarsi sulle infinite declinazioni, nell’arte contemporanea, di un “atlante” d’immagini e gesti le cui radici affondano nella cultura classica e, allo stesso tempo, sui modi in cui i processi dell’arte hanno contribuito a formare e disseminare quel repertorio cui l’arte occidentale attinge da oltre due millenni.
Lo sforzo di misurare le forme e la tenacia di questo legame, nonché la dimensione di creatività che esso cela e consente, è tutt’altro che nuovo – come insegna il vivace dibattito tra gli intellettuali romani circa l’originalità di Virgilio rispetto a Omero (Weiß 2017) e, più in generale, la riflessione che, dal periodo ellenistico in avanti, sembra essersi appuntata sul confine, spesso labile, tra citazione e falsificazione (Higbie 2017). La terminologia che la critica utilizza per definire il rapporto tra l’arte del XX e del XXI secolo e la ‘tradizione’ – da ‘replica’ a ‘citazione’, ‘allusione’, ‘appropriazione’, ‘influenza’, ‘ispirazione’, ‘pastiche’, ‘prestito’, e molte altre parole ancora – è, del resto, sostanzialmente identica a quella che la Kopienkritik ottocentesca (lo studio comparativo, modellato sulla filologia classica, degli esemplari romani di un certo tipo statuario al fine di ricostruirne il modello greco perduto) ha sperimentato a proposito del nesso tra il corpus della scultura romana e il passato greco (Anguissola 2015; Cupperi 2014; Serlorenzi, Barbanera, Pinelli 2018).
La sentinella di Sosno, così come gli oggetti delle Incursioni di Settis, è esemplare dell’impossibilità di ridurre il nesso tra l’arte contemporanea e la tradizione, in particolare quella classica, a una sola, univoca chiave di lettura. Si tratta, del resto, di ricostruire i termini del dialogo con un repertorio d’immagini, parole, concetti di necessità frammentario (giacché dell’Antichità possediamo oggetti e testi filtrati da un millenario processo di degrado naturale e selezione umana), eppure ‘coerente’ nella sua percezione come una sorta di ‘totalità paradigmatica’. Privo dei tratti fisiognomici principali, il volto bronzeo di Sosno restituisce i termini di questa parzialità – alludendo a una conoscenza limitata a dati generici, periferici, rispetto agli elementi di più autentica espressività. In questo, la scelta di Sosno riprende un’idea di completezza saldamente codificata fin dall’Antichità, che individua nella rappresentazione dei tratti del volto un momento cruciale nella resa della figura umana (Cic., Fam. 1.9.5 e Off., 3.10; si veda anche l’importante catalogo della recente mostra dedicata dal Met Breuer al ‘non finito’ nelle arti figurative, in particolare nei suoi nessi con gli antecedenti classici: Baum, Bayer, Wagstaff 2016).
Le condizioni di luce e sfondo, peraltro, modificano l’impressione generata dalla scatola che sostituisce i lineamenti della sentinella: talora, essa pare uno specchio trasparente verso la realtà oltre la scultura stessa (la realtà vista ‘attraverso’ il filtro del classico); talaltra, ricorda un prisma di ‘materia grezza’ dal quale la figura sia parzialmente emersa (ribaltando, implicitamente, l’idea della bronzistica come un’arte realizzata “per via di porre”). La riflessione sui mezzi di estrazione dell’immagine dalla materia è al centro dei saggi di Settis e delle opere che in essi sono discusse. Il concetto di “traccia performativa”, formulato da Settis in occasione del simposio Detail und Aufmerksamkeit, tenutosi nel 2014 presso l’Istituto germanico di Storia dell’arte a Firenze (il contributo s’intitolava Periferie, epitomi, residui: strategie dell’attenzione) e sapientemente sfruttato ai fini delle sue Incursioni, è prezioso per comprendere il procedimento attraverso cui William Kentridge ha delineato le maestose figure di Triumphs and Laments (Incursioni, al capitolo 9) sui blocchi di travertino lungo il Tevere, in un processo di ‘estrazione’ delle scene dalla patina opaca che rivestiva la pietra. Le immagini di Kentridge paiono affiorare dalle tenaci sedimentazioni del tempo e della memoria, così come le figure in legno di Giuseppe Penone scaturiscono dal fusto stesso dell’albero generatore (Incursioni, al capitolo 7). Il “grado zero” della scultura che Penone recupera, ad esempio, in un’installazione quale Tra scorza e scorza (2003, Giardini della Reggia di Venaria Reale) rende palpabili, insieme, l’ineludibile natura materiale dell’opera, la sua forma e il gesto dell’artista che nella prima cerca (o sulla prima imprime) la seconda (Incursioni, alle pagine 211-212). Nello “stupore” e nella “sorpresa, che è data dalla materia stessa” e generata, nelle parole di Penone stesso, da una “azione del fare” (Incursioni, alle pagine 197-198), si scorge il riflesso di una lunga familiarità con il miracolo (miraculum nel lessico pliniano) della materia che muta la propria fisionomia e, meglio, della materia che in sé contiene immagini naturali, disponibili alla scoperta da parte dell’artefice (Cic., Div.1.23, 2.48-49; Plin., Nat. 16.199, 36.14, 36.134; si veda, in ultimo, Catoni 2020). La consapevolezza dei processi creativi è alla radice anche della scelta di Grisha Bruskin di dipingere in colore bianco i suoi prototipi umani in bronzo, schematiche iterazioni di veri Charakteres (se di questo acuto sguardo sui luoghi comuni di una società intendiamo ripercorrere, fino a Teofrasto, le manifestazioni), così da “farle regredire allo stato di gesso del suo remoto modello mentale” (Incursioni, al capitolo 6, pagina 175).
Nel 2018, Le bon gutteur è stato esposto a Londra nelle sale di King’s College alla Bush House e alla Somerset House, dove si dipanava il percorso di The Classical Now. La mostra, legata al progetto Modern Classicisms, come le Incursioni di Salvatore Settis si prefiggeva d’illuminare le articolazioni di un rapporto muovendo dalla prospettiva dello storico dell’arte antica (Squire, Cahill, Allen 2018). Nell’iniziativa londinese, il non-volto di metallo creato da Sosno era esposto insieme alla composizione di The Victory Boxed di Edward Allington [Fig. 2], costruita sui ritmici effetti d’iterazione di un topos e sulla sostituzione di una piatta uniformità ai potenti volumi e alla virtuosistica resa delle superfici dell’originale in marmo. Così, il vastissimo repertorio di archetipi offerto dall’Antichità classica fornisce a Dana Schutz (Incursioni, al capitolo 10) un linguaggio di straordinaria potenza per articolare un commento relativo, anzitutto, alla società contemporanea – il ricordo di Leda, posseduta dal cigno, non costituisce l’evocazione di una fonte iconografica, ma ispira una visione cruda, esasperata dalla condizione femminile. Non diversamente, l’Adonis with Teargas (o Bust of a Protester) assemblato da Banksy risponde, insieme al contesto stesso in cui è collocato, a istanze politiche strettamente attuali [Fig. 3]. Il volto è celato dietro a un foulard, in un meccanismo che sfrutta la frizione tra l’idea d’anonimità veicolata dalla maschera e l’immediata, ineludibile riconoscibilità di un prototipo classico. Consegnando a un’istantanea immobile e marmorea la frenesia della ribellione, Banksy trasfigura il soggetto dell’opera e lo trasferisce nella dimensione, remota e paradigmatica, del Classico. L’intero allestimento del Walled Off Hotel di Betlemme in cui il busto è collocato – un ambizioso quanto controverso progetto artistico, di rigenerazione urbana e lotta politica – sfrutta la discrasia tra il sapore coloniale degli arredi e la memoria di una storia traumatica, tutt’altro che conclusa. È il riferimento alla tradizione a rendere ‘classico’ un evento o, piuttosto, il ricorso al vocabolario classico riflette la consapevolezza, da parte dell’artista, dell’artificiosità di un’idea di “edle Einfalt und stille Größe” (“nobile semplicità e quieta grandezza”) che l’immaginario comune associa al concetto stesso di ‘Classico’, annullando ogni prospettiva storica e le frizioni questa implica?
Non sorprende che, in un volume scritto da un archeologo, al processo della scoperta e della sistematizzazione dei dati sia riservata un’attenzione vivissima (per lo storytelling/history-telling alla radice di tante esperienze nell’arte contemporanea si veda Roelstraete 2009). La teoria di trionfi e miserie composta da Kentridge presuppone lo sforzo di catalogare e classificare ricordi vicini o lontani, proiettati, ormai privi di scansione cronologica, sull’uniforme – ed eterna – superficie del travertino (per la fascinazione contemporanea verso i valori plastici del travertino, evidente per esempio nella poetica di Igor Mitoraj: si rimanda a Pucci 2016 e 2019b). I ‘prototipi umani’ di Bruskin emergono – vestigia di un lontano contesto – all’atto di un vero e proprio scavo (Collezione di un archeologo, si veda Incursioni, alle pagine 175-178), in maniera non diversa dai tesori di cui Damien Hirst ha immaginato e inscenato, a Venezia, il recupero da un antico relitto (Treasures from the Wreck of the Unbelievable, Venezia 2017: si veda Pucci 2019a).
Il compito dell’archeologo è, in ultima istanza, proprio quello di raccogliere la totalità delle tracce di una cultura artistica e materiale, ordinandole in un repertorio coerente, nel tentativo di colmare gli inevitabili iati tra quanto è sopravvissuto. La consapevolezza della parzialità di ciò che, del mondo antico, è giunto fino ai nostri giorni, si trova al centro degli scatti di Mimmo Jodice (Incursioni, al capitolo 4). La sapiente ricerca del movimento di Jodice cattura, con struggente partecipazione, il lavorio lento e costante del tempo che, implacabile, erode superfici, identità, ricordi. Il Compagno di Ulisse dal Ninfeo di Punta Epitaffio a Baia [Fig. 4] è il ritratto di un uomo senza volto. I contorni mossi e la superficie porosa della pietra, dall’aspetto quasi spugnoso, creano al contempo una testimonianza tangibile dello scorrere dei secoli e un paradigma umano cui sia all’infinito possibile sovrapporre la propria identità – nell’inesausta filiazione dei partecipanti al nostos odissiaco.
Il gesto con cui il fotografo ricompone il volto mutilato di una statua (Demetra, Opera I, 1992, 132) allude al lavoro di un restauratore, o di un archeologo che sia riuscito, fortuitamente, a recuperare due frammenti della stessa composizione. “Perché”, del resto, si domanda Settis, “le linee di frattura tra un frammento e l’altro non dovrebbero esser lasciate in vista, e narrarci il gesto dell’archeologo che scava, del restauratore che risana le ferite?” (Incursioni, alla pagina 141). Ciononostante, lo sguardo lirico di Jodice è lontanissimo da quello del tecnico o dello studioso – che mira a ricostruire la completezza o, almeno, a recuperarne una coerente immagine interiore. Nel volto in marmo fotografato da Jodice domina piuttosto lo scarto dei lineamenti creato dalla frattura stessa, così come i solchi e i vuoti scompongono l’immagine dei lacerti dipinti dall’oecus a giardino nella Casa del Bracciale d’Oro a Pompei (Affresco da Pompei 1982, 142), di cui le pubblicazioni archeologiche restituiscono invariabilmente, anche grazie agli strumenti digitali, l’originaria perfezione (Aoyagi, Pappalardo 2006, 189-191, 196-197, 200, 205, 209). Del pari, le azioni legate la ‘scoperta’ della Collezione di un archeologo di Bruskin altro non sono che il ribaltamento del metodo archeologico: se, nel lavoro dell’archeologo, la sistematizzazione dei materiali interviene dopo il loro recupero, così da mettere ordine in ciò di cui il caso ha determinato la sopravvivenza, la tassonomia sovietica elaborata di Bruskin precede la dispersione e il sotterramento dei suoi membri.

5 | Oliver Laris, Kopienkritik, 2011, Basilea, Skulpturhalle.
La medesima tensione a ricostruire un passato paradigmatico (perché lentamente divenuto, nella memoria collettiva, un corpus concluso) ma frammentario (e dunque fondamentalmente disorganico) è al centro della ricerca di Oliver Laric, che nel progetto collettivo L’image volée curato da Thomas Demand (Demand 2016) ha rivisitato l’esperienza di Serial Classic, precedente iniziativa della sede milanese della Fondazione Prada (Settis, Anguissola, Gasparotto 2015; vedi Galleria della mostra in Engramma). Attraverso lo sguardo di Laric, la statua di Penelope (che pure è un originale greco ‘seriale’, ripetuto poi in numerose repliche romane) diventa un solitario simbolo d’attesa, mentre tenui colori pastello attribuiscono una leziosa dimensione fiabesca alla stampa delle opere già raccolte in Serial Classic. In un allestimento di alcuni anni precedente, ospitato presso la Skulpturhalle di Basilea (2011, a cura di Raffael Dörig), Laric affrontava l’ineludibile arbitrarietà di ogni sforzo di ricomposizione e l’artificiosità che ne è l’esito [Fig. 5]. Nella cornice dei candidi calchi in gesso di figure quasi identiche (versioni diverse di stessi ‘tipi’ statuari), strumento essenziale per l’esercizio combinatorio dell’archeologo, il metodo della Kopienkritik assume le forme di teste in resina di celebri tipi policletei, la cui imperturbabile fisionomia è scomposta in fasce colorate [Fig. 6], a restituire sia il procedimento intellettuale che la ‘critica delle copie’ presuppone, sia la natura composita del suo risultato (prodotto della selezione e unione di parti di sculture diverse, sulla base di una – presunta – fedeltà al modello perduto).

6 | Oliver Laris, Kopienkritik, dettaglio di una testa, 2011, Basilea, Skulpturhalle.
La lettura di Settis cattura il complesso equilibrio tra il ricorso ad archetipi profondamente radicati nella coscienza e l’atto, consapevole, della ricerca di modelli nella memoria individuale e collettiva. Il gesto catturato nelle opere di Mimmo Jodice, di strappare una fotografia in due pezzi per poi ricomporli (Incursioni, alle pagine 138-140), si ripete nel processo analitico dello studioso che smembra le immagini, vi riconosce i segni di un linguaggio antico e li ricuce, infine, nella trama di un dialogo ininterrotto. L’accostamento di segmenti a colori e altri in bianco e nero (Incursioni, alla pagina 138) segna, nelle fotografie ricomposte di Jodice, il cambiamento di passo legato al graduale disvelamento dell’oggetto o dell’evento, alle oscillazioni e alla diversa vividezza delle memorie. In maniera analoga, l’Incursione nell’immaginario topografico di Tullio Pericoli (Incursioni, al capitolo 5) ripercorre i meccanismi di scomposizione, isolamento e sintesi attraverso i quali il pittore si appropria del paesaggio. Così, i saggi di Settis illuminano la mutevolezza e la vivacità del rapporto – diretto o mediato, inconscio o ponderato – tra l’arte contemporanea e la tradizione classica, in una lezione che parla anzitutto del mondo d’immagini in cui viviamo e, per chi dello studio dell’Antichità abbia fatto il proprio mestiere, di come l’interminabile processo di conoscenza del passato possa farsi, esso stesso, gesto archetipico e memoria.
Riferimenti bibliografici
- Anguissola 2015
A. Anguissola, “Idealplastik” and the Relationship between Greek and Roman Sculpture, in E.A. Friedland, M. Grunow Sobocinski, E. Gazda (eds.), The Oxford Handbook of Roman Sculpture, Oxford 2015, 240-259. - Aoyagi, Pappalardo 2006
M. Aoyagi, U. Pappalardo (a cura di), Pompei (Regiones VI-VII), Insula Occidentalis, Napoli 2006. - Baum, Bayer, Wagstaff 2016
K. Baum, A. Bayer, S. Wagstaff (eds.), Unfinished: Thoughts left Visible, New York 2016. - Catoni 2020
M.L. Catoni, Parian Marble and “quella che si fa per forza di levare”, in A. Anguissola, A. Grüner (eds.), The Nature of Art. Pliny the Elder on Materials, Turnhout 2020, 157-170. - Cupperi 2014
W. Cupperi (a cura di), Multiples in Pre-Modern Art, Zürich-Berlin 2014. - Demand 2016
T. Demand (ed.), L’image volée, Milano 2016. - Higbie 2017
C. Higbie, Collectors, Scholars, and Forgers in the Ancient World, Oxford 2017. - Pucci 2016
G. Pucci, Il più antico dei moderni: un profilo di Igor Mitoraj, “TeCLa. Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica” 13 (2016), 43-71. - Pucci 2019a
G. Pucci, L’antico nell’era della post-verità. A proposito di una mostra di Damien Hirst, “Forma Urbis” 14, 5/6 (2019), 30-35. - Pucci 2019b
G. Pucci, Una pietra scabrosa. Sculture moderne in Travertino, in M.A. Tomei, R. Borgia (a cura di), Lapis Tiburtinus. La lunga storia del Travertino, Tivoli 2019, 159-166. - Pucci 2020
P. Pucci, Ulisse. Un eroe umano per questi tempi di crisi, “Alias” (11 ottobre 2020), 8. - Roelstraete 2009
D. Roelstraete, The Way of the Shovel: on the Archaeological Imaginary in Art, “e-flux Journal” (marzo 2009). - Serlorenzi, Barbanera, Pinelli 2018
M. Serlorenzi, M. Barbanera, A. Pinelli (a cura di), Il classico si fa pop. Di scavi, copie e altri pasticci, Milano 2018. - Settis, Anguissola, Gasparotto 2015
S. Settis, A. Anguissola, D. Gasparotto (a cura di), Serial / Portable Classic. The Greek Canon and its Mutations, Milano 2015. - Squire, Cahill, Allen 2018
M. Squire, J. Cahill, R. Allen (eds.), The Classical Now, London 2018. - Weiß 2017
P. Weiß, Homer und Vergil im Vergleich. Ein Paradigma antiker Literaturkritik und seine Ästhetik, Tübingen 2017.
Per citare questo articolo / To cite this article: A. Anguissola, Le tracce dell'archeologo, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 197-206 | PDF
In dialogo con Salvatore Settis su Incursioni
Maurizio Bettini
Dato che di Incursioni. Arte contemporanea e tradizione ho avuto l’opportunità di discutere direttamente con l’autore nel gennaio scorso – in un incontro virtuale organizzato dal Centro AMA e dal DFCLAM dell’Università di Siena – mi è venuto quasi spontaneo dare un tono colloquiale al mio intervento: quasi che, nel formulare le mie riflessioni, mi stessi di nuovo rivolgendo a Salvatore. In questo modo mi è sembrato di mantenere vivo, per quanto possibile, il momento di quella discussione e dell’appassionante lettura che l’aveva preceduta – certo uno dei più lieti in un tempo così difficile.
Questo libro ha un sottotitolo che può sconcertare, ma nello stesso tempo dice tutta l’importanza e soprattutto la novità della riflessione che svolgi: Arte contemporanea e tradizione ha infatti l’aria di un ossimoro, mette insieme due termini che, nella percezione comune, suonano incompatibili o quasi. L’arte contemporanea, soprattutto agli occhi dei profani, è infatti sinonimo di rottura con la tradizione e, in molti casi, certo lo è. Ragion per cui quando si coglie qualche ‘eco’ della tradizione artistica passata in un’opera contemporanea, la critica fa ricorso, come dici, a un vocabolario molteplice, una Babele di termini: allusione, appropriazione, citazione, influenza, ispirazione, manipolazione, pastiche, prestito, riferimento, uso … In effetti la retorica sistematizzatrice è sempre in agguato, pronta a creare categorie e schemi, com’è avvenuto con i rapporti testuali interni ai testi nella teoria letteraria. Ho ancora vivida memoria di questo ingabbiamento in caselle retoriche dei – spesso presunti – rapporti fra testi, soprattutto poetici. Meno male che quell’onda mi pare ormai passata, lasciando solo poche tracce di spuma. Al contrario, in Incursioni tu ammetti la possibilità di individuare un principio unificante, che possa collocare anche l’arte contemporanea nella longue durée della pratica artistica: la “tradizione artistica” appunto. A questo proposito citi un motto (attribuito a Gustav Mahler) che colpisce per la sua profondità: “Tradizione non è adorare la cenere, ma custodire il fuoco”. Credo proprio che, più o meno consciamente, sia stato questo motto a ispirarti lungo la stesura del libro: nella tradizione artistica hai messo da parte la cenere e hai cercato (e trovato) ogni volta la favilla che ardeva.
Di conseguenza mi pare che il tuo lavoro presenti due caratteristiche che lo rendono unico e – mi auguro – destinato a fungere da modello per future ricerche sull’arte contemporanea: da un lato infatti si affida a una impalcatura teorica solida e chiara, derivata dall’idea di “tradizione artistica” elaborata da Julius Schlosser e dalle Pathosformeln della Mnemosyne warburghiana; dall’altro c’è una rigorosa attenzione (ancora warburghiana) alla ricostruzione filologica degli elementi tràditi. Ogni volta, cioè, il ‘testo’ pittorico viene decostruito attraverso una serie di passaggi che mostrano concretamente il cammino compiuto attraverso la “tradizione artistica”. Si tratta della operazione che, prendendo a prestito una formula creata da Pinelli, definisci “reverse engineering” nei confronti dell’opera, lo smontaggio all’indietro degli elementi che la compongono. Nello stesso tempo, la cura non più filologico-verticale, ma, vorrei dire, antropologico-orizzontale, ti permette di riconnettere l’opera a ideologie o forme culturali ad essa contemporanee, le quali hanno ‘premuto’ sulla realizzazione dell’opera, facendone ciò che essa è all’interno di questo momento della tradizione. In altre parole, mostri la necessità (e la tua capacità) di penetrare nel repertorio delle figure interiori dell’artista, cercandovi indizi per comprendere anche i meccanismi della memoria sociale e di quella che Warburg chiamava “psico-storia”. Che è anche quello che ti permette di integrare l’immagine nel più vasto contesto ideologico, sociale, di bisogni, anche di polemiche e progetti, che l’immagine ri-proposta comunica relativamente al tempo in cui è creata.
Da questo punto di vista credo che uno dei saggi diciamo più ‘warburghiani’ della raccolta sia quello dedicato a Renato Guttuso: Arte e delitto. Guttuso e la morte di Neruda (Incursioni, alle pagine 65 e ss.). Perché mi è parso che in questo caso il “reverse engineering” della decostruzione filologica (l’individuazione del tipico “braccio della morte”, Pathosformel presente già nella tradizione antica; le immagini della morte di Marat che stanno dietro il disegno di Guttuso; le varie opere che Guttuso ha a sua volta dedicato a Marat) si intreccia con una ricerca più vasta sugli indizi, anche esterni all’opera, necessari per comprendere i rapporti di amicizia, le posizioni politiche, l’ideologia che legano l’autore al soggetto e al suo tempo (la memoria sociale, la “psico-storia” di Warburg). Sempre in questa direzione, poi, una piccola perla (piccola solo perché il saggio è più breve di altri), è costituita per me dalla riflessione svolta a proposito di The Visible World di Dana Schutz (Incursioni, alle pagine 339 e seguenti). In questo caso l’accurato, e spesso sorprendente, smontaggio filologico dell’opera della pittrice americana (il riconoscimento di Leda nella figura femminile sdraiata sullo scoglio; l’identificazione del Cigno nell’uccello che la sovrasta; il gesto del braccio abbandonato; e così via) si accompagnano all’individuazione degli intensi sentimenti femministi che animano la pittrice e alla denuncia dello strapotere maschile sulla donna. Temi fortemente sentiti dalla pittrice e altrettanto fortemente attuali.
A proposito di questo quadro mi è anzi accaduto da fare una riflessione sul tema dei ‘racconti’. Quando si parla di memoria culturale relativamente alla tradizione figurativa, infatti, occorre tener conto, come tu fai, del fatto che molte di queste immagini – sto parlando di immagini classiche, o bibliche – vengono assieme a un racconto che le motiva: nel senso che esse rappresentano anche personaggi di una vicenda narrativa. Così la “Leda in ceppi” di The Visible World non richiama solo un’immagine pompeiana o un dipinto che rimonta a Michelangiolo, ma un mito di persecuzione e seduzione in cui sappiamo che Zeus ha inseguito Leda, regina di Sparta, e l’ha violentata finalmente sotto forma di un cigno; la testa tagliata di Giovanni, o quella di Oloferne, ci giungono sotto forma di immagini celebri ma anche all’interno di racconti in cui questi personaggi sono vittime di una donna, Salomè o Giuditta: le quali per motivi diversi hanno voluto la decapitazione di un uomo. E così via. Ora già Dan Sperber, ne Il contagio delle idee, ci aveva mostrato come le rappresentazioni, in generale, circolino molto di più, e molto meglio, se sono inserite o accompagnate da un racconto. Nel meccanismo che Sperber definisce “epidemiologia delle credenze” si può constatare che le rappresentazioni, le quali si presentano sotto forma di racconto, risultano più stabili e durature di altre.
Il lavoro che hai svolto su Giuseppe Penone (Incursioni, alle pagine 187 e ss.) – un artista che sappiamo esserti particolarmente vicino – mi è parso poi che si muovesse entro orizzonti più vasti. La tua ricerca, a raggio davvero ampio stavolta, parte infatti dalla cultura greca, che nella forma di una colonna, in legno o pietra, ‘leggeva’ la figura umana; dalla consustanzialità, per dir così, fra l’uomo e l’albero, enunciata nella filosofia greca, presente poi in Plinio il vecchio (quando l’autore latino afferma che gli alberi hanno carne e vene) per trionfare nelle Metamorfosi di Ovidio (Dafne ovviamente); e ancora questa consustanzialità si ripresenta nel Dante del Convivio, quando l’autore fa asserire all’imperatore Federico “Omo è legno animato”; e poi in Leonardo, che lo riprende nella sua pratica anatomica, affermando che “il core è nocciolo che genera l’albero di vene …” (Incursioni, alla pagina 215).
Ora tutto questo in certo senso confluisce nell’opera di Giovanni Penone, la cui arte straordinaria ‘ritrova’ l’albero dentro il tronco o la trave, scavandola; che ‘fa crescere’ con lo sviluppo del tronco, dentro il tronco, una mano di bronzo (da qui l’interesse di Penone per l’Apollo e Dafne di Bernini, a motivo di quella mano di Apollo che ‘schiaccia’ la gamba della Ninfa). Ecco, in questa riflessione su Penone, e sulla sua arte, mi pare di veder agire una memoria culturale diversa rispetto a quella che si articola in Mnemosyne. Una memoria più vasta, che non è fatta solo di immagini, ma di modelli culturali, di rapporto uomo/natura, al punto che l’artista, per potere rappresentare qualcosa, deve prima farsi tale e quale alla cosa che intende rappresentare. Come afferma Dante ancora nel Convivio, che tu riporti (Incursioni, alla pagina 223): “chi pinge figura / se non può esser lei, non la può porre”. Anche se neppure Penone, certamente, si sottrae a una dimensione memoriale diciamo maggiormente consona ai principi warburghiani più classici: come nel caso dell’albero che sostiene fra i suoi rami (senza foglie) un sasso, e in questo modo si richiama all’Ercole Farnese.
E poi c’è il tableau vivant di Marcel Duchamp (Incursioni, alle pagine 39 e ss.), la sua testa tagliata poggiata sul tavolo, la compagna drappeggiata e dallo sguardo lontano. Anche in questa analisi metti in azione la decriptazione filologica dei diversi elementi che compongono la scena: la testa tagliata, quella che rimanda a Giuditta e Oloferne, ma anche a Orfeo (un poeta, un cantore, un artista) la cui presenza in filigrana non è evocata solo dalle immagini classiche della sua testa mozzata, ma anche dagli elementi bacchici, kantharos e tralcio d’edera, che compaiono nelle diverse versioni dell’opera. Anche in questo caso, insomma, il “reverse engineering” del filologo dà i suoi frutti, mettendo in luce i fili di immagini e di simboli i quali hanno il potere di mantenere anche questa singolare composizione dentro una tradizione artistica che va molto indietro nel tempo.
E poi c’è il metro, il misterioso metro che si snoda accanto alla testa mozzata dell’artista. Di questa singolare presenza tu dai già una spiegazione esauriente, molto ‘in contesto’ con la poetica di Duchamp. Ma avendo a che fare con un artista del genere, vorrei concludere queste brevi riflessioni proponendoti un’altra interpretazione, che, trattandosi di un personaggio come Duchamp, non esclude ovviamente quella che hai formulato. Sappiamo che l’artista amava molto i giochi di parole, le sciarade, gli anagrammi. Anche il suo stesso nome, e per opera sua, è andato incontro a diverse metamorfosi – dagli pseudonimi femminili all’anagramma omofonico con cui si designa: Marchand du Sel, in cui i fonemi che compongono il suo ‘vero’ nome si rimescolano in modo suggestivo. Già molti anni fa Maurizio Calvesi ha messo in luce questa passione di Duchamp, così connaturata al suo stile e al suo personaggio, per anagrammi, rebus, sciarade, acronimi, “contrepèteries”. E dunque, se il ‘mètre’ che si snoda sul tavolo, accanto alla testa dell’artista, fosse lì per indicare il ‘maître’, il maestro?
Per citare questo articolo / To cite this article: M. Bettini, In dialogo con Salvatore Settis su Incursioni, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 207-211 | PDF

1 | Giuseppe Penone, Alpi marittime. Continuerà a crescere tranne che in quel punto, 1968-2003, albero (Ailanthus altissima) e bronzo, bosco di San Raffaele Cimena (Torino).
Il volume di Salvatore Settis prova come, una volta acquisito un metodo filologico, si possa “vagare da un soggetto all’altro”, si possano effettuare Incursioni nelle varie categorie storiche, dall’Antico al Rinascimento fino al Contemporaneo, muovendosi in terreni insondati senza dover essere specialisti “fosse un secolo, un artista, un tema”. Lo studioso di archeologia e dell’eredità della cultura classica, “straniero in ogni luogo” – ma per questo il suo lavoro connotato da un sapere vivo – consegna al pubblico una serie di saggi dedicati ad artisti di epoca moderna, che non rompono con la tradizione, ma piuttosto trasformano nel presente il passato, parte integrante del loro processo creativo.
Il metodo di Settis si plasma sulla lettura dell’opera d’arte contemporanea fatta di materia che, grazie alla mano e al pensiero dell’artista, respira, quando non vive essa stessa, come nel caso del legno cavato dagli alberi, “materia primordiale dell’architettura e della scultura”. Giuseppe Penone, “come avesse appreso la sua lezione di vita e d’arte nell’ombra di una foresta dell’antica Grecia”, lavora sulla ‘crescita’ degli alberi, la scultura è l’albero stesso che cresce divenendo vita. Una mano fissata a un tronco sarà inglobata dall’albero (Ailanthus altissima e bronzo, Alpi Marittime [Fig. 1]), un innesto possibile commentato già da Plinio, il quale, nella Storia naturale, agli alberi dedica ampio spazio (XII-XVII), e ricorda che nell’agorà di Megara:
Si trovava un ulivo selvatico molto antico a cui dei guerrieri valorosi avevano affisso le loro armi [di bronzo], che dopo moltissimo tempo avevano finito per essere incorporate nel tronco, diventando invisibili. Da quell’albero dipendeva il destino della città: un oracolo aveva infatti predetto che essa sarebbe andata in rovina se mai un albero avesse generato delle armi. Ed è proprio quello che avvenne, quando l’albero fu tagliato, e ne emersero elmi e schinieri (Plinio, Nat. Hist. XVI, 199).
Quella di Penone è dunque arte derivata dalla contaminazione uomo-natura e la mano scolpita, integrandosi nelle viscere dell’albero, crea un passaggio dal mondo animale a quello vegetale. L’artista imprime il suo gesto nella materia, “non tanto una forma predeterminata, ma una traccia performativa”. Negli anni in cui (1968 circa) vi era un divieto di creare l’oggetto, Penone “riparte dall’estetica dell’object trouvé” che viene “de-oggettificato in quanto ri-naturalizzato” (Incursioni, alla pagina 198).

2 | Maestro del Codice Squarcialupi, Paride incide il nome di Enone sulla corteccia di un faggio, particolare, primo quarto del XV secolo, Milano, Biblioteca Ambrosiana, S.P. 13 bis, c. 18r.

3 | Miniaturista francese del XVI secolo, Storie di Enone. Al centro: Enone scrive a Paride. A sinistra: Sogno di Ecuba; Giudizio di Paride. Sotto: Paride ed Enone incidono i loro nomi sulla corteccia di faggi, Paris, Bibliothèque Nationale de France, Richelieu Manuscrits Français 873, c. 27v.
Oltre a richiamare Plinio, Settis si sofferma su Ovidio, il poeta della vita palpitante del cosmo, delle Metamorfosi del corpo umano in albero, come nel caso di Dafne che, inseguita da Apollo, prega di perdere figuram (I, 545) e, presto, si avvede che il tenero petto si cinge di sottile corteccia, i capelli si mutano in fronde, le braccia in rami, i piedi si fissano in radici, il volto diventa una cima. La lingua plastica e la fervida immaginazione di Ovidio, così come la mano e il pensiero di Penone, dal largo respiro, trasmettono la “ininterrotta fluidità degli oggetti di natura, la stretta parentela fra i viventi”.
Lo scultore modella e intaglia il legno, l’amante lo incide, la mano di entrambi è guidata dal cuore. Da parte mia vorrei rammentare ancora il poeta latino, quello delle Heroides, in cui si trova il tema dell’incisione, della scritta sulla corteccia, che si dilata con la crescita dell’albero. Nella Epistula V, la protagonista è la ninfa Enone, amante di Paride sul monte Ida dove l’eroe era stato esposto dopo il sogno funesto di Ecuba di dare alla luce una fiaccola che commutava in fiamme la città di Troia. Una volta avuta in premio Elena, dopo l’arbitraggio fra le tre dee, Paride abbandona la ninfa che, per prima, gli aveva fatto conoscere l’amore. La fanciulla nella epistola ricorda i bei momenti trascorsi con l’amato di cui i faggi sono testimoni: l’eroe tracciava con il falcetto il nome dell’amata sulla corteccia tenera del tronco e le lettere si ingrandivano con la crescita dell’albero.
I faggi incisi da te conservano il mio nome, si legge ‘Enone’ scritto dal tuo falcetto. E quanto crescono i tronchi, altrettanto il mio nome: crescete ed ergetevi ritti per attestare i miei titoli! Ricordo che c’è un pioppo piantato sulla riva del fiume: sulla sua corteccia è scritta una lettera a ricordo di me. O pioppo, vivi, ti prego: tu che, piantato al bordo della riva, porti questa iscrizione sulla rugosa corteccia: “Quando Paride potrà respirare, dopo avere abbandonata Enone, l’acqua dello Xanto, tornando indietro, correrà alla sua sorgente” (Ovidio, Heroides V, 23-32).
Il tema si riscontra in pittura e nei codici miniati come nell’Ambrosiano S.P.13 bis [Fig. 2], che contiene il volgarizzamento delle Eroidi del traduttore fiorentino Filippo Ceffi, un manoscritto realizzato a Firenze nel primo quarto del Quattrocento, in cui si alternano, nelle carte, ventiquattro raffinatissimi disegni acquerellati. È anche l’unico testimone di questa traduzione che presenti almeno una miniatura per ognuna delle epistole di Ovidio, concepita dal Maestro del Codice Squarcialupi (Zaggia, Ceriana 1996, 32). Alla c. 18r, entro un paesaggio agreste, solcato da un fiume, l’eroe troiano incide con il falcetto, sulla corteccia di un faggio, il nome di Enone, la quale è munita di arco e di faretra, attributi che la connotano come cacciatrice, e si ritroveranno nella pittura domestica (Caciorgna 2004, 91-158; Caciorgna 2015). In ambito francese, si segnala la traduzione delle Heroides di Octavien de Saint-Gelais, dedicata a Carlo VIII e contenuta in vari manoscritti preziosamente decorati. In particolare, un codice della Biblioteca Nazionale di Parigi Richelieu Manuscrits Français 873, c. 27v [Fig. 3] comprende ventuno pagine miniate che mostrano, per lo più, l’immagine dell’eroina nell’atto di scrivere la lettera al suo amante (Caciorgna 2008, 37-39).
Nella vignetta centrale della miniatura francese, Enone, una figura solitaria contro la foresta di esili alberi, indossa una solenne veste rossa ed è intenta a scrivere la lettera a Paride che si allontana con la sua nave. Il momento evocato dall’artista è quello del tragico abbandono in cui l’eroe troiano parte con la sua flotta. Il soffio marino gonfia le vele ed Enone accompagna con lo sguardo la nave che si allontana sul mare. Intanto la spiaggia si bagna delle lacrime della ninfa (Ovidio, Heroides V, 55-58). Alle spalle dell’eroina la foresta richiama il periodo trascorso insieme dai due amanti quando Paride apprendeva l’arte della caccia da Enone, e gli mostrava i luoghi in cui le fiere riparavano i piccoli, tendeva le reti e conduceva i cani veloci sulla vetta dell’Ida (Ovidio, Heroides V, 19-22). Sul lato sinistro della miniatura è rappresentato l’antecedente della storia di Enone e Paride con Ecuba gravida che sogna di dare alla luce la fiaccola che incendierà Troia. Sotto si prospetta il Giudizio di Paride, mentre nella parte inferiore l’episodio di Paride che incide sulla corteccia le lettere del nome dell’amata (Ovidio, Heroides V, 23-32).
Penone, lo scultore degli alberi, ha realizzato un faggio in bronzo a grandezza naturale, quello di Otterlo [Fig. 4], un albero che si confonde con altri faggi, quelli veri. Nel tempo la scultura “ha assunto una patina che la assimila alla scorza dei suoi fratelli di legno […] l’artista ribadisce e precisa la sua ricerca sperimentale, in una spola incessante fra la spontaneità della natura e la propria (non meno naturale) creatività” (Incursioni, alla pagina 209).

4 | Giuseppe Penone, Il faggio di Otterlo, particolare, 1988, bronzo, Otterlo, Museo Kröller-Müller.
In tempi ancora recenti, le faggete erano luogo di passeggiate in cui uomini e donne lasciavano i segni del proprio amore nei tronchi, cuori trafitti oppure un nome (Caciorgna 2008-2010). Anche questa è ormai tradizione, superata da whatsapp, facebook, instagram, messaggi che si imprimono o perdono nella rete. Ma anche l’opera d’arte, costituita come l’uomo da materia, non sempre è eterna, muore e si trasforma.
Riferimenti bibliografici
- Caciorgna 2004
M. Caciorgna, Il naufragio felice. Studi di Filologia e Storia della Tradizione Classica nella cultura letteraria e figurativa senese, Sarzana (La Spezia) 2004. - Caciorgna 2008
M. Caciorgna, Da Ovidio a Domenico da Monticchiello. Presenza e connotazioni paradigmatiche delle Heroides nella cultura senese del Rinascimento, in Siena nel Rinascimento: l’ultimo secolo della Repubblica, atti del convegno promosso dall’Università di Warwick e da quella di Siena, con la collaborazione del centro Warburg Italia, Siena, Accademia degli Intronati, (Siena, 28-30 settembre 2003, Graduate College di Santa Chiara, Aula Magna), Siena 2008, 37-70. - Caciorgna 2008-2010
M. Caciorgna, Exempla amantium. Scritte d’amore sulle cortecce degli alberi e moduli elegiaci. Testo e immagine nella tradizione classica, dall’umanesimo all’epoca contemporanea, “Fontes. Rivista di Filologia, Iconografia e Storia della tradizione classica” 11/13 (2008-2010), 1-33. - Caciorgna 2015
M. Caciorgna, Francesco di Giorgio Martini and workshop, Fragment of a spalliera panel of the Abduction of Helen of Troy. The flight of Helen’s Attendants, in Carl Brandon Strehlke, Machtelt Israëls (eds.), Catalogue of the European Paintings in the Berenson Collection (Villa I Tatti Series), Milano 2015, 267-272. - Della Casa
A. Della Casa, traduzione e cura di, Publio Ovidio Nasone. Opere, Torino 1982. - Zaggia, Ceriana
M. Zaggia, M. Ceriana Zaggia, I manoscritti illustrati delle "Eroidi" ovidiane volgarizzate, Pisa 1996.
Per citare questo articolo / To cite this article: M. Caciorgna, Da Enone a P-enone. Incidere alberi vivi, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 212-218 | PDF
1
Molte le sollecitazioni che provengono dal libro di Salvatore Settis Incursioni. Arte contemporanea e tradizione. A partire dalla iniziale e necessaria delimitazione di campo fra le moltissime accezioni e i moltissimi contesti d'uso del termine tradizione. Entro il perimetro disegnato dalla nozione di tradizione come trasmissione delle pratiche sociali, culturali, artistiche e tecniche, secondo la declinazione di Julius Schlosser da un lato (Incursioni, alle pagine 14-16), e come trasmissione del linguaggio figurativo e stilistico classico che riemerge a distanza di tempo nelle manifestazioni artistiche post-antiche, secondo la declinazione di Aby Warburg dall'altro lato (Incursioni, alle pagine 18-37), si muove l'analisi, condotta con rigoroso metodo filologico, dei dieci casi esaminati in questo libro. Mi soffermerò su due aspetti che lo innervano per intero e che trovo di particolare interesse perché permettono, anzi implicano, anche un movimento inverso, dal contemporaneo all’antico. Le incursioni proposte in questo libro, infatti, non solo sperimentano l'uso di alcuni strumenti propri della ricerca storica, storico artistica, archeologica e filologica nell'analisi di contesti caratterizzati da un elevato grado di complessità – come sono i contesti, in movimento, dell'arte contemporanea (incluso il cinema). Esse invitano anche a tornare all’antico con un bagaglio di domande rinnovato o precisato, e a tornarvi con strumenti affinati proprio grazie alla complessità e densità documentale che caratterizza l’analisi dei contesti artistici contemporanei. Fra molti, sono due i versanti che sollecitano la mia riflessione: il primo è il rapporto fra la spinta alla codificazione e cristallizzazione degli schemata e la spinta all’adattamento e all’innovazione nelle produzioni artistiche anche dell’Antichità; il secondo versante ha a che fare con la storia di lungo periodo dei diversi modi di articolare nel medium visuale discorsi meta-artistici (inclusa la consapevolezza del fare artistico), che implicano una potenziale rottura dell’illusione e l’inclusione nell’immagine di riferimenti, per esempio, alla materia e alla techne con cui essa è prodotta. Questa spola fra il ‘dentro e fuori’ la techne include anche, fra le sue incarnazioni non visuali, l'uso esemplare e analogico del fare artistico entro contesti letterari anche di tipo riflessivo e scientifico, che indagano pratiche di natura diversa dalle technai visuali (per esempio l’operare della natura, la costruzione dei modelli politici, etc.).
2
Il tempo e lo spazio sono le due discriminanti più evidenti fra la prospettiva di analisi della tradizione come trasmissione di pratiche di bottega in contesti relativamente contenuti e omogenei e la prospettiva warburghiana adottata nella concezione e costruzione dell’Atlante Mnemosyne. Entrambe le prospettive sono accomunate dalla concretezza delle pratiche artistiche e dei materiali nei quali la tradizione prende corpo. Quest’ultima, anche se osservata entro lo spazio più angusto – quello di una bottega artigianale in un luogo e tempo determinati – implica sempre processi di manipolazione e trasformazione. Come ben evidenziato in questo libro, entrambe le prospettive, in modi diversi, si muovono fra due poli potenzialmente in conflitto, quello della spinta alla trasformazione, adattamento e manipolazione di schemata e forme da un lato, e quello della spinta alla loro cristallizzazione e codificazione, che garantiscono riconoscibilità e riusabilità dall’altro lato. Una variabile di particolare rilevanza per entrambe le prospettive è la multimedialità, osservabile negli usi sia antichi sia post-antichi del repertorio di forme e formule visuali codificate, accanto alla concomitante variabilità dei contesti di uso e di riuso. La multimedialità degli schemata è un tratto che, anche con solo riguardo all’Antichità classica, emerge non soltanto al livello di pratiche artistiche e di attestazioni visuali ma anche entro contesti riflessivi, che permettono di rilevare un altissimo grado di consapevolezza, nell’Antichità, del fatto che la possibilità che uno stesso schema – riconoscibile come tale – sia impiegabile entro media diversi garantisce la costruzione e la persistenza di un vocabolario stabile di forme e di valori (Catoni 2008). Esempi particolarmente chiari in tal senso offrono le rappresentazioni antiche di figure di danza, il cui alto grado di codificazione permette di osservare con più facilità il loro comportamento entro sistemi (materiali, formali o narrativi) diversi che costituiscono, diciamo così, altrettanti stress-test: si può ad esempio osservare il grado e tipo di costrizioni e rigidità riconducibili all’esigenza di riconoscibilità dello schema come anche gli spazi di costrizione o libertà di manipolazione riconducibili al medium o al contesto formale, narrativo e figurativo nei quali un determinato schema di danza è raffigurato o, ancora, gli spazi di nuovi significati, anche allusivi, che la rappresentazione di un determinato schema di danza in un determinato contesto narrativo apre.
Questo libro sollecita un ritorno all’analisi del funzionamento delle arti visuali nell’Antichità con strumenti affinati, in particolare per quanto riguarda sia lo studio del ruolo dei diversi media e contesti d’uso di schemata e dispositivi stilistici nell’orientare i significati sia l’analisi delle modalità di produzione delle immagini. Per quanto una produzione altamente seriale come è quella, ad esempio, della ceramica attica a figure nere e a figure rosse non presenti mai due vasi con figure identiche, è possibile però in alcuni casi rilevare l’uso dello stesso ‘cartone’ per realizzare figure diverse (si pensi, per citare un esempio, alla figura di Thorykion sul lato A di un’anfora attica a figure rosse firmata da Eutimide e la figura designata come Ettore dal nome inscritto su un’altra anfora firmata dallo stesso pittore [Figg. 1-2].

1 | Euthymides, Ettore si arma fra Priamo ed Ecuba [nomi iscritti], ca. 510-500 a.C., anfora attica a figure rosse, ex Vulci, München, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, inv. 2307. (Foto Bibi Saint-Pol, Creative Commons license.)
2 | Euthymides, Thorykion si arma fra due arcieri sciti Mae[...]g[.] e Euthybo[los], ca. 510-500 a.C., anfora attica a figure rosse, ex Vulci, München, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, inv. 2308. (Foto Bibi Saint-Pol, Creative Commons license.)
Anche in un contesto molto lontano da quello della ceramica attica, in alcune serie di affreschi pompeiani per esempio, è possibile seguire il migrare di elementi iconografici da una composizione all’altra e, nei casi più interessanti, fra composizioni diverse per rappresentare lo stesso soggetto o fra soggetti diversi (McNally 1985; Ghedini 1993; Bragantini 2004; Colpo 2005; Colpo 2006; Colpo 2007; Catoni-Osanna 2018). Casi come questi sono ormai da molto tempo considerati dagli studiosi preziose occasioni per studiare i meccanismi di funzionamento delle botteghe artigianali come anche l’uso e la trasmissione di modelli (Settis 1973; Ghedini 1997; Settis 2006; Settis 2008; Zanardi 2012): ma ciò che questo libro sollecita è lo studio di questi stessi casi come elementi degli ecosistemi cui le immagini appartengono, nei quali valgono regole proprie e specifiche e nei quali i media e i contesti figurativi o narrativi agiscono sulle forme e sugli schemata imponendo costrizioni o aprendo spazi di libertà di manipolazione o adattamento.
Questa possibilità di un ritorno all’antico con una strumentazione affinata, emerge a mio avviso nel modo più chiaro dall’analisi genetica condotta da Settis sul fregio di William Kentridge Triumphs and Laments (Incursioni, alle pagine 275-337) e sul film Il rito di Ingmar Bergman (Incursioni, alle pagine 103-131), in cui lo studio morfologico si intreccia con quello dei nuovi significati che letteralmente deflagrano dall’accostamento, in un nuovo contesto e in un nuovo medium, di schemi e formule iconografiche provenienti dai contesti culturali e cronologici più diversi nel primo caso, o dall’attivarsi di nuovi drammatici significati e allusioni a partire da un contesto determinato (quello dell’affresco nel grande triclinio della Villa dei Misteri) nel secondo caso. La stessa attenzione anche al ruolo che nella creazione di nuovi significati e linguaggi visuali giocano i media nei quali forme e suggestioni iconografiche si trasmettono e vengono reimpiegate è ben presente nello studio della fotografia di Marcel Duchamp ‘intitolata’ da Settis stesso Doppio Ritratto (Incursioni, alle pagine 38-63), del disegno di Renato Guttuso che rappresenta la morte di Neruda (Incursioni, alle pagine 65-101) come anche dei “conti con l’arte” di Bill Viola (Incursioni, alle pagine 233-273).
Questa spola fra l’antico da un lato e i contesti e i media della sua tradizione dall’altro lato, e viceversa, fu già d’altra parte l’oggetto della doppia mostra “Serial/Portable Classic” a cura di S. Settis, A. Anguissola, D. Gasparotto (Milano e Venezia 2015: v. una Galleria della mostra in Engramma) che puntava lo sguardo anche sui media e le pratiche artistiche proprie sia della costruzione del repertorio di forme classiche sia della loro trasmissione e riuso in contesti cronologici e geografici diversi da quelli in cui esse furono elaborate.
3
Seguendo questo stesso filo a ritroso rispetto al percorso del libro, dal contemporaneo all’antico, le analisi proposte da Settis di alcune opere di Mimmo Jodice e di Tullio Pericoli (Incursioni, alle pagine 133-145 e 147-163) sollecitano anche (oltre all’interessante problema della rappresentazione del tempo entro un medium statico) una riflessione sul rapporto, per così dire, fra dentro e fuori l’arte. Gli strappi e le artefatte frammentazioni di Jodice come anche il linguaggio paesaggistico della pittura di Tullio Pericoli impongono quasi all’osservatore un discorso che irrompe da fuori lo spazio figurato e che, entrando nell’ecosistema delle immagini, è forzato ad assumere i necessari tratti visuali per esistere nello spazio e nel genere della narrazione fotografica o pittorica. In un libro di qualche anno fa Luca Giuliani propose una lettura della pittura vascolare cosiddetta “a soggetto teatrale” basata su alcune regole di genere rispettivamente della commedia e della tragedia antiche (Giuliani 2013): se il genere della commedia antica consentiva, anzi prescriveva, la temporanea rottura dell’illusione scenica, in particolare nel momento meta-poetico della parabasi, il genere della tragedia non prevedeva tali sospensioni dell’illusione narrativa e scenica. Queste stesse regole di genere spiegano, secondo Giuliani, alcune convenzioni della pittura vascolare, per esempio quella di rappresentare esplicitamente come tali elementi della finzione teatrale (maschere, palcoscenico, personaggi) nelle rappresentazioni di commedie ma non in quelle tragiche.
Tornando all’antico col bagaglio di domande poste dal libro di Salvatore Settis, sarebbe forse possibile porre il problema in termini diversi e chiedersi quali sono, nei diversi contesti cronologici e culturali, i modi in cui negli ecosistemi delle immagini le arti visuali includono riflessioni meta-artistiche. Si potrebbe farlo a cominciare addirittura dai kouroi arcaici, un tipo scultoreo che prevede che il blocco di marmo dal quale il kouros è tratto ‘traspaia’, resti visibile nella statua finita (Barringer 2014; Dietrich 2017; sulle erme analizzate da questa prospettiva si può vedere Catoni 2020); e si potrebbe continuare ricordando il messaggio di orgoglio prevalentemente tecnologico (e commerciale) suggerito dall’iscrizione poetica ( [τ]ο͂ αϝὐτο͂ λίθo ἐμὶ ἀνδριὰς καὶ τὸ σφέλας) incisa sulla base del colosso alto 10 metri con la sua base, dedicato dagli abitanti di Nasso nel santuario di Apollo a Delo fra la fine del VII e l'inizio del VI secolo a.C. [Figg. 3-4-5].

3 | Torso frammentario di kouros monumentale identificato col Colosso dei Nassi (porzione superiore, lato posteriore), Delo, area del Santuario di Apollo. (Foto Harry Meyer, Institute for the Study of the Ancient World. Creative Commons license.)
4 | Torso frammentario di kouros monumentale identificato col Colosso dei Nassi (porzione superiore, lato anteriore), Delo, area del Santuario di Apollo. (Foto Harry Meyer, Institute for the Study of the Ancient World. Creative Commons license.)
5 | Torso frammentario di kouros monumentale identificato col Colosso dei Nassi (porzione inferiore), Delo, area del Santuario di Apollo. (Foto Zde. Creative Commons license.)
L’iscrizione ricorda che la statua e la base sono dello stesso blocco di marmo [Fig. 6]: le dimensioni colossali e le caratteristiche visuali della statua e della sua base dovevano destare meraviglia anche, ma forse soprattutto – come suggerisce l’iscrizione – per la capacità di evocare valori e significati legati al materiale, all’enormità e peso dei blocchi di marmo utilizzati e conseguentemente alla straordinaria capacità tecnologica dei Nassi di cavarli, trasportarli, scolpirli ed erigerli (Chamoux 1990; Martini 1990, 218; Hermary 1993; Gruben 1997; Giuliani 2005; Giuliani 2006; Martini 2006; Queyrel 2014; Martini 2018, riprendendo l'ipotesi di Hermary 1993, considera i frammenti oggi a Delo come i resti della statua che nel IV secolo a.C. rimpiazzò quella più antica).

6 | Base frammentaria inscritta del Colosso dei Nassi (lato posteriore), Delo, area del Santuario di Apollo. (Foto Olaf Tausch. Creative Commons license.)
È evidente che la possibilità di analizzare nel lungo periodo i modi in cui l’arte può tematizzare se stessa o discorsi meta-artistici nel medium visuale deve ancorarsi alla specificità dei casi analizzati (si veda per esempio Anguissola 2018) perfino quando ci si trovi di fronte a espressioni che divengono topiche. Lo stesso Settis notava, a proposito dell’interpretazione dell’espressione ex uno lapide riferita da Plinio al gruppo del Laocoonte (Plinio, Nat. Hist. XXXVI, 37; Settis 1999, 42 e 79-81), la vitalità di questo modo di fare riferimento al materiale (il marmo) nel contesto pliniano ma non soltanto:
La maestria tecnica degli scultori in marmo viene perciò lodata in vario modo, e in particolare ricorrendo ben quattro volte, in rapida successione, all’espressione ex uno lapide (in un caso ex eodem lapide), riferita a opere di grande complessità compositiva [...] (Settis 1999, 42).
Ogni contesto nell’ecosistema delle immagini va analizzato iuxta propria principia. Ma fra gli strappi di Jodice e il blocco di marmo che resta visibile o che parla di sé nella scultura greca arcaica, esiste un filo, che è quello della possibilità di articolare nel medium visuale una spola fra dentro e fuori l’arte.
Riferimenti bibliografici
- Anguissola 2018
A. Anguissola, Supports in Roman Marble Sculpture. Workshop Practice and Modes of Viewing, Cambridge 2018. - Barringer 2014
J.M. Barringer, The Art and Archaeology of Ancient Greece, Cambridge 2014. - Bragantini 2004
I. Bragantini, Una pittura senza maestri: la produzione della pittura parietale romana, “Journal of Roman Archaeology” 17 (2004), 131-145. - Catoni 2008
M.L. Catoni, La comunicazione non verbale nella Grecia antica, Torino 2008. - Catoni 2020
M.L. Catoni, Parian Marble and ‘Quella che si fa per forza di levare’, in A. Anguissola, A. Grüner (eds.), The Nature of Art: Pliny the Elder on Materials, Turnhout 2020, 157-170. - Catoni, Osanna 2018
M.L. Catoni, M. Osanna, Arianna a Nasso. Un nuovo affresco dalla Regio V 5 di Pompei, “Bollettino d'Arte” 39-40 (2018), 5-46. - Chamoux 1990
F. Chamoux, L’Epigramme du Colosse des Naxiens à Délos, “Bulletin de Correspondance Hellenique” 114 (1990),185-186. - Colpo 2005
I. Colpo, La formazione del repertorio. Immagini di Ganimede dall’area vesuviana, “Eidola” 2 (2005), 67-93. - Colpo 2006
I. Colpo, Quod non alter et alter eras. Dinamiche figurative nel repertorio di Narciso in area vesuviana, “Antenor. Miscellanea di studi di archeologia” 5 (2006), 51-85. - Colpo 2007
I. Colpo, Circolazione di schemi nella formazione del repertorio mitologico di IV stile a Pompei: l’immagine di Endimione seduto, in Circulación de temas y sistemas decorativos en la pintura mural antigua, a cura di C. Guiral–Pelegrín, Calatayud 2007, 77-82. - Colpo, Ghedini 2007
I. Colpo, F. Ghedini, Schema e schema iconografico: il caso di Ciparisso nel repertorio pompeiano, “Eidola” 4 (2007), 49-69. - Dietrich 2017
N. Dietrich, Framing Archaic Greek Sculpture. Figure Ornament and Script, in V. Platt, M. Squire, The Frame in Classical Art. A Cultural History, Cambridge 2017, 270-316. - Ghedini 1993
F. Ghedini, Arte romana: generi e gesti, in S. Settis (a cura di), Civiltà dei romani. Un linguaggio comune, Milano 1993, 161-178. - Ghedini 1997
F. Ghedini, Trasmissione di iconografie, in Enciclopedia dell'Arte antica, II suppl. (1997), V, 824-837. - Giuliani 2005
L. Giuliani, Der Koloss der Naxier, in L. Giuliani (ed.), Meisterwerke der antiken Kunst, München 2005, 12–27. - Giuliani 2006
L. Giuliani, „Aus demselben Stein bin ich“. Zum Verständnis der Inschrift an der Basis des Naxier-Kolosses auf Delos, in A. Dostert, F. Lang (hrsg. von), Mittel und Wege. Zur Bedeutung von Material und Technik in der Archäologie, Möhnesee 2006, 101-112. - Giuliani 2013
L. Giuliani, Possenspiel mit tragischem Helden. Mechanismen der Komik in antiken Thetherbildern, Göttingen 2013. - Gruben 1997
G. Gruben, Naxos und Delos. Studien zur archaischen Architektur der Kykladen, “Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts” 112 (1997), 261-416. - Hermary 1993
A. Hermary, Le colosse des Naxiens à Délos, “Revue des Etudes Anciennes” 95 (1993), 11-27. - Martini 1990
W. Martini, Die archaische Plastik der Griechen, Darmstadt 1990. - Martini 2006
W. Martini, Bild und Wort, Vortrag Kolloquium „IkonoTexte–Duale Mediensituationen“ (Kleine Mommsen–Tagung. 17-19. Februar 2006; pdf a questo link). - Martini 2018
W. Martini, Der Koloss der Naxier. Eine Revision, “Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Institus” 133 (2018), 27–47. - McNally 1985
S. McNally, Ariadne and Others: Images of Sleep in Greek and Early Roman Art, “Classical Antiquity” 4.2 (1985), 152-192. - Queyrel 2014
F. Queyrel, Apollon et le colosse des Naxiens, “Revue Archéologique”, 2 (2014), 245-258. - Settis 1973
S. Settis, Mys figlio di Hermias: un toreuta del secolo IV a.C., “Studi Classici e Orientali” 22 (1973), 169-171. - Settis 1999
S. Settis, Laocoonte. Fama e stile, Roma 1999. - Settis 2006
S. Settis, Il Papiro di Artemidoro: un libro di bottega e la storia dell’arte antica, in C. Gallazzi, S. Settis (a cura di), Le tre vite del papiro di Artemidoro. Voci e sguardi dall’Egitto Greco-Romano, Torino 2006, 20-65. - Settis 2008
S. Settis, Il contributo del papiro alla storia dell’arte antica, in C. Gallazzi, B. Kramer, S. Settis (a cura di), Il Papiro di Artemidoro (P. Artemid), Milano 2008, 581-616. - Zanardi 2012
B. Zanardi, “Hic catagrapha invenit, hoc est obliquas imagines” (Plin., Nat. Hist., XXXV 56). L’uso del disegno nella pittura antica, in P. Clini (a cura di ), Vitruvio e il disegno di architettura, Venezia 2012, 61-83.
Per citare questo articolo / To cite this article: M. L. Catoni, Qualche nota su Incursioni: dal contemporaneo all'antico, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 219-229 | PDF

1 | Ritratti di Antinoo. Da sinistra a destra: Testa da busto in marmo, Venezia, Museo di Palazzo Grimani; Testa in bronzo, Firenze, Museo archeologico nazionale; Testa da busto in marmo, ex Villa Adriana, Cambridge, Fitzwilliam Museum; Testa da statua in marmo, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών; Testa da busto in marmo, Berlin, Antikensammlung; Testa dal busto dell’Antinoo Ecouen, ex da Villa Adriana, Paris, Musée du Louvre.
“Le temps, ce grand sculpteur”
Il tempo è un grande scultore, così scrive Marguerite Yourcenar. E una parola ‘vera’, come vera è ogni parola poetica. Vera prima di tutto perché trasfigura l’immagine di Chronos traducendo l’attività vorace e rapace del tempo in un verso – l’emistichio di un alessandrino – in sé magnifico: “Le temps, ce grand sculpteur”. Il tempo, scrive Yourcenar, agisce sulle opere d’arte. Ma con più rapido ed evidente effetto scolpisce i tratti del nostro volto, le curve, gli addolcimenti e gli irrigidimenti del nostro corpo.
Quel tenero corpo s'è modificato di continuo, a guisa di una pianta e queste alterazioni sono imputabili all'opera del tempo. Il fanciullo mutava: si faceva grande. Bastava una settimana d'indolenza per intorpidirlo; un pomeriggio di caccia gli rendeva la solidità, lo scatto dell’atleta. Un'ora di sole lo faceva mutare dal colore del gelsomino a quello del miele. Le gambe un po' pesanti del puledro si andavano man mano allungando; la gota perdeva la delicata rotondità infantile, s'incavava leggermente sotto lo zigomo sporgente; il torace gonfio d'aria del giovane corridore allo stadio lungo assumeva le curve lisce e polite d’un seno di Baccante. Il broncio delle labbra s'impregnava di un’amarezza ardente, d’una sazietà triste. In verità, quel volto mutava, come se ogni notte e ogni giorno io lo avessi scolpito (Yourcenar [1951] 19812, 147).
Adriano, che si sente “responsabile della bellezza del mondo”, crede di essere stato lui ad aver fatto mutare – notte per notte, giorno per giorno – la grazia adolescente dell’amato, ad averla corrotta e scalfita. Ma non è stato lui: è il tempo cattivo e inesorabile che scandisce il declino del volto e del corpo di Antinoo. E sarà Adriano, invece, saranno i suoi artisti che “scolpiranno” quel corpo e quel volto in molte versioni e li affideranno a quella “specie di magia” che è l’opera d’arte. Grazie agli artisti, il corpo e il volto di Antinoo sono rimasti impressi nel marmo e nel bronzo; di più, quel volto e quel corpo sono vivi oggi, sono vivi per noi. E tutti siamo, ancora, innamorati di Antinoo.
Il filo del tempo in Incursioni
Si vede bene l’azione del tempo nella serie dei ritratti di Antinoo; si vede bene osservando i segni sul nostro stesso corpo. Il tempo, con intensa energia, agisce sugli esseri viventi con un doppio effetto: allentamento e irrigidimento. Demolisce l’integrità del vivente, scomponendo via via l’armonia, la compostezza; ma, contemporaneamente, indurisce le giunture, fa perdere elasticità agli snodi e alle connessioni, irrigidisce le pieghe del nostro sentire e delle nostre espressioni, fino a farne rughe del volto e dell’anima. Sui corpi il tempo produce cedimenti o rigidità; nelle opere, interagendo con la materia di cui sono fatte, produce memoria o rovina – non arte. Il tempo non è già l’attore ma può essere un ingrediente importante dell’opera d’arte. Ma per fare arte, usando anche l’azione del tempo, ci vuole la mano dell’artista.
In Incursioni, Salvatore Settis si mette alla prova nell’indagare non tanto la verità di quel che è stato, quanto piuttosto come quel passato agisce dando sfondo al presente e come, viceversa, lo sguardo che muove dal presente, al passato può dare colore e smalto: tutti i saggi qui raccolti rispondono a un’urgenza che è la passione del presente. C’è un filo nella trama di questo libro, un filo che brilla nel tessuto di una scrittura scintillante e preziosa e che corre sotto l’accurato ordito di metodo. Il filo che vedo brillare e che mi piace tirare qui è il fattore tempo. Così già scriveva Settis, cimentandosi nella lettura di una delle sciarade più difficili dell’arte rinascimentale, la Tempesta di Giorgione:
Una scena nata come da una immaginata e non mostrata ‘diluizione’ del racconto, e dove invece i segni dei suoi momenti successivi sono come ‘contratti’ e tuttavia completamente sciolti nel paesaggio ‘morale’: il serpente (la Colpa), l’arboscello [che copre parzialmente ‘Eva’] (la Vergogna), il fulmine (la Maledizione), Adamo (il Lavoro), Eva (il Parto), le colonne (la Morte), Caino (il Delitto e la Dannazione). ‘Riducendo’ Dio al fulmine, il serpente a una presenza appena percettibile, rappresentando la Morte con le colonne spezzate, e il Delitto con Caino ancora innocente, Giorgione ha evitato che il suo quadro si riducesse a un accumulo di momenti narrativi; con straordinaria intelligenza egli ha saputo mostrare ciascuno degli ‘elementi’ della tela – che noi abbiamo voluto scomporre – in funzione della rappresentazione di un solo istante, che contenesse in sé, per così dire, tutto il passato e tutto il futuro (Settis 1978, 107).
“Un solo istante” – l’istante in cui quel fulmine taglia e illumina il cielo – che raccoglie in sé “tutto il passato e tutto il futuro”. Settis coglie un elemento centrale che non mira a decrittare il significato dell’opera, ma serve a comprenderne il senso: il tempo dell’opera rinascimentale impara dal tempo grammaticale antico l’assolutezza aoristica che riassume il racconto e i suoi diversi momenti in un’immagine istantanea, componendo armonicamente, sinotticamente, gli spezzoni cronologicamente dispersi (perché necessariamente progressivi) della narrazione. Il tempo rinascimentale è un tempo ‘greco’, che non prevede alcuna idea di consecutio.
Vale per il tempo nell’arte del Rinascimento; vale anche per l’analisi di Settis sull’opera degli artisti contemporanei in cui il fattore tempo è oggetto della stessa attenzione. È così che in Giuseppe Penone (al quale è dedicato il capitolo 7 di Incursioni) gli alberi scolpiti, dei quali sono pur rintracciabili antecedenti importanti nelle fonti antiche, sono un soggetto “radicalmente nuovo”, in cui è implicata, insieme, “densità materica” e “temporalità metaforica cariche di storia” (Incursioni, alla pagina 32). Rimarcando con forza la “dignità della materia”, l’artista intende riaffermare, con senso di orgogliosa soggettività, la sua responsabilità. Ed è proprio il fatto che “l’aspettativa di permanenza di materiali come il marmo o il bronzo implica il confronto con le pratiche e gli usi degli scultori nel passato” a far sì che alla potenza della materia l’artista debba corrispondere in modo simmetrico:
Vale la pena di fare scultura solo quando se ne avverta una vera necessità. I materiali tradizionali, analizzati mentre vengono lavorati, rivelano perché in passato sono stati usati con tanta frequenza: il cerchio si chiude, e la radicale novità della scultura di Penone finisce per riannodarla con le sorgenti stesse (i materiali) della tradizione (Incursioni, alla pagina 205).
In questo senso, a Penone non basta il “legno del bosco”. Serve Il tempo, e un tempo che abbia una particolare qualità: che sia elastico, non unidirezionale ma aperto in direzione del futuro e del passato. Così non è soltanto lo scorrere del tempo che l’artista inserisce nel disegno della sua opera programmandone la successiva mutazione: grazie all’opera, il tempo si fa reversibile e così l’albero “sotto lo scalpello dello scultore ritrova dentro di sé la forma e la sottigliezza che ebbe qualche decennio fa” (Incursioni, alla pagina 32). In questa pratica, che implica l’uso attivo del tempo, Settis riconosce tracce della dendrocronologia, la conta degli anelli di crescita annuale degli alberi in uso anche per la datazione archeologica: l’arte di Penone è dunque una particolare forma di archeologia che si può definire come archeologia della materia naturale, ma, anche, come “archeologia del sé”:
La mano dello scultore, tradotta nel metallo, fa tutt’uno con l’albero e ne viene col tempo divorata: perciò scavare nel tronco ingenera una sorta di archeologia del sé, che riporta alla luce un istante della vita dell’artista (Incursioni, alla pagina 195).
Per ciò, animata dal “respiro del tempo” l’opera di Penone è “scultura che avviene” (Incursioni, alla pagina 220), sia oggettivamente, per quanto riguarda l’opera, sia, soggettivamente, per quanto riguarda lo stesso artista:
Quella di Penone non è ‘un’arte senza tempo’, e sarebbe anzi impensabile senza una temporalità vibrante che si mette in mostra, si presta alla descrizione, si fa racconto. Racconto non di miti o storie, ma di quel perpetuo processo naturale che è la sua scultura (Incursioni, alla pagina 206).
Anche nel capitolo di Incursioni dedicato a Mimmo Jodice, Settis segue il filo del tempo, elemento cruciale nella pratica dell’artista, dal momento in cui il fotografo impugna la macchina fotografica, trattandola
[…] come la matita del disegnatore, il pennello del pittore, lo scalpello dello scultore. Come se il processo, tecnico ma anche artigianale, con cui la pellicola, una volta impressionata, viene manipolata nella camera oscura e trasfigurata in immagine degna di portare la sua firma abbia una segreta fratellanza con la mano del coroplasta che modella l’argilla (Incursioni, alla pagina 135).
In questo senso Jodice, che legge “sotto la specie della fotografia ogni altra forma d’arte del nostro tempo”, per il carattere della sua immaginazione, per la sua strumentazione tecnica e sapienza artigianale, ma soprattutto per l’uso che fa del tempo, è scultore ‘a cera perduta’ prima che fotografo:
Tanta […] è la distanza fra il semplice snapshot che un obiettivo può registrare e l’esito finale dell’elaborazione a cui Jodice costringe i suoi negativi, che il suo processo creativo può forse meglio assimilarsi a quello della scultura in bronzo. Nella fusione a cera perduta, perché la statua prenda forma adeguandosi all’idea dello scultore è necessario passare per fasi successive, dal modello all’armatura, all’‘anima’ di terracotta, alla sua tunica di cera, alla ‘camicia’ di argilla con gli sfiatatoi, alla finale cottura e fusione, alla rifinitura a freddo (Incursioni, alla pagina 135).
Nell’opera di Jodice alla “laboriosa selezione dei soggetti e delle inquadrature” consegue, “un bruciante processo di metamorfosi lirica”. E quel che conta è il fine che consiste nel manipolare “la materia per trasportarla in un suo regno interiore. E per farlo nostro” (Incursioni, alla pagina 135).
L’appropriazione sottesa a ogni atto d’artista si compie in Jodice anche mediante l’adozione delle “foto con strappo” un genere che Settis sente come concettualmente il più prossimo ai temi archeologici:
Protagonista indiscusso è il gesto dell’artista, la mano che interviene sulla superficie della carta fotografica, a operarvi un taglio netto […], o a strappare una foto in due pezzi, poi ricomponendoli, talvolta con un passaggio dal colore al bianco e nero (Incursioni, alla pagina 139).
È un gesto doppio che strappa e che ricuce: un gesto per cui il soggetto dell’opera non viene compromesso ma esaltato, e l’esito che ne esce è “arricchito di nuove dimensioni, il movimento e il tempo, che il gesto provvisoriamente distruttivo dell’artista gli ha donato” (Incursioni, alle pagine 138-139)
Nel capitolo dedicato a Triumphs and Laments di William Kentridge, l’archeologo potrebbe accomodarsi concentrandosi sull’identificazione dei modelli delle singole scene e dell’insieme della pompé che l’artista mette in scena sulla riva del Tevere. Settis lo fa, per exempla, ma l’attenzione metodologica per i meccanismi di attivazione della inventio dell’artista prevale sempre sul facile gioco del riconoscimento erudito. Ma lo studioso mette soprattutto in evidenza due dispositivi che l’artista mette in campo, uno concettuale, l’altro tecnico.
Il primo è l’idea che un elemento importante che ispira il concetto generale dell’opera e le posture delle sue singole figure sia il potenziale di “inversione energetica” che pulsa in ogni Pathosformel. Già dal titolo, l’opera di Kentridge pone l’accento sul controcanto luttuoso del trionfo (sul tema si veda di recente Pucci 2017, con bibliografia), ma lo sguardo di Settis, in questo caso nelle sue vesti di profondo studioso del pensiero di Warburg, trova nell’opera contemporanea esempi importanti e puntuali dell’applicazione del composto di ‘caldo’ e di ‘freddo’ che precipita nella formula patetica, e della complessità insita nel dispositivo ermeneutico che non si lascia mai decodificare in modo univoco. Nel moto, vitale o mortale, entusiastico o disperato, gioioso e luttuoso, che abita nella ‘formula di pathos’ e che la anima, non si trova certo una conferma del panofskyano “principio di disgiunzione” tra forma e contenuto, che sarebbe la prova di un’ignoranza del tema (ad esempio, nell’artista medievale) o di una disattenzione o disinteresse al tema (ad esempio, nell’artista contemporaneo). Si tratta piuttosto, al contrario, della più solenne e sonora smentita di una separazione tra significante e significato. La stessa intensità del pathos, l’esasperazione della passione a un suo grado superlativo che alimenta il sovraccarico energetico e consente il rovesciamento di una formula, con paradossale capovolgimento di senso, può essere convertita dall’artista nel polo contrario della passione. In queste coordinate Kentridge sceglie una modalità nuova, e tutta sua, per confrontarsi con la storia che è chiamato a rappresentare:
Kentridge ha qui inventato una narrazione marcatamente dis-continua, dove i sentimenti ingoiano gli eventi, le date e i fatti naufragano nel grigio terreno tra memoria e oblio. Ha esercitato in pieno, e in proprio, la “sovranità dell’artista” (Incursioni, alla pagina 322).
Ma c’è anche il dispositivo tecnico su cui Settis attira la nostra attenzione, e che ha a che fare, ancora una volta, con il tempo. Per comporre la sua teoria di trionfi e lamenti – trionfi/lamenti, come coppia in endiadi, non oppositiva – Kentridge adotta una temporalità che fa epifania monumentale nel presente, ma più in profondità investe in un senso sul passato, sul futuro nell’altro. Sul passato Kentridge investe adoperando come materiale di costruzione della sua opera, la materia stessa che il tempo ha prodotto, la patina nerastra che il tempo ha posato sui blocchi di travertino che fanno sponda al fiume:
Calati uno per uno dall’alto del parapetto del Lungotevere, gli stencils di Kentridge sono stati fatti aderire al muraglione nel luogo prescelto per ciascuna figura, servendo da guida ad alcuni operai che con violenti getti d’acqua hanno rimosso dai blocchi di travertino una parte della patina nerastra che li copriva. Alla fine del processo, il ‘nero’ è quello della patina superficiale, risparmiato dai getti d’acqua, mentre il ‘bianco’ corrisponde al colore naturale del travertino, che gli idropulitori hanno messo allo scoperto (Incursioni, alle pagine 291-292).
Un gioco al negativo, dunque, in cui il fregio (e la stessa ars pingendi) emerge ‘per via di levare’, ‘per sottrazione’: non già dai cartoni bianchi predisposti dall’artista e applicati con la tecnica dello stencil, ma dai ritagli ripuliti dalla patina del tempo. Il calcolo sull’azione del tempo non è rivolto soltanto al passato (ovvero, a levare la materia che il tempo ha già fisicamente prodotto), ma è rivolto a sfruttare anche l’azione futura del tempo: perché quella patina rimossa a forza di getto d’idranti, presto si riformerà. E anche su questo l’artista, strategicamente, investe. Pare un ossimoro: ma l’affresco monumentale dell’artista sudafricano è programmaticamente effimero. È reversibile, non solo in senso concettuale per forza di “inversione energetica”, ma è anche tecnicamente programmato per scomparire, grazie al (per colpa del) tempo.
Per il tempo aoristo in cui cui l’opera è (sarà – ancora per poco) leggibile, resta la forza del progetto che si avvale di un set tanto importante quanto solitamente invisibile: la teoria delle immagini trionfali e luttuose di Kentridge ha non solo come fondale, ma come scenario di grande presenza il Lungotevere. Forse non è un caso che soltanto qualche mese prima rispetto alla inaugurazione dell’opera di Kentridge, un’altra opera aveva restituito al Tevere il regime di visibilità che meriterebbe, e che al fiume di Roma è da secoli negato. L’inaugurazione di Triumphs and Laments è stata il 21 aprile del 2016; nel febbraio del 2016 usciva nelle sale cinematografiche Lo chiamavano Jeeg Robot (presentato alla Festa del Cinema di Roma nell’autunno precedente), il grande film di Gabriele Mainetti in cui il Tevere è insieme quinta e protagonista dell’azione, serbatoio mitico di energie oscure e potenti.
Il filo rosso che attraversa e lega i saggi di Settis, diventa importante e trova il suo punto di forza nella lettura dell’opera di Bill Viola (Incursioni, al capitolo 8). Con Paolo Fabbri, Salvatore Settis è stato tra i primi in Italia a impegnare sulla poetica di Bill Viola uno sguardo non sedotto dall’apparente facilità delle sue opere, l’attrazione accattivante, ma spesso superficiale, che ha decretato il successo di pubblico (prima e forse più che di critica) della video-arte dell’artista newyorkese.
L’esercizio di stile dello studioso del passato è rintracciare il precedente formale di un’opera come Catherine’s Room del 2001 (presa come esemplare di altre del genere), non già nel ‘polittico’, come il titolo stesso apposto all’installazione ingannevolmente suggerisce, ma piuttosto nelle predelle che “accompagnano e commentano” l’opera maggiore allestita come Pala d’altare. È la forma ‘cinematografica’ di un racconto per atti distinti, una biografia svolta per scene di quotidianità. Anche in questo caso, come sempre nell’arte di Bill Viola, il tempo entra in gioco in modo speciale: qui – nelle predelle che raccontano, in modalità continua o frammentata, la vita della santa, che si traduce in scene di vita profana negli schermi della Catherine’s Room – il tempo lavora nelle modalità della simultaneità, della compresenza, ma anche dello spiraglio dato allo spettatore che, in posizione defilata, può osservare l’intimità di uno spazio, e di azioni nel tempo, che solitamente gli sono preclusi. Ha scritto Paolo Fabbri:
L’immobilità frequente della sua camera produce, come il circuito chiuso di una televisione, l’effetto di un presente duraturo e di illimitata simultaneità che conservano la fluidità della metamorfosi e la discontinuità della iniziazione. Una animazione interna e un irraggiarsi del visibile (Fabbri 2011).
E quel che vale per Catherine’s Room (e vale puntualmente nei modi che Settis indica), vale per ogni opera di Bill Viola. Infatti si potrebbe dire che non c’è opera di Bill Viola che si regga senza la componente tempo (sull’uso del tempo nell’opera dell’artista, v. in Engramma, Alfieri 2011): il senso di tutto il corpus dell’artista sta nell’uso del tempo, trattato come un ingrediente di base nel disegno dell’opera – dalle predelle all’esperienza mistica, insieme sapienziale e necromantica, di Ocean Without a Shore (sul quale si rimanda al magistrale contributo di Fabbri 2009).
Trittico
Salvatore Settis ci propone con Incursioni un Atlante, tutto suo, dell’arte contemporanea. E però, così facendo, ci chiama a corrispondergli. Sempre sul filo del tempo, arrivando, invece che partendo, da Bill Viola, propongo una lettura che compone tre opere: il Cristo morto di Hans Holbein a Basilea; la Resurrezione di Piero a San Sepolcro; Emergence di Bill Viola (opera alla quale Settis dedica pagine importanti), che con le due precedenti nel mio piccolo Atlante fa trittico.
Trittico. Quadro 1, la Morte

2 | Hans Holbein, Cristo morto nel sepolcro, 1521, olio su tavola, Basilea, Kunstmuseum.
NeI Cristo morto di Basilea, il cadavere del Dio-Uomo è costretto dentro le misure claustrofobiche della tavola-sarcofago, appena sufficienti per contenere un corpo (30,5 cm x 200 cm). La tavola non è stata mutilata, quindi la dimensione è quella originale: secondo parte della critica il dipinto non aveva funzione di predella d’altare, ma fu concepito come opera a sé stante. Le misure riproducono dunque, esattamente, lo spazio interno al sarcofago; nell’inventario Amerbach del 1586 il quadro viene descritto come “un dipinto di morto di H. Holbein su legno con colori a olio”; una nota aggiunta a margine del testo tiene a precisare “cum titulo Jesus Nazarenus rex”.
Cristo sta disteso, all’interno della cassa-tomba: sta di per sé nella sua iperrealistica carnalità, come espressione estrema della morte. Il dio incarnato non sarebbe stato tale se non fosse passato per l’esperienza ultima, definitiva e definitoria dell’umano. La rigidità delle membra grigie ed emaciate, la contrazione della mano destra, lo spasmo del volto, la fissità dello sguardo, sono amplificate dall’assoluto isolamento della figura serrata e compressa nello spazio angusto, ormai nettamente separato dalla passione del mondo esterno. Qui, ora, non ci sono Marie che esprimono con varie voci e varie posture il teatro del dolore, non c’è nessuna Maddalena, non c’è più nessun lamento, nessun dolore della Madre, delle altre Marie, dell’amato Giovanni: non è più il cadavere molle portato di peso nel lenzuolo funebre; non è il cadavere raccolto dalla Madre che lo tiene tra le sue braccia, come un bimbo tragicamente tornato nel suo grembo. È finito il compianto e nessun pathos giunge più a toccare questo corpo chiuso nella tomba, contratto ora nel rigor mortis: morte rigida, secca – anche perché disseccata di ogni lacrima, di ogni compassione. Il silenzio astratto dello spazio stretto e conchiuso ci dice l’orrore tutto umano, solo umano, della fine.
“Un dipinto di morto”: l’inventario registra e restituisce seccamente la nettezza della visione: Cristo non è che “un morto” e nel tempo che l’artista cattura e restituisce al nostro sguardo, in questo spazio, in questo tempo, parrebbe morto per sempre. L’artista permette al nostro sguardo di sfondare lo spazio chiuso della cassa-tomba, dove dovrebbe stare, muto impassibile solo, il morto soltanto. E noi non possiamo che contemplare quel tempo: nella visione di Holbein, Cristo, per un istante assoluto, è veramente e definitivamente morto e grazie all’artificio ci è concesso di ascoltare il silenzio del tempo della morte di dio. È un tempo rappresentato per la prima e ultima volta come irredimibile, che corrompe, consuma la carne fino a irrigidire il corpo prima vivente nella fissità assoluta. È il tempo, breve e infinito, della morte di Dio: è questa immagine in cui, come voleva Platone nel Timeo, “il tempo che chiamiamo Chronos”, altro non è che il “ritratto dell’eternità” (Platone, Timeo 37c: εἰκὼ […] αἰῶνος ὃν δὴ χρόνον ὠνομάκαμεν).
Trittico. Quadro 2, la Resurrezione

3 | Piero della Francesca, Resurrezione, particolare, ca. 1458, affresco, San Sepolcro, Museo civico.
L’artista, può scegliere quale tempo usare nella sua opera, e può redimere lo stesso tempo dalla consegna di essere ritratto dell’eterno, in cui Chronos finisce per coincidere con la corruzione e poi con la morte. Può presentare nella sua opera l’istante della salvezza: così fa Piero a Sansepolcro.
In primo piano i quattro soldati, seduti, non già dormienti, ma sognanti, nel clima rarefatto imposto dall’epifania di Cristo alle loro spalle. Perché quell’epifania si vuole assoluta, non vuole avere spettatori. Per questo, l’artista sceglie non già il tempo della narrazione, ma un tempo sospeso, un attimo eterno. Le quattro figure sono colte in posture del tutto innaturali. La più scomoda e impossibile è la posa del soldato di destra: il braccio destro puntato a terra all’indietro, il busto sospeso, il capo riverso. I due soldati centrali hanno le palpebre abbassate; sembra che siano stati investiti da una magia pesante e potente che grava su di loro: impossibile aprire quegli occhi, grave la forza che li ha incantati. Il soldato di sinistra, le mani sul volto che premono sulle palpebre, denuncia che quel sonno è artificio, una necessaria auto-esclusione per evitare la potenza della visione – il fotogramma di un attimo non ancora redento, ancora disperato.
Dietro, il paesaggio è rigorosamente ripartito dalla figura centrale. A sinistra la morte della natura; alberi secchi e il terreno (per quanto si può apprezzare dallo stato dell’affresco) tutto brullo. A destra la stessa specie di alberi invece è virente, svettante di foglie (sulla lettura del fondale dell’opera di Piero come ‘icona’ del tempo, v. Cacciari 1997, 154; Cacciari 2007, 32); la terra di fondo è scura, marrone-rossastra, ma cespugli verdi alludono alla vita; una torre, una casa segnano che della vita fa parte l’habitat artificiale costruito dall’uomo.
Al centro lui, il corpo maestoso: con la mano destra impugna il vessillo, come il Triumphator che non ha, non ha più ora, paura di perdere e può esibire il segno della sua vittoria. La mano sinistra con gesto fermo, lento, regale, trattiene le pieghe del manto che copre (e scopre) il torso bellissimo, ferito. Dalla ferita al costato colano ancora gocce di sangue, rosso di vita. Il piede destro è ancora dentro il sepolcro; il piede sinistro è poggiato saldamente sul bordo del sarcofago. Pesa grave sul bordo quel piede: c’è tutta la memoria della fatica di quel passo che l’ha portato fuori dal sepolcro, di qua dal buio. Il colore grigiastro della carne, la porpora sbiadita dello stesso manto risentono ancora, visibilmente, del pallore del niente, il non-colore del luogo da cui si è sottratto.
La compostezza grave, regale, della figura si concentra nell’espressione straordinaria del volto: sa, ricorda momento per momento, le tappe della passione. Ricorda soprattutto la disperazione urlata dalla croce: “Padre, perché mi abbandoni?”. Perciò ora torna vittorioso dall’orrido di Ade, ma senza nessuna gioia. Ritorna come Ananke – era necessario che tornasse; ritorna come Nike – doveva tornare vittorioso; ritorna come Nemesi – era giusto che tornasse. Ma sul volto porta tutti i segni del percorso. Trionfa sulla morte, trionfa qui nel mondo in cui ha voluto tornare come uomo. Trionfa sulla vita e sulla morte di qui. Contro gli uomini che l’hanno messo a morte; ma anche contro lo stesso Padre (“Perché mi hai abbandonato?”) che ha permesso che provasse fino in fondo l’esperimento troppo umano della vita e della sua fine. Sa tutto, per sapienza tragica. Vince – sull’intrigo, sull’incomprensione – vince anche sulla teologia: infrange e revoca con gesto regale il doloroso diktat di una teodicea adesso insensata. Vince politicamente, perché rompe il quadro di una cosmologia ossificata, e ritorna – redux più che triumphator. Il passo volitivo di quel piede, le mani, il volto, dicono la prepotenza di un sentimento che in chiunque altro sarebbe stato rabbia della morte o soddisfazione per la resurrezione: in lui è disperata dolcezza.
La resurrezione – resurrezione del corpo qui – non era scritta, non era assicurata da nessun annuncio consolatorio. È stata una necessità – Ananke, Nike, Nemesi – che si è manifestata in itinere: lui è risorto, decidendo di ricongiungere ciò che era stato separato. È suo quel corpo: è questo lo scandalo. Trionfa il corpo di Cristo: l’epifania, ciò che si vede ora, è quel corpo che ritorna qui nel mondo. Nello stesso istante, assoluto: il miracolo incantatorio sui corpi, sugli occhi dei soldati; il passo che porta Cristo fuori dal sarcofago; il ricordo nel suo volto che ricapitola tutta la passione; negli occhi la dolce prepotenza dell’epifania: – Io sono qui, ora. Nessuno lo aveva messo in conto: irruzione che sorprende e scardina il tempo coatto privo di aspettativa. Sulla spietata e troppo inumana processione temporale della Legge, il corpo di Cristo trionfa grazie a questa immagine.
Trittico. Quadro 3, la Rinascita

4 | Bill Viola, fotogramma da Emergence, 2002, installazione video.
Anche quando sceglie la declinazione narrativa, l’artista può rovesciare l’ordine del tempo. Prima, accanto al sarcofago, due donne soffrono e ci fanno soffrire l’assenza. Il dolore le piega. Non sanno scuotersi. Raccolte piegate dal pathos, le Marie. Non parlano, tra loro, non è tempo di parole, non c’è niente da dire o da fare. C’è solo da coprirsi la testa con il velo. E stare chiuse, piegate, introflesse. È un teatro di Pathosformeln del dolore – le mani al petto, la mano sul capo – in cui però il ‘caldo’ del pathos è come se fosse pittoricamente raggelato. Il tempo non scorre sempre uguale e quando una madre ha perso un figlio, quando una sorella ha perso un fratello, quando un’amante ha perso l’amato, scorre più lento. E, non potendo riavvolgersi all’indietro, sembra non passare mai.
Chiuse, mute, sopraffatte sono le due donne accanto al sepolcro-altare. Stanno male, noi stiamo male con loro. La più giovane tenta, forse, un dialogo di sguardi. Ma la più grande – la madre – non può: non ce la fa neppure a volgere lo sguardo verso l’altra. Non ce la fa. E noi con lei. Che peso, che pena. Si guardano, a un certo punto: la madre tenta un, impotente impossibile, sfogo al dolore. Un urlo muto: no, non può. Che peso: è un sasso, un’intera massa di roccia che pesa sul cuore. Ma ecco che la ragazza vede: è la più giovane che se ne accorge. L’altra è troppo raggelata troppo introflessa nel suo dolore. Dal sarcofago sbuca la testa, dalla tomba di marmo fuoriesce l’acqua.
L’artista lavora con il tempo: è il tempo che detta il moto delle azioni e delle emozioni, La madre vede l’acqua, prima. E lui esce – esce dall’acqua, esce dalla morte, bianco e bellissimo; le carni candide, algide: forse quel telo leggero lo scalda. Comunque lo copre. Ma non come un morto: è un bimbo, un bimbo grande che nasce. È vivo nonostante il bianco marmoreo delle carni.
E le Marie reagiscono: è vivo. Le carni del bel corpo nudo si scaldano un po’, si tingono di rosa: ci sono loro ad accoglierlo. È tenero e bellissimo. È la ragazza la prima che lo tocca e lo tocca, lo palpa per saggiare e per sapere che è, di nuovo, corpo: che è di nuovo un essere vivente. Ma è la madre che lo prende tra le braccia. Ecco è tornato nelle braccia di sua madre: è tenero, è livido, è integro: non ha i segni delle ferite. Lo depongono a terra, ma non è quell’altra deposizione, quando lo avevano tirato giù dalla croce. Non è morto, ora. Lo coprono con il telo, lo accarezzano, ma non è più per l’ultima volta – non è un addio. È tenero quel corpo, è stanco di morte. Gli baciano le mani e piangono, finalmente – perché è di nuovo qui. Il tempo scorre veloce ora che lui sta compiendo la sua epifania.
Riorientandone il senso e la direzione, l’artista reiventa il tempo nella sua pittura – “pittore”, ci ricorda Settis, si definisce Bill Viola. Sappiamo da Aristotele che quando cerchiamo di dire cosa sia il tempo, dobbiamo dire che è in qualche modo movimento, dato che insieme al movimento noi lo percepiamo [Fisica 219a 1-3: ληπτέον δέ, ἐπεὶ ζητοῦμεν τί ἐστιν ὁ χρόνος […], τί τῆς κινήσεώς ἐστιν. ἅμα γὰρ κινήσεως αἰσθανόμεθα καὶ χρόνου]. Ma l’artista governa la direzione del tempo e così, fa di una resurrezione una nascita. Così Salvatore Settis:
Potremmo anzi dire che la sequenza narrativa di Bill Viola nega la resurrezione, poiché la deposizione viene dopo che il corpo del giovane emerge dal pozzo (dal sepolcro?). Ma forse questo non è Cristo, né le donne sono la Maddalena e la Madonna. Forse non è una morte che stiamo guardando, forse è una nascita (Incursioni, alla pagina 253).
L’ordine del racconto è invertito, e capovolto risulta il senso stesso dell’icona della Pietà: il sarcofago partorisce alla vita un corpo, e la Madre prende tra le braccia e poi accudisce il vivente appena nato.
Il tempo presta la sua materia e la sua misura a una nuova narrazione allegorica. È un tempo che, pur legato al movimento – lento prima, poi accelerato e che comunque ha in sé un inizio e una fine – diventa il tempo giusto, l’unico in cui l’evento accade: kairos (una riflessione sulle definizioni del tempo che ruotano intorno al “tempo debito” è in Marramao 20202). E questa immagine del tempo – il tempo kairos – non deriva dalla mitografia e neppure evolve dall’allegoresi di concetti astratti che acquistano nomi propri di divinità, specifiche iconografie, a volte anche culti religiosi. Kairos, personificato e divinizzato, non è una invenzione dei sapienti né dei filosofi: è l’invenzione di un artista. Secondo quanto riferiscono Imerio e poi Giovanni Tzetzes, fu Lisippo a inventare l’immagine di Kairos come un giovane, con un ciuffo di capelli sulla fronte ma calvo sulla nuca, che passa rapido con i piedi alati in bilico su una sfera (Imerio, Declam. et Orat. XIII, 1; Tzetzes, Epist. 70, 99-100: sul tema rimando a Centanni 2020). E secondo le fonti l’artista inventò l’immagine di Kairos per un preciso motivo. Alessandro il Grande una volta si era lasciato sfuggire un’occasione da afferrare al volo ed era molto pentito di aver perso il momento opportuno. Fu allora che Lisippo, che era presente nella circostanza, inventò la figura di Kairos non isolata ma in un gruppo: dietro a lui era rappresentato “un altro uomo che andava a buon passo e tendeva la sua mano come per afferrarlo [...]. Ma quello andava avanti di gran corsa”. Lisippo inventa dunque Kairos con un’intenzione precisa “per ricordare ad Alessandro il suo errore, rimproverandolo senza parere di rimproverarlo, e come ammonimento per tutti […] per alludere alle ferite del cuore che colpiscono chi indugia e perde tempo” [κατακαρδίους πληγὰς αἰνιττόμενος, αἵπερ ἐγγίνονται τοῖς χρόνουκαθυστερίζουσιν] (Tzetzes, Epist. 70, 99-100; ma cfr. anche Chiliades VIII, 200, 421-427; X 323, 268-287).
Il Tempo fugge, rapido, ma sta all’uomo che gli corre appresso riuscire ad afferrarlo, anche a costo di doverlo prendere con la forza, per l’unico appiglio che offre alla presa – il lungo ciuffo di capelli sulla fronte. Alessandro imparerà bene quel che il suo artista aveva voluto insegnargli: nella sua splendida, fulminante, impresa avrà da sopportare molte altre “ferite nel cuore”, ma non dovrà mai più pentirsi di aver indugiato, non si pentirà mai più di aver perso del tempo. Solo l’artista poteva inventare questa dimensione del tempo che diventa figura della vita (che, per Alessandro, è anche figura della storia).
Il tempo-Chronos si salva nell’opera d’arte, il punto in cui l’immagine accoglie e riproduce il tempo mobile ma non univoco che ha il nome di Kairos. È la dimensione – istantanea, come in Piero e in Holbein; narrativa come in Bill Viola – che si salva dal tempo-Chronos, perché converge sull’aoristo, il tempo infinito e aperto all’orizzonte di pluriverse dimensioni aspettuali.
Il tempo, grande alchimista
Ha ragione Marguerite Yourcenar: il tempo, alleato alla natura, può conferire all’opera d’arte un’aggiunta di “bellezza involontaria” (Yourcenar [1952] 1985, 52). Ma non si può dire che quella che nasce sia un’“opera nuova”: semplicemente perché non è un’‘opera’. Certo i leoni di Delo, esposti per secoli alla luce davvero apollinea dell’isola, sono diventati meravigliosi “fossili imbiancati, ossa al sole in riva al mare” (Yourcenar [1952] 1985, 52); e le statue mutilate dai martelli degli iconoclasti si sono caricate di un pathos che prima non avevano, e ora gli “dei mutilati hanno l’aria di martiri” (Yourcenar [1952] 1985, 53). È pur vero, che ridotta così come la vediamo “acefala, senza braccia, […] consunta da tutte le raffiche delle Sporadi, la Vittoria di Samotracia è divenuta meno donna e più vento di mare e dell’aria” (Yourcenar [1952] 1985, 53). Ed è pur vero che “ogni […] ferita ci aiuta a ricostruire un crimine e a volte a risalire alle sue cause”, e che ogni restauro è un’operazione discrezionale e arbitraria che corrisponde a una particolare, storicizzata, declinazione del sentimento di pietà:
I nostri antenati non potevano rassegnarsi a questi capolavori mutilati, a segni di violenza e di morte su questi dèi di pietra […]: restauravano per pietà. E per pietà, noi provvediamo a disfare la loro opera (Yourcenar [1952] 1985, 54).
Ma non basta. Perché non è vero che, come scrive Yourcenar, l’intervento dell’artista rappresenta solo un fase nella vita delle statue, un breve episodio nella loro esistenza che si distende nei millenni, dalla loro origine materica alla mutazione e rovina:
La forma e il gesto imposti dallo scultore non sono stati per queste statue che un breve episodio tra la loro incalcolabile durata di roccia nel grembo della montagna, e poi la lunga esistenza di pietra deposta sul fondo delle acque. […] Come quel cadavere di cui parla la più bella e misteriosa delle canzoni di Shakespeare, esse hanno subito un mutamento oceanico dovizioso non meno che strano (Yourcenar [1952] 1985, 55).
Ma non basta che la materia di una statua sul fondo del mare acquisisca l’ornamento, la bellezza aggiunta, di meravigliose incrostazioni di sale e di conchiglie. Dopo l’opera dell’artista, serve l’archeologo che riscopre quella statua e che la riporta a vivere tra noi. Non basta che un corpo giaccia in fondo al mare per fare delle sue ossa coralli, dei suoi occhi perle. Serve Shakespeare che scriva:
Full fathom five thy father lies
Of his bones are coral made
Those are pearls that were his eyes
Nothing of him that doth fade
But doth suffer a sea-change
Into something rich and strange.
(William Shakespeare, The Tempest, Act 1, Scene 2).
Senza le parole del poeta, quel corpo sul fondo del mare torna alla natura senza rinascere a vita poetica. E non è cosa né ricca né strana.
Il tempo non è scultore, né pittore, né architetto. Il tempo non inventa opere. Ci vuole la mano dell’artista che, insieme ad altri materiali utili per la sua tecnica, sfrutta anche il movimento del tempo. Ci vuole Penone che lavorando con i materiali e le forme della natura, sa però che solo se “il momento artificiale – il fatto ad arte – si coniuga con l’evento naturale” e che i materiali possono trasformarsi “in entità creative” (Incursioni, alla pagina 205). Ci vuole Kentridge che gioca contro (gioca con) la patina che il tempo ha posato e poserà sulle cose, con lo sporco depositato sulle pareti delle rive del Tevere, per far emergere in negativo, per ablazione, figure del trionfo e del lamento, superlativi del pathos che rimettono una sequenza la storia di Roma, in modo superbamente effimero e anacronistico. Ci vuole Bill Viola che reinventa il ritmo del tempo, come in Ocean Without a Shore, facendoci sostare là, alle porte dell’Ade, sulla soglia dove il tempo cede il passo al niente: ma purtuttavia c’è un attimo breve – una parete d’acqua – che permette il dialogo con chi sta nella dimensione fredda dell’altro mondo.
No, il tempo non è un grande scultore. Se mai è un alchimista che, complice la natura, sa modificare anche la struttura molecolare, chimica e biologica della materia: degli elementi e degli esseri viventi, delle pietre e dei corpi. Il tempo è un alchimista poco partecipe ed essenzialmente distratto, perché indifferente al valore e alla qualità dei materiali che usa, o che scalfisce, che compone o che consuma. Il tempo è un alchimista che crea e disfa a caso, perché non crede al primato dell’oro.
Senza l’artista, senza il poeta, al Tempo stesso mancherebbero immagini, nomi divini, e a noi mancherebbero i modi di dirlo e di rappresentarlo. Un grande artista, Lisippo, ha inventato il nome divino e l’immagine stessa di Kairos. È l’artista che inventa il tempo. E noi forse, senza l’opera d’arte, del tempo non sapremmo nulla.
Nota
Sono già intervenuta a dialogo con le considerazioni di Salvatore Settis sulla Tempesta in Centanni 2017, 177; sempre in Fantasmi dell’antico ho proposto le mie riflessioni sul Cristo morto di Basilea di Holbein e sulla Resurrezione di Piero (in una diversa versione e con note e bibliografia: Centanni 2017, 181-183 e 179-181). Una lettura di Emergence, all’interno dell’opera di Bill Viola in mostra nel 2017 a Palazzo Vecchio a Firenze, è stata pubblicata in Engramma: Centanni et all. 2017.
Riferimenti bibliografici
- Alfieri 2011
A. Alfieri, Tempo dell'attesa, noia e affezione nell'arte di Bill Viola, “La Rivista di Engramma” 89 (aprile 2011), 14-20. - Cacciari 1997
M. Cacciari, L’Arcipelago, Milano 1997. - Cacciari 2007
M. Cacciari, Tre icone, Milano 2007. - Centanni 2017
M. Centanni, Fantasmi dell’antico. La tradizione classica nel Rinascimento, Rimini 2017. - Centanni 2020
M. Centanni, Occasione presa/occasione persa. Kairos e il teatro della fortuna nel bassorilievo di Torcello, in Venezia prima di Venezia. Torcello e dintorni, Lezioni Marciane 2017-2018, a cura di M. Bassani, M. Molin, F. Veronese, Roma 2020, 39-65. - Centanni et all. 2017
M. Centanni, A. Fressola, A. Ghiraldini, A. Pedersoli, "Neither from nor towards; at the still point, there the dance is". Recensione alla mostra di Bill Viola "Rinascimento elettronico" (dal 10 marzo al 23 luglio 2017, Palazzo Strozzi, Firenze 2017), “La Rivista di Engramma” 146 (giugno 2017), 123-138. - Fabbri 2009
P. Fabbri, Ocean Without a Shore, “L’archivio del senso”, Quaderni della Biennale, 1 (2009), 27-47. - Fabbri 2011
P. Fabbri, Bussare alla Porta degli Angeli, in Bill Viola, 10 opere video single channel 1976-1994, catalogo della mostra a cura di F. Mancini, Ravenna 2011. - Marramao 20202
G. Marramao, Kairós. Apologia del tempo debito, nuova ed. ampliata (I ed. Torino 1992), Torino 2020. - Pucci 2017
G. Pucci, Chi è il barbaro? I disastri delle guerra sulla Colonna Traiana, in A. Camerotto, M. Fucecchi, G. Ieranò, a cura di, Uomini contro. Tra l’Iliade e la Grande Guerra, Milano 2017, 51-66. - Settis 1978
S. Settis, La Tempesta interpretata, Torino 1978. - Yourcenar [1952] 1985
M. Yourcenar, Il tempo, grande scultore, in Il tempo, grande scultore [ed. or.: Le temps, ce grand sculpteur, 1952, Paris 1953], trad. it. G. Guglielmi, Torino 1985, 49-55. - Yourcenar [1951] 19812
M. Yourcenar, Memorie di Adriano [ed. or.: Mémoires d’Hadrien, Paris 1951], trad. it. L. Storoni Mazzolani, Torino 19812.
Per citare questo articolo / To cite this article: M. Centanni, Il tempo (non è un) grande scultore. Con un Trittico, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 230-251 | PDF
Nell’Introduzione al suo saggio Incursioni. Arte contemporanea e tradizione, Salvatore Settis cita un aforisma attribuito a Gustav Mahler: “Tradizione non è adorare la cenere, ma custodire il fuoco” (Incursioni, alla pagina 14).
Il contesto parla della “tradizione” nel senso più ampio della parola per restringersi alla “tradizione artistica” e approdare al rivoluzionario progetto di Aby Warburg (1866-1929), l’Atlante della “tradizione visuale europea”, l’incompiuto, fondamentale, Mnemosyne che ha trasformato il concetto stesso di tradizione artistica attraverso l’“occhio assoluto” di un outsider, la cui genialità è stata troppo facilmente confusa con una forma patologica laddove era il fuoco della passione e la consapevolezza di una scoperta epocale a travolgere l’animo e la mente di Warburg – nel suo sforzo non condiviso, nel suo pressoché totale isolamento.
L’inatteso riferimento a Mahler ha prodotto in me una specie di corto circuito che mi ha riportato a un’altra rivoluzione, più o meno coeva, che inizia sotto il segno dell’arte pittorica e del suono ma poi si evolve in una lotta non meno ardua, non meno condivisa, in campo esclusivamente musicale. Di questa rivoluzione, Mahler (1860-1911) è il solitario precursore. Nella tradizione artistica lo scarto colpisce (o lascia nell’incomprensione e nell’indifferenza) l’occhio dello spectator, per dirla con Roland Barthes (Barthes 1980, 33). Ma il suono viene a ferire direttamente l’orecchio, l’organo più sensibile e più suscettibile, per cui la reazione è immediata, non c’è posto per una riflessione meditata: è la ripulsa, è l’odio.
Rispetto alla tradizione, Mahler non è radicalmente innovatore, tuttavia il suo rapporto con essa è teso, critico, sempre al limite della lacerazione. Nelle sue composizioni penetrano elementi eterogenei, citazioni, parodie, ironia e sarcasmo, si mescolano canti popolari, marce militari, echi di operetta, ballabili: il tutto viene però inserito in una costruzione formalmente ineccepibile. Nonostante questo, ha attirato su di sé le critiche, l’accusa di fare musica kitsch, l’odio dei tradizionalisti (la musica non conosce misura). Ha scritto Adorno:
L’insistenza di chi pretende che nella musica non ci sia nulla di più di quanto vi esiste di fatto, cela la irrigidita rassegnazione e il compromesso di un ascoltatore che si dispensa dal lavoro e dalla fatica di intendere il concetto musicale come un ente in divenire e come un momento di superamento di se stesso (Adorno [1952] 1966, 141).
La tonalità, “la grande teoria della mediazione musicale”, Mahler la infiamma dall’interno, ponendo le basi di quella che sarà l’emancipazione della dissonanza. La tradizione scorre come un fiume carsico portando con sé i messaggi nascosti che verranno raccolti dalla grande triade che presiede alla nascita vera e propria della Nuova Musica e che porta i nomi di: Arnold Schönberg (1874-1951), Anton Webern (1883-1945), Alban Berg (1885-1935).
L’anno magico della svolta è il 1911. Singolare è il fatto che a covare sotto le ceneri non fosse solo il problema della tonalità per opera di Schönberg, ma anche l’arte pittorica per opera di Kandinsky. Siamo al tempo del “Blaue Reiter”, primo e unico numero di una rivista che uscirà nel 1912, in cui Schönberg appare, unico musicista, con un saggio importante (Il rapporto con il testo). La coincidenza di idee è pressoché simultanea e trova espressione indipendente nelle elaborazioni teoriche e nelle sperimentazioni pratiche di Kandinsky e Schönberg: il Manuale di armonia (Schönberg 1911) e Lo spirituale nell’arte (Kandinsky 1912), seguiti dai drammi sperimentali: La mano felice (Schönberg) e Il suono giallo (Kandinsky).
I percorsi evolutivi appaiono legati: dissoluzione dell’oggetto, dissoluzione della tonalità, emancipazione della forma e dei colori, emancipazione della dissonanza. Ma la visione di Kandinsky non è quella di Schönberg. Kandinsky vuole il diverso, Schönberg cerca il legame segreto, la continuità nella diversità, nella ripetizione come re-interpretazione o negazione. In questo è simile a Warburg. Perciò, nonostante l’amicizia e il lungo carteggio con Kandinsky, se ne distacca e segue con fermezza la sua strada. Nel suo magistero egli non rinnega il rigore tradizionalista. “Uno dei compiti più nobili della teoria – scrive Schönberg – è di sorvegliare l’amore per il passato e di aprire, nello stesso tempo, lo sguardo verso il futuro: in tal modo essa può essere storica” (Schönberg 1963). In una lettera a Webern dice:
L’unica cosa che vorrei raccomandarti è di disporre le analisi [...] in modo che possa risultarne lo sviluppo verso la composizione dodecafonica. Quindi, p. es., i Fiamminghi, Bach per il contrappunto, Mozart per la struttura delle frasi e anche dei temi, Beethoven ma anche Bach per la transizione, Brahms ed eventualmente Mahler per le molteplici variazioni e implicazioni degli esiti finali (Schönberg 1931).
E Glenn Gould commenta:
Per lui era semplicemente impossibile tagliare i ponti con il passato: aveva bisogno di mantenere vivi dei legami per poter andare avanti nella sua esplorazione del territorio sconosciuto della dodecafonia (Gould 1974).
Webern e Berg sono forse coloro che meglio comprendono e fanno fruttare i piccoli fuochi accesi da Mahler per immergerli nel crogiuolo incandescente creato dal loro Maestro. Ma la morte precoce di entrambi interrompe una strada in ascesa, mentre Schönberg procede isolato, in un universo che si restringe soprattutto dopo la sua tardiva adesione all’ebraismo (come sfida al nazismo nascente) e al conseguente espatrio ed esilio in America. La teoria dodecafonica è ancora sub judice, mentre la Jacobsleiter e il Moses und Aron – le sue opere ‘ebraiche’ – rimangono incompiute, segno di una frattura interiore e di un’oscillazione mentale che mi ricordano la malattia di Warburg.
Gli allievi di Schönberg – Webern e Berg – vivono il passaggio all’atonalità secondo l’input del Maestro e forse, come ho già detto, con maggiore coscienza del ‘passaggio’. Non per nulla erano entrambi grandi ammiratori di Mahler. Il capolavoro incompiuto di Alban Berg, l’opera Lulu, oscilla tra tradizione e svolta atonale, rispettando i canoni della dodecafonia ma senza chiudere totalmente con la forma tràdita, in una evidente irrisolta tensione tra passato e futuro. Diversamente Webern sviluppa maggiormente la tecnica dodecafonica, teso al recupero del suono puro e delle pause che isolano ed evidenziano il suono stesso.
Con l’esilio di Schönberg in America e la morte precoce di Webern e Berg, il grande trio viene smantellato. Gli eredi della Scuola Viennese si ritrovano a Darmstadt dove si consuma una diaspora ideologica che divide personaggi come Pousseur, Stockhausen e Boulez da quella che potremmo chiamare la ‘Scuola veneziana’ che, pur nella osservanza delle leggi della dodecafonia, si distingue per una concezione meno vincolata, più libera: ciò è dovuto all’influsso di un personaggio enigmatico, scettico e ironico quale fu Gian Francesco Malipiero, il cui rigore tradizionalista era tuttavia aperto al nuovo – come testimoniano i suoi allievi, Luigi Nono e Bruno Maderna, che da Malipiero stesso furono indirizzati alla scuola di Darmstadt e al magistero di Hermann Scherchen. A Darmstadt essi portarono l’aura della ‘bottega veneziana’ e il culto del suono, valorizzato dal silenzio.
Silenzio e suono nelle opere di Luigi Nono, più vicino al magistero di Schönberg. Centralità assoluta del suono in Bruno Maderna che, diversamente da Nono, cerca un aggancio non con le norme tràdite, ma con un lontano passato che non esiste se non nell’immaginazione. In un’epoca che fece uso indiscriminato di mezzi tecnici, Maderna andò alla ricerca della melodia assoluta e affidò il canto monodico allo strumento più simile per timbro all’antico aulo: l’oboe. Ha scritto Mario Baroni: “Il mito archetipico della melodia dell’aulos [...] accompagna la vita di Maderna [...] nei venticinque anni in cui egli compone le sue musiche più mature” (Baroni 1989, 227-ss.).
Un archetipo, dunque: l’aulos dei greci, la musica dionisiaca versus la cetra apollinea, il teatro di scontro della musica antica. In Maderna vince l’aulos: Aulodia (1963), la Grande Aulodia (1970) e l’ultima composizione nell’anno della morte, Terzo concerto per oboe e orchestra (1973).
Ma qual è il termine di confronto se la musica antica è andata perduta? Dove possiamo rintracciare nella ‘Nuova Musica’ di Maderna la componente archetipica della musica antica? Non certo nel frammento del celebre ma troppo esiguo Epitafio di Sicilo, che pure Maderna riecheggiò in una delle sue composizioni giovanili (forse 1952). Siamo quindi difronte a una musica che compie un salto mortale al di là di ogni lezione tràdita per ricostruire un “originale assente” (Centanni 2005), per ricreare una melodia che riprende il suono antico senza conoscerlo. È un eccezionale balzo all’indietro e anche un salto nel vuoto: ma è comunque il suono che evoca un suono, quello di una musica scomparsa, l’archetipo perduto.
Forse ho divagato troppo. Ma il saggio di Settis e la prospettiva warburghiana da lui adottata e messa in opera, mi hanno trascinato verso un campo diverso e tuttavia contrassegnato dal medesimo contrasto fra tradizione e innovazione, da uguali problemi di coesistenza, di ripresa, di modificazione – un tema che, anche in musica, mi ha sempre attratto e affascinato. Trovo inoltre una sottile affinità tra le figure di Warburg e Schönberg nella solitaria battaglia per il rinnovamento del guardare e dell’ascoltare e nel tardivo riconoscimento delle loro geniali intuizioni.
L’‘orecchio assoluto’ sembra un’espressione adottata solo per i musicisti ed è privilegio di molti. Ma a Warburg – e solo a lui – vorrei applicare la definizione di ‘occhio assoluto’, come di colui che vede ‘al di là’ e insieme ‘intorno’, che raccoglie – come Mahler – le testimonianze più varie e ne fa una piattaforma estesa e multiforme dove passato e presente confluiscono per alimentare la creatività.
‘Occhio assoluto’ è anche quello con cui Settis si introduce nelle forme di arte contemporanea, in singoli capolavori pittorici – Doppio ritratto di Duchamp; Morte di Neruda di Guttuso; la Catherine Room di Bill Viola, nel cinema di Ingmar Bergman – il poco conosciuto film Rito – nella camera oscura di Mimmo Jodice, nella scultura di Giuseppe Penone, per citare solo alcuni dei suoi splendidi saggi.
Settis definisce questi suoi scritti “incursioni” e afferma di sentirsi “straniero in ogni luogo” (Incursioni, alla pagina 37). Straniero. Dunque xenos. Ma nella tradizione antica, che si è propagata nel tempo, xenos è colui che giunge inatteso, lo sconosciuto che sconvolge le regole stabilite, che trasfigura i riti, svela i segreti nascosti, le intenzioni consapevoli e i risultati inconsapevoli, è il “ladro di anime”, di gesti, di figure. È colui che alla fine si rivela Signore e Maestro.
Riferimenti bibliografici
- Adorno [1952] 1966
Th.W. Adorno, Wagner. Mahler. Due studi [ed. or. 1952], trad. it. Torino 1966. - Baroni 1989
M. Baroni, L’archetipo dell’aulos. Echi e reminiscenze melodiche, in Studi su Bruno Maderna, Milano 1989. - Barthes 1980
R. Barthes, La camera chiara [ed. or. 1980], trad. it. Torino 1980. - Centanni 2005
M. Centanni (a cura di), L’originale assente, Milano 2005. - Gould 1974
G. Gould, L’ala del turbine intelligente, Torino 1974. - Schönberg [1911] 1963
A. Schönberg, Manuale di armonia [ed. or. 1911], trad. it. Milano 1963.
Per citare questo articolo / To cite this article: M. G. Ciani, Cenere e fuoco, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 252-257 | PDF
Le forme viventi: l’impronta e il soffio. Giuseppe Penone e Andrea Mantegna: un dialogo anacronistico
Claudia Cieri Via
1 | Macchiatonda, Capalbio, 10 Marzo 2021.
Osservare tronchi d’alberi su una spiaggia d’inverno permette di cogliere l’azione della natura: il lavorio del vento, dell’acqua del sale sulla superficie di un tronco una volta parte di un albero, parte di un bosco o di una foresta [Fig.1].
Un albero che ha perso la sua funzione nel processo di fotosintesi clorofilliana nel luogo d’origine diventa testimonianza dell’effetto degli elementi naturali che hanno contribuito alla sua trasformazione, permettendo di misurarne la temporalità e dunque di ricostruire la sua storia:
Nel recuperare una forma che è naturale, c’è uno stupore una sorpresa che è data dalla materia stessa […] questo lavoro dell’albero ritrovato all’interno del legno.
Così afferma Giuseppe Penone in occasione della conversazione con Carlos Basualdo (Basualdo 2018). Ma già da queste parole si evince l’opera dell’artista che lavora sugli elementi della natura, tronchi o rami di alberi, foglie, pietre, scavando nella materia, ascoltandola. In un disegno del 1968 in cui la mano dell’artista ‘ausculta’ il tronco dell’albero egli enuncia il suo progetto per Alpi marittime, accompagnando i suoi disegni con annotazioni poetiche tracciate sui fogli [Fig. 2].
Sento il respiro della foresta, odo la crescita lenta ed inesorabile del legno, modello il mio respiro sul respiro del vegetale. Avvero lo scorrere dell’albero attorno alla mia mano appoggiata al suo tronco.
Ancora nel progetto dello stesso anno Per aderire agli alberi [Fig. 3] l’artista riflette sull’albero:
[…] come elemento vitale in espansione e in accrescimento continuo […] alla sua forza aderisce la mia forza, i suoi rami ed i suoi cerchi si adattano agli anelli delle mani e delle braccia e ricordo i contatti e le prese delle gambe che affondano in lui. La sua reazione è il suo lavoro .
Giuseppe Penone sperimenta dunque l’azione del tempo annotando “[…] per ritrovare all’interno dell’albero l’azione da me compiuta” [Fig. 4]. Una “archeologia del sè”, dunque, una splendida espressione di Salvatore Settis che coglie icasticamente il lavoro come pensiero di Giuseppe Penone (Incursioni, alla pagina 194)
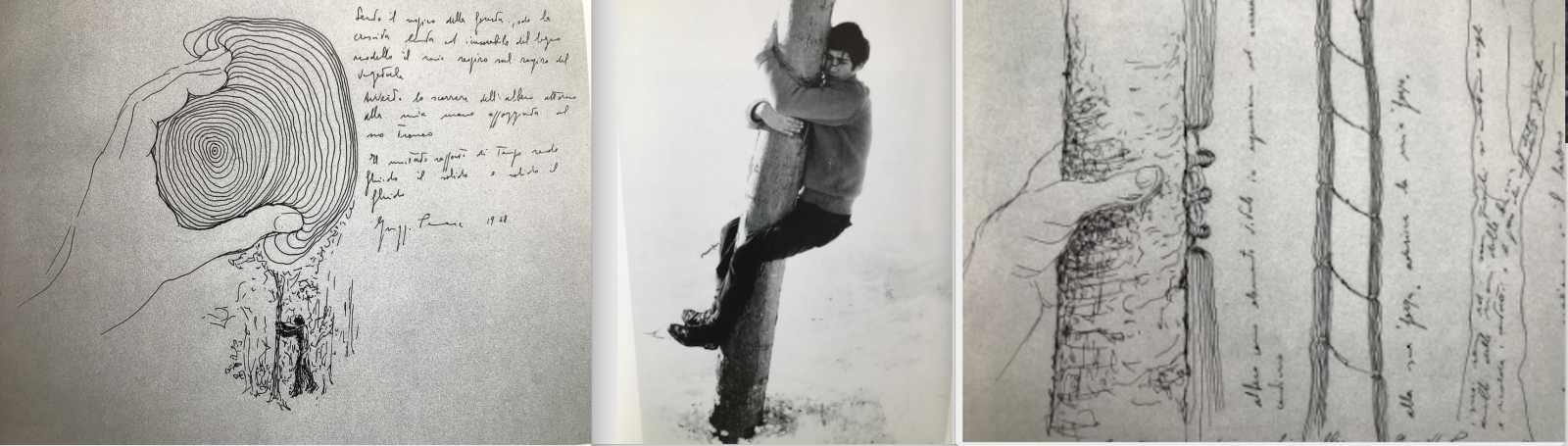
2 | Giuseppe Penone, progetto per Alpi Marittime, disegno, 1968.
3 | Giuseppe Penone, L’albero ricorderà il contatto, azione dell’artista, 1968.
4 | Giuseppe Penone, Per aderire agli alberi, disegno, 1968.
Nei suoi disegni la vitalità delle forme naturali e del suo pensiero dialogano in una rispondenza fra scrittura e sperimentazione agente, della mano che disegna, della mano che ascolta la natura. “L’arte – afferma Penone in dialogo con Germano Celant – non è la descrizione di forme ma del pensiero” (Celant 1989; Brugerolles 2017).
Anche Andrea Mantegna osservava la natura padano-veneta, nei luoghi del suo lavoro d’artista, attraverso il processo geologico di quelle rocce calcaree che il tempo aveva conformato e sbriciolato, assimilandolo al lavoro degli scavi archeologici del suo tempo [Fig. 5]. Nella Madonna delle cave agli Uffizi [Fig. 6] l’artista accosta le forme della natura alle forme dei ruderi, il processo geologico allo scavo archeologico, cogliendo in entrambi i casi l’azione del tempo fra trasformazione e distruzione. Andrea Mantegna si rivela, fin dal suo apprendistato presso la bottega di Francesco Squarcione, un artista che osserva la natura, in un progressivo coinvolgimento empatico ed artistico, attraverso un’analisi lenticolare della materia rocciosa secondo un processo che evoca una sorta di dendrologia alla quale fa riferimento Michael Baxandall nel suo libro sugli scultori in legno del Rinascimento tedesco attraverso una analisi del materiale stesso, il legno di tiglio: “[...] il migliore fra tutti i legni che si adoperano nella scultura […] perché egli ha i pori uguali per ogni lato e ubbidisce più agevolmente alla lima e allo scalpello” (Baxandall [1980] 1989).
Fu per primo Paul Kristeller nella sua monografia sull’artista padovano del 1902 a introdurre notazioni scientifiche sui materiali delle rocce naturali della Madonna delle cave dove: “pezzi di minerali cristallizzati posti sulla roccia originale sono il frutto di una formazione vulcanica di basalto, formazioni che si trovano in pochi luoghi d’Italia; uno di questi è il monte Bolca vicino a Ronca, fra Vicenza e Verona” (Kristeller 1902, 238-240). Le immagini del territorio di Ronca con il monte Bolca verificano il fascino di questa natura sull’artista nelle sue opere giovanili. Un interesse per la natura nei dipinti di Mantegna si lega a quello più strettamente geologico informato a un’indagine stratigrafica dei materiali nel sito. Infatti le rocce, frastagliate e aguzze, a blocchetti o a scaglie sono molto simili alle rocce del territorio di Ronca, carbonatiche, sedimentarie, formatesi in ambiente marino composte di strati calcarei, determinando quel tratto scabroso degli aridi paesaggi pietrosi già nei nei dipinti degli anni ’60 del Quattrocento come il San Sebastiano di Vienna o l’Orazione nell’orto della National Gallery di Londra, fortemente caratterizzati dagli effetti di fenomeni geologici, trovando in particolare riferimento nelle descrizioni di Alberto Magno il quale sulla scorta di Aristotele e di Avicenna scriveva nel De mineralibus stampato a Padova nel 1475:
Qualche volta i monti sono prodotti accidentalmente quando un corso d’acqua o il vento frattura il suolo; così dallo scavamento si erge un’eminenza elevata; è questa la principale formazione della montagna […]. Vi sono in effetti delle terre molli e delle terre dure; i venti e i corsi d’acqua sollevano le terre molli tanto che le terre dure sopravvivono e formano eminenze (Alberto Magno, De mineralibus, edizione Padova 1475).
Più che di rovinismo si può parlare dunque per Mantegna di indagini stratigrafiche volte a recuperare l’essenza dei materiali, la loro natura e la loro storia per renderli artisticamente attraverso il tratto della sua pittura. Un preciso riferimento agli scavi archeologici si individua nella Madonna delle cave [Fig. 6].

5 | Andrea Mantegna, L’Orazione nell’orto degli Ulivi, ca. 1459, Londra, National Gallery.
6 | Andrea Mantegna, Madonna delle cave, 1488-90, Firenze, Uffizi.
Qui, attraverso l’osservazione naturalistica, l’analisi geologica e l’indagine archeologica sono vissute scientificamente e emotivamente. Mantegna sembra infatti lavorare sui materiali al fine di renderli ‘effetti’ dell’attività umana e del tempo; così i muri crepati e fratturati appaiono come conglomerati di processi geologici, mentre i frammenti di sculture o di monumenti, come nei dipinti del San Sebastiano a Vienna e a Parigi, sono testimonianze o sopravvivenze nel tempo dei processi storici e artistici [Fig. 7]. Non si tratta dunque solo di ‘citazioni’ di modelli antichi ma di ‘osservazione’ da parte dell’artista che ne coglie la fattura materica originale anche nei frammenti, e dunque la loro storia.
Nel progetto per il giardino di pietra del 1968, Penone sembra voler far dialogare gli alberi con i materiali di pietra, in particolare con lastre e colonne doriche, in una forma di innesto degli uni con gli altri: “L’albero teso al suo ritmo di crescita per poter […] ridurre i tempi di espansione e di stabilità assorbe gli ostacoli che oggi vengono posti dall’attività dell’ambiente” [Fig. 8].
È interessante evocare, in un rapporto rovesciato, questa problematica contesa fra natura e ambiente, fra natura e cultura, in una riflessione di Leon Battista Alberti tratta dal X libro del De re aedificatoria in cui si legge:
Il fico selvatico è per i muri come un ariete silenzioso. Io stesso ho veduto – incredibile a dirsi – pietre colossali rimosse e scompaginate dal cuneo possente di una piccola radice annidatasi fra le fenditure, ora se questa fosse stata estirpata fin da principio quando era ancora tenera l’opera sarebbe rimasta intatta (L.B. Alberti, De re aedificatoria, ed. Orlandi, Portoghesi 1966, 988).
La presenza di un fico selvatico che emerge dai frammenti antichi del San Sebastiano del Louvre, al di là di un eventuale significato simbolico cristologico, sembra riproporre nella ricerca artistica di Mantegna quella connessione fra l’indagine geologica e l’indagine archeologica nell’ambito delle quali il tempo ha un ruolo determinante anche come giudizio etico rivolto in questo caso all’incuria degli uomini cui fa riferimento Leon Battista Alberti nel passaggio citato del De re aedificatoria (Esch 2008) [Fig. 9].

7 | Andrea Mantegna, San Sebastiano, 1459, Wien, Kunsthistorisches Museum.
8 | Giuseppe Penone, progetto per Il giardino di pietra, 1968.
9 | Andrea Mantegna, San Sebastiano, 1490, Paris, Louvre.
L’interesse dunque di Mantegna sembra essere di ordine processuale oltre che figurale. La ricerca sui materiali naturali è strettamente legata all’osservazione del paesaggio reale indagato ed osservato in maniera lenticolare per restituire l’ambiente storico, luogo di antichità, all’ambiente reale in cui natura e cultura si fondono nell’identità dell’artista. La trasposizione artistica di questa analisi geologica del territorio da parte di Andrea Mantegna avviene attraverso l’interesse archeologico da un punto di vista stratigrafico e da un punto di vista artistico-testimoniale. L’indagine scientifica infine trova espressione nel tratto dell’artista che si fonde nella resa del soggetto.
Un ulteriore appunto di Penone nel Progetto per un giardino di pietra, chiama in causa le pietre nella loro contesa con gli altri elementi: “[…] l’albero come il fango ha imparato ad inghiottire le pietre e le ingloba e le fa divenire sua struttura”. Una riflessione che a partire dal 1981 Penone svilupperà nella serie di opere Essere Fiume, in cui il processo di levigazione e trasformazione delle pietre sotto l’azione dell’acqua diventa una prova per ottenere lo stesso effetto su una pietra da lui stesso lavorata; dal confronto fra le due pietre l’assimilazione della traccia dell’artista alla natura è perfetta: “Produrre una pietra di pietra è scultura perfetta” – scrive l’artista, esaltando il ruolo processuale della creazione artistica. E, ancora, “È l’essere fiume la vera scultura di pietra”.
La scultura è un lavoro di memoria e l’opera di Penone è essenzialmente un’opera di scultura, come attivazione di forme e proiezione del tempo nella materia. Scrive Catherine Grenier:
Être Fleuve est a ce titre emblématique de toute l’oeuvre. Par le geste le plus élémentaire du sculpteur, l’artiste crée de sa main un bloc d’éternité. Ce bloc renferme la mémoire d’une conjonction de temps (Grenier 2004, 122).
Occorre “[…] farsi albero, farsi fiume, farsi pietra […]” – scrive Penone – per attivare il processo della creazione artistica attraverso la memoria. E ancora nel 1968 in rapporto al suo processo-performance di “farsi scultura” [Fig. 10] appunta:
Per realizzare la scultura è necessario che lo scultore si adagi, si sdrai per terra lasciandosi scivolare, senza scendere in fretta, dolcemente, a poco a poco e finalmente raggiunta l’orizzontalità, concentri l’attenzione e gli sforzi al suo corpo che premuto contro il terreno gli permette di vedere, di sentire contro di sé le cose della terra e raggiungere il grado di quiete necessaria al compimento della scultura. Lo scultore penetra e la linea dell’orizzonte si avvicina ai suoi occhi. Quando si sente con la testa finalmente leggera, il freddo della terra lo taglia a metà e gli rende leggibile con chiarezza e precisione il punto che stacca la parte del suo corpo che appartiene al vuoto del cielo e la parte che è del pieno della terra. È allora che avviene la scultura.

10 | Giuseppe Penone, Soffio di Foglie, 1979, foglie di bosso, performance.
11 | Giuseppe Penone, Soffio di foglie, 1979.
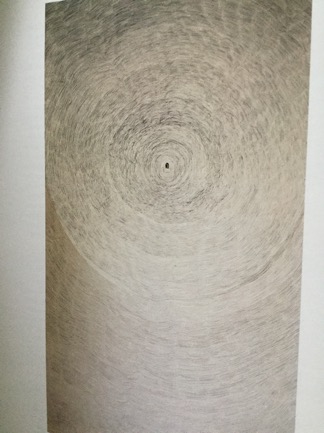
12| Giuseppe Penone, L’impronta del disegno, 2002.
13 | Giuseppe Penone, Sulla pelle delle dita il disegno del suono.
Il lavoro del suo corpo sulla materia proprio della scultura porta Penone a concentrarsi sull’impronta in quanto memoria che il corpo deposita sul mondo. Scrive Georges Didi-Huberman:
Il gesto di impronta non ha in sé un valore orientato e utilitario della produzione di un oggetto: è innanzitutto l’esperienza di una relazione, il rapporto di emergenza di una forma da un substrato ‘improntato’… La forma, nel processo dell’impronta, non è mai rigorosamente prevedibile è sempre problematica, inattesa, instabile aperta (Didi-Huberman [2008] 2009, 31).
L’impronta è anche “l’alba delle immagini” – scrive Leroi-Gourhan – da affrontare “ […] attraverso la ricerca del fantastico nella natura, il sentimento estetico che spinge verso il mistero delle forme bizzarre, conchiglie pietre denti o zanne, impronte di fossili” (Leroi-Gourhan [1965] 1977, 212-216).
Giuseppe Penone è stato impressionato dai numerosi resti presenti nel territorio delle Alpi liguri, come ricorda Germano Celant, vestigia del paleolitico e del neolitico che conservano tracce dell’origine dell’umanità, di cui l’artista ha raccolto delle testimonianze di pietre scolpite per osservare e riproporre il processo del tempo. Il segno della natura nella stratificazione delle rocce è uno dei fenomeni che permette di leggere la temporalità nel processo geologico, evincendo in alcuni casi sorprendenti immagini di creazione artistica. Il ritrovamento nel territorio di Ronca, attraverso un’indagine stratigrafica, di bellissimi e preziosi pesci fossilizzati, ha permesso di ricostruire la memoria di questo territorio secondo un procedimento simile a quello adottato dalla scienza archeologica. Ai fossili di Verona già si riferiva Pietro d’Abano:
In alcune pietre si trovano figure meravigliose: esse sono delle testimonianze dei corpi celesti e non delle figure di corpi di qui in basso. È ciò che si vede nelle pietre che si trovano a Verona; in queste pietre delle stelle sono raffigurate attraverso cinque raggi… vicino a Verona si raccolgono degli eleganti fossili dove si vedono stelle a cinque braccia marcate di un’influenza celeste (Pietro D’Abano, Geomantia, nuovamente tradotta di latino in volgare per il Tricasso mantoano, Venezia 1542).
Ad analoghe immagini (Cieri Via 2010, 261 fig. 20; Pratesi 2003, 46, n. 38) Leon Battista Alberti dedica un passaggio del II libro de De re aedificatoria, prendendo le distanze da ogni fenomeno magico per confermare la sua posizione scientifica:
Fatto più sorprendente ancora nella campagna veronese ogni giorno si raccolgono pietre sparse all’aperto qua e la che portano il disegno del cinque foglie inciso con linee esatte in modo perfetto e armonioso dalla natura, con arte tanto sicura e ammirevole che nessun uomo sarebbe in grado di imitarne l’accuratezza. E ciò che più meraviglia è il vedere come ogni sasso sia voltato in giù in modo da nascondere il disegno che porta impresso; dal che si può facilmente dedurre che la natura ha creato questi capolavori non per rendere gli uomini stupefatti, ma solo per se stessa (L.B. Alberti, De re aedificatoria, ed. Orlandi, Portoghesi 1966, 158).
Attraverso le parole di Leon Battista Alberti si può cogliere l’operazione proposta da Giuseppe Penone di Rovesciare i propri occhi secondo la quale l’artista coprendosi gli occhi con due lenti a contatto specchiate dimostra che siamo in grado di vedere attraverso l’ingannevole apparenza delle cose, dentro la materia, in profondità.
I Soffi di foglie restituiscono la memoria del corpo dell’artista e del suo soffio. L’intervento dell’artista segna la sua riflessione sull’esperienza di una relazione fra corpo e materia. Il bronzo restituisce la forma dell’artista impressa nelle foglie oppure solamente lo spostamento delle foglie attraverso il soffio fermato nel tempo [Fig. 11].
La presenza dell’artista come impronta della sua attività creatrice trova una sua forma di sublimazione nelle Propagazioni: dall’impronta del suo dito l’artista sviluppa l’idea di una corrispondenza dell’immagine con il suono e con la luce che si propagano nello spazio ma è anche associata all’ondulazione dell’acqua in una sorta di installazione performativa [Fig. 12].
Sul disegno del 1995 Penone scrive [Fig.13]:
Cristallo, luce della terra che trasporta il pensiero. Albero occhio della Terra, trappola di luci / Sguardo di foglie / Marmo ossa della terra / calcio pensiero di pietra / cervello di cristallo / flauto di vertebre / schiena di vetro/ Albero delle vertebre. Sulla pelle delle dita il disegno del suono (Celant, 1989, 28-29) .
L’impronta umana del dito, come nella struttura degli alberi, produce un progressivo allargamento dei cerchi concentrici, frutto di un paziente lavoro che esprime anche un processo di ascesa, evocando suggestivamente la progressione dei disegni di Botticelli nel Paradiso di Dante. Tale processo trova continuità nelle opere con le spine d’acacia, dove l’impronta delle labbra dell’artista come “[…] spazio incerto perché spazio che confina il dentro col fuori, l’io con l’altro. Spazio di fusione e di osmosi totale”, ma anche come spazio del soffio vitale, si coglie nella visione a distanza dell’opera rispetto a una visione ravvicinata, che invece permette di cogliere l’aggressività della superficie in una polarità di senso (Grenier 2004, 248-253).
Il soffio nelle Metamorfosi di Ovidio è una metafora della creazione e dunque del ‘dar vita’ nel mito di Prometeo che “[…] formò gli uomini con il limo e coll’acqua mentre Atena spirò in essi il soffio della vita”, ma anche della perdita della vita ad esempio nel mito di Orfeo ucciso dalle Baccanti: “Lo ammazzarono sacrileghe e da quella bocca ascoltata perfino dai sassi […] l’anima si disperse con l’ultimo respiro nel vento” (Ovidio, Metamorfosi XI, 41-43).
Al soffio della vita e al ritmo vitale dell’inspirare e dell’espirare Aby Warburg riferisce quella pausa di riflessione, quello spazio del pensiero, Zwischenraum, quell’intervallo che per Penone consiste fra ciò che è fisico e ciò che è pensiero e che si fonda sulla memoria. Così scrive Warburg a conclusione del suo saggio su Rembrandt del 1926:
L’ascensione al sole con Elios e agli Inferi con Proserpina simboleggia due stazioni che nel movimento circolare della vita sono legate l’un l’altra come inspirazione e espirazione; nel nostro viaggio possiamo portare solo un unico bene: la pausa eternamente fuggitiva fra impulso e azione, e sta a noi quanto a lungo possiamo estendere questa pausa del respiro con l’aiuto di Mnemosyne (Warburg [1926] 2007, 362).
Bibliografia
- Basualdo 2018
C. Basualdo, a cura di, Giuseppe Penone. The inner Life of Forms, New York 2018. - Baxandall [1980] 1989
M. Baxandall, Scultori in legno del Rinascimento tedesco [ed. or. The Limewood Sculptors of Renaissance Germany, Yale University Press 1980], trad. it. D. Frigessi, Torino 1989. - Brugerolles 2017
E. Brugerolles, Le partage d’une passion pour le dessin, Paris 2017. - Celant 1989
G. Celant, Giuseppe Penone, Milano 1989. - Cieri Via 2010
C. Cieri Via, Andrea Mantegna e la ‘geologia artistica’, in Mantegna a Roma. L’artista davanti all’antico, a cura di T. Calvano, C. Cieri Via , Roma 2010, 237-270. - Didi-Huberman [2008] 2009
G. Didi-Huberman, La somiglianza per contatto. Archeologia, anacronismo e modernità dell’impronta, [ed. or.: La ressemblance par contact. Archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte, Paris 2008], trad. it. C. Tartarini, Torino 2009 - Esch 2008
A. Esch, Leon Battista Alberti, Poggio Bracciolini, Andrea Mantegna, in Leon Battista Alberti. Humanist, Architekt, Kunsttheoretiker, hrsg. von J. Poeschke, C. Syndikus, Muenster 2008, 123-164. - Grenier 2004
C. Grenier, Giuseppe Penone, ouvrage accompagnant l’exposition présenté au Centre Pompidou, Galerie sud, du 21 avril au 23 aut 2004, Paris 2004. - Kristeller 1902
P. Kristeller, P. Andrea Mantegna, Berlin-Leipzig 1902. - Lancioni 2008
D. Lancioni, a cura di, Giuseppe Penone, Exposition sous la direction de Richard Peduzzi, Accademie de France à Rome, Villa Medici, Paris 2008. - Leroi-Gourhan [1965] 1977
A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, II: La memoria e i ritmi [ed. or.: Le Geste et la Parole II. La Mémoire et les Rythmes, Paris 1965), trad. it. F. Zannino, Torino 1977. - Orlandi, Portoghesi 1966
G. Orlandi, P. Portoghesi (a cura di), L.B. Alberti, De re aedificatoria, Milano 1966, - Pratesi 2003
L. Pratesi (a cura di), Giuseppe, Penone. Paesaggi del cervello, Torino 2003. - Warburg [1926] 2007
A. Warburg, L’antico italiano nell’epoca di Rembrandt, in Opere II. La Rinascita del paganesimo antico e altri scritti (1917-1929), a cura di Maurizio Ghelardi, Torino, 2007, 405-654.
Per citare questo articolo / To cite this article: C. Ceri Via, Le forme viventi:l'impronta e il soffio. Giuseppe Penone e Andrea Mantegna: un dialogo anacronistico, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 258-269 | PDF
Il passato nel presente. Triumphs and Laments di William Kentridge nella lettura di Salvatore Settis (passando per un’Iliade teatrale)
Gabriella De Marco
Leggendo Incursioni, recente quanto corposo volume di Salvatore Settis, mi è tornato in mente, per un personale percorso di associazioni, il potente allestimento dell’Iliade messo in scena dal Teatro Del Carretto, per l’adattamento e la regia di Maria Grazia Cipriani. Non so se lo studioso conosca e apprezzi il lavoro della compagnia toscana e, in particolare, la rilettura dell’Iliade. Tuttavia, non è questo il punto, non è questo l’aspetto importante. Il mio libero quanto arbitrario accostamento, pur non avendo nulla di filologicamente fondato, ha preso forma dalle riflessioni sulla memoria culturale sollecitate dal testo di Settis. Tema presente, a mio parere, pur nelle evidenti diversità, nella ricerca del gruppo teatrale di Lucca. Il rapporto di continuità nelle arti con la memoria dell’antico, con il passato, con la tradizione – intesa nell’accezione etimologica del termine – è una sorta di fil rouge che ha guidato, con coerenza, la ricerca di Settis riverberandosi, anche, nelle pagine del libro.

1 | Iliade, Teatro Del Carretto, regia di Maria Grazia Cipriani, fotografia di Elena Modena, Città del Teatro, Cascina (Pisa), 2013.
Tra gli spunti di Incursioni vi è la convinzione, che tra ‘antico’ e ‘contemporaneo’ non c’è netta frattura, ma una perpetua tensione, che continuamente si riarticola nel fluire dei linguaggi critici e del gusto, nei meccanismi di mercato, nel funzionamento delle istituzioni, nella “cultura popolare”. Un’affermazione pregna di sfumature, aperta a molteplici livelli di lettura, che meriterebbe una giornata di studi. Tuttavia, per tornare al libro, l’autore evidenzia come, nonostante questa continuità, l’età contemporanea, spesso, attui una sorta di tabula rasa con il passato negando, a favore del cambiamento dei sistemi di rappresentazione, quel fluire ininterrotto di una tradizione che si rinnova nel presente.
Settis ribalta, dunque, quello che è un uso riduttivo del termine ‘tradizione’, sinonimo, sovente, di una consuetudine normalizzante, cui si sostituisce, come contraltare, l’originalità della novità e della rottura a tutti i costi. Un’opinione corrente a cui lo studioso si oppone sostenendo come la tradizione sia, al contrario, trasmissione dei saperi tramandata nei secoli, e che, come tale, abbia prodotto non immobilità ma cambiamento, generando, come ho già citato, quella “perpetua tensione che continuamente si riarticola nel fluire dei linguaggi critici e del gusto” (Incursioni, alla pagina 11). Una tensione che ritrovo, per tornare alla mia digressione iniziale, nell’adattamento dell’Iliade, pretesto del mio ragionamento a partire dal libro di Settis.

2 | Iliade, Teatro Del Carretto, regia di Maria Grazia Cipriani, fotografia di Elena Modena, Città del Teatro, Cascina (PI), 2013.
La mise en scène del Teatro Del Carretto esprime, stabilisce, persegue un rapporto con la memoria del passato inteso non come un nostalgico vagheggiamento di un tempo ormai perduto, ma come consapevolezza del presente. Un presente volto a coniugare il mito, la memoria, l’antropologia culturale, il ricordo personale, con la storia. La riscrittura proposta dalla compagnia di Lucca, eco lontana del grande poema epico, è centrata sul confronto tra la tragicità propria della condizione umana e la natura sovrumana degli dei. Una condizione di lontananza dagli dei che relega l’uomo in una dimensione terrena e finita.

3 | Iliade, Teatro Del Carretto, regia di Maria Grazia Cipriani, fotografia di Elena Modena, Città del Teatro, Cascina (Pisa), 2013.
Una situazione evidenziata dalla Compagnia toscana che attinge al crogiolo del mito sedimentato attraverso i secoli nell’immaginario collettivo degli occidentali. Una rappresentazione dal forte tasso evocativo che, tuttavia, mai diviene vernacolo. Ciò grazie, anche, all’ideazione di uno spazio scenico potente ed essenziale che suggerisce, per l’originalità e l’intelligenza creativa del suo autore Graziano Gregori, un’idea di antica terribilità. Una scena abitata da soli uomini e dei, resi sia in carne ed ossa sia da ‘attori artificiali’ che, in un avvincente tessuto fitto di fonti dirette e indirette, include, anche, le avanguardie storiche del primo Novecento. Iliade, quindi, può ritenersi un esempio mirabile di quella capacità di coniugare e tramandare, pur attraverso la creazione di un universo immaginifico ma non destorificato, le fonti della nostra cultura con l’urgenza del presente. Il passato, dunque, non è un calco, sembra ricordarci il Teatro Del Carretto la cui ricerca, nel suo rinnovarsi, attinge alle fonti del passato, nutrendo l’attualità del nostro tempo.

4 | Iliade, Teatro Del Carretto, regia di Maria Grazia Cipriani, fotografia di Elena Modena, Città del Teatro, Cascina (Pisa), 2013.
Analogamente a quanto ci dice, pur se mediante percorsi diversi, William Kentridge attraverso Triumphs and Laments, il grande fregio allestito, a Roma, sugli argini del Tevere, certamente tra le più significative opere di arte urbana del nostro tempo. Ma le riflessioni legate alla memoria culturale inducono a un’altra considerazione: la memoria, è noto, è anche memoria selettiva e come tale implica, necessariamente, uno stretto rapporto con l’oblio sia sul piano del ricordo personale, sia su quello della memoria sociale (Assmann [1999] 2002).
La memoria e l’oblio, quindi, per parafrasare Wisława Szymborska, sono, “una coppia ben assortita” (Szymborska 2012). Non si tratta di stabilire, pertanto, quanto passato sia racchiuso nell’opera di un autore, quanto piuttosto ‘quale passato’ sia racchiuso in un’opera. L’eredità di quello che si definisce genericamente come ‘l’antico’ non è sempre presente in maniera permanente e simultanea nella coscienza personale e in quella collettiva; ciò significa affrontare il rapporto con il tempo della storia e con la selezione delle fonti.

5 | Roma, Lungotevere. (Foto di Federico86, 2008, Wikimedia.Commons.org free media repository.)
L’individuazione, la selezione e la costruzione delle fonti sono alla base del complesso, quanto accurato, lavoro di Kentridge. Triumphs and Laments è espressione incontestabile di come storia e filologia diventino sia nella prassi artistica sia nella prospettiva storiografica, una sorta di stella polare come conferma la lettura che ne fa Settis in Incursioni, dalle cui pagine affiorano temi e categorie centrali nella teoria critica del Novecento e dei nostri giorni (Assmann [1999] 2002; Benjamin [1934] 1973; Bloom [1994] 2000; Bourriaud [1998] 2010; Bürger [1974] 1990; Danto [1992] 2010; Lyotard [1979] 1991).
Incursioni ha, dunque, colpito nel segno avviando una fitta serie di ragionamenti destinata, probabilmente, a farsi, a divenire, sistema. E in ciò risiede la forza, l’impatto di questo prezioso volume, come confermano le molte e avvincenti finestre tematiche che si aprono a partire dalla lettura del fregio realizzato da William Kentridge sui muraglioni del Tevere. Non ripercorrerò su queste pagine le vicende, le caratteristiche, l’ampio apparato iconografico e iconologico ricostruito con accuratezza filologica da Settis e che di per sé costituiscono un esempio di metodo applicato agli studi storici di arte contemporanea. Mi interessa, invece, evidenziare alcuni aspetti importanti che, a partire dal fregio, aprono una vasta gamma di implicazioni. Prenderò in considerazione proprio le pagine finali del saggio dove l’autore inserendo l’opera in un più ampio contesto internazionale che spazia dai murales alla street art, dall’installazione all’arte pubblica propone un’apparente deviazione dall’intervento ‘romano’ del grande artista sudafricano citando un passo da Monumenti di Robert Musil:
[…] la cosa più strana dei monumenti è che non si notano affatto. Nulla al mondo è più invisibile. Non c’è dubbio che essi sono fatti per esser visti, anzi per attirare l’attenzione; ma nello stesso tempo hanno qualcosa che li rende, per così dire, impermeabili, e l’attenzione vi scorre sopra come le gocce d’acqua su un impermeabile, senza arrestarsi un istante […]. Per farsi notare, insomma i monumenti dovrebbero darsi da fare come tutti noi (Incursioni, alla pagina 335).

6 | Roma, Lungotevere Prati. (Foto di Blackcat, 2011, Wikimedia.Commons.org free media repository.)
Sparigliando le carte, Settis ci distoglie da Kentridge e dal suo intervento di arte urbana per affrontare, con la complicità del grande scrittore, alcuni nodi irrisolti, eppur urgenti, di molte città contemporanee e di Roma in particolare. Ma la divagazione dello studioso è, infatti, soltanto apparente perché non solo ci riconduce al forte impatto impresso sul territorio capitolino dal lavoro dell’artista di Johannesburg, ma perché si fa, come tutto il volume, sensore dell’attualità.

7 | E. Basile, M. Rutelli, A. Ugo, G. Geraci, Monumento alla libertà e ai caduti, 1909-1910, 1930-1931, bronzo, marmo, pietra, Palermo. (Foto di Fabio P., 2014, Wikimedia.Commons.org free media repository.)

8 | E. Gallori, Monumento a Giuseppe Garibaldi, 1895, bronzo, Roma. (Foto di Rebax63, 2017, Wikimedia.Commons.org free media repository.)
I monumenti, e concordo, attraverso Settis, con Musil, erano diventati sempre più, nella percezione collettiva, da simboli del potere, da polarità urbane dalla forte connotazione celebrativa e identitaria, a spazi neutrali, anonimi, muti e spesso incongrui con i ritmi, con il fluire della città contemporanea. Fatte, dunque, alcune importanti eccezioni, i monumenti sembravano aver perduto la funzione di senso, il rapporto di necessità con il contesto che li accoglieva. Sia che si trattasse di scultura o di un’opera architettonica sia di un’installazione o di un intervento site-specific, avevano smarrito, sovente, il rapporto fondante con il luogo e con la memoria del luogo (Gallerani 2002; De Marco 2002; De Marco 2020).
Ma se la solitudine del monumento costituisce un aspetto innegabile di molte realtà urbane condizionando, anche, la fruizione del cittadino, il marmo, la pietra e il bronzo non sono immutabili come siamo portati, spesso, a pensare (Bourriaud [1998] 2010; De Marco 2016; Lowe [2020] 2021). Al contrario, confermano ancora una volta, come la memoria sia sempre dinamica, come dimostrano le immagini che, sempre più di frequente, provengono dalla carta stampata, dai telegiornali e dal web e che raccontano di graffiti, di scarabocchi, di rovesciamenti di statue e monumenti legati al passato coloniale, schiavista e razziale di molti Paesi.
La caduta, il rovesciamento iconoclasta a cui sono, oggi, soggetti molti monumenti e statue del passato ne ribalta la percezione ormai consolidata facendoli diventare da luoghi silenti a luoghi della divisione e dello scontro sociale il cui ribaltamento e/o distruzione aggiunge nuovi strati di significato. L’abbattimento di simboli e personalità considerate fondanti mette in luce, proprio attraverso la furia della contestazione, come il punto di vista della storia sia disseminato di insidie, di strascichi irrisolti che non vanno ignorati, negati o rimossi ma riletti (Isnenghi 2004; Romano 2015; Nacci 2019).
Spetterà, pertanto, anche agli storici dell’arte fornire utili quanto preziose chiavi di lettura su questi avvenimenti (De Marco 2019 e De Marco 2020). Ciononostante, quella che era ritenuta opportunamente l’invisibilità del monumento, per tornare alle raffinate pagine di Settis che cita Musil, è spunto funzionale alle argomentazioni dell’archeologo perché gli permette di suggerire l’analogia con Roma, una città ricca di storia che stenta, oggi, a farsi notare perché incapace di recuperare, di attivare, una nuova progettualità.
Città eterna per antonomasia, Roma è “Roma-città” e “Roma-mondo”, per ricordare una definizione cara a Lotman, e come tale può essere paragonata solo a Gerusalemme, altro luogo simbolo, dal forte potere di fascinazione (Giardina, Vauchez 2000; Lotman 1985). Nel contesto romano, scrive Settis, nulla come Triumphs and Laments ha mostrato, di recente, una capacità di riattivare i meccanismi della memoria visuale, in una città sovraccarica di monumentalità e di storia, e forse proprio per questo, aggiungo, incline a non guardare, a non ricordare. Kentridge, al contrario, ci costringe a ricordare, a riflettere. Nella lunga sequenza disegnata sulle sponde del Tevere si volge, anche, al passato non appiattendolo in letture affrettate. L’artista, infatti, non banalizza perché attinge al tempo della storia, selezionando e prendendo posizione, offrendo più livelli di interpretazione e realizzando un intervento che, nonostante la sua voluta natura effimera, è destinato a durare.
Non un intervento calato dall’alto, dunque, ma un progetto accurato che ha stabilito un rapporto di necessità, di pertinenza con il luogo. Ciò paradossalmente proprio nell’essere anti-monumento. L’artista ci ha messo di fronte alla storia con un segno non invasivo, non inutilmente narcisistico ma rispettoso dell’ambiente, conciliando la transitorietà con il valore culturale della perennità. Kentridge, per concludere con le parole di Paul Éluard, ha dato forma, da grande artista qual è, a “le dur désir de durer”.
Avvertenze
Il titolo del volume che, su queste pagine cito soltanto come Incursioni, è per esteso: Incursioni. Arte contemporanea e tradizione edito da Feltrinelli, nel 2020. L’adattamento dall’Iliade da parte del Teatro Del Carretto, compagnia attiva dal 1983 che ha sede a Lucca presso il Teatro del Giglio, è di Maria Grazia Cipriani che ha curato anche la regia. Le scene e i costumi sono di Graziano Gregori su suoni di Hubert Westkemper, le luci di Gianni Pollini. Qui mi riferisco all’edizione del 2015 presso il Teatro Guglielmi di Massa trasmessa il 9 Gennaio 2021 da Rai 5, canale 23. Segnalo, per una disaminata dettagliata: https://www.teatrodelcarretto.it. Giova sottolineare come il nome della compagnia rimandi, tra i molti riferimenti e secondo quanto mi ha detto Cipriani, al monumento funebre a Ilaria Del Carretto collocato nella Cattedrale di San Martino a Lucca a cui attese, tra il 1406 e il 1410, Jacopo della Quercia. La definizione di ‘attore artificiale’, densa di rimandi cui su queste pagine non posso accennare, mi è stata suggerita da Maria Grazia Cipriani e Tania Tonelli, preziose alleate per la stesura di alcune parti di questo scritto e a cui va la mia gratitudine. Un grazie, anche, a Elena Modena per aver acconsentito la pubblicazione delle foto di scena, libere dai vincoli dei diritti di autore. Le immagini si riferiscono alla rappresentazione del 2013, sempre per la regia e allestimento di Cipriani, presso Città del Teatro, Cascina (PI).
Il grande fregio di 550 metri in lunghezza per un’altezza massima di oltre 12 metri, di William Kentridge (Johannesburg, 28 aprile 1955), posto sugli argini del Tevere fra Ponte Sisto e Ponte Mazzini, è stato inaugurato con un corteo festivo, il 21 aprile del 2016, giorno in cui si celebra il Natale di Roma. Opera partecipata per la cui realizzazione l’artista si è avvalso di un insieme di competenze disciplinari molteplici comprese, naturalmente, quelle di storici e storici dell’arte. Il fregio è stato realizzato con una tecnica originale e rispettosa dell’ambiente volta a limitare, nel tempo, la durata dell’opera. Tecnica che ha sfruttato in senso creativo, tramite l’idropulitura, la rimozione dello smog e della patina biologica accumulatasi negli anni sui muraglioni, facendo emergere, per sottrazione, il complesso quanto articolato corteo d’immagini che anima l’intero lavoro. Un procedimento che non solo non ha alterato le caratteristiche chimico-fisiche degli argini ma ha utilizzato lo smog come pigmento e già adottato da Kristin Jones nel 2005, per She Wolves, intervento pensato in occasione dell’evento inaugurale di Solstizio d’Estate organizzato dall’Associazione onlus Tevereterno.
Per un’attenta disamina del fregio, delle sue dimensioni, e delle fasi preliminari alla sua realizzazione rimando alle pagine 274-336 del citato volume di Settis. Il fregio di Kentridge, unitamente ad alcune realizzazioni coeve di street art e all’intervento site-specific Floating Piers sul lago d’Iseo a firma di Christo (Gabrovo, 13 giugno – New York, 31 maggio 2020), sono stati oggetto di alcune di lezioni da me tenute, nel 2016, per il Corso di Laura Magistrale di Storia dell’arte dell’Ateneo di Palermo.
Riferimenti bibliografici
- Assmann, [1999] 2002
A. Assmann, Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale [ed. or.: Erinnerungsraume: formen und Wandlungen des kulturellen Gedachtnisses, München 1999], trad. it. S. Paparelli, Bologna 2002. - Benjamin [1934] 1973
W. Benjamin, L’autore come produttore, in W. Benjamin, Avanguardia e rivoluzione, [ed. or.: Der Autor als Produzent. Ansprache im Institut zum Studium des Fascismus in Paris am 27. April 1934], trad. it. A. Marietti, Torino 1973. - Bloom [1994] 2000
H. Bloom, Il canone occidentale [ed. or.: The Western Canon, New York 1994], trad. it. F. Saba Sardi, Milano 2000. - Bourriaud [1998] 2010
N. Bourriaud, Estetica relazionale [ed. or.: Esthétique relationnelle, Dijon 1998], trad. it. M.E. Giacomelli, Milano 2010. - Braccesi 1989
L. Braccesi, L’Antichità aggredita. Memoria del passato e poesia del nazionalismo, Roma 1989. - Burke [2001] 2002
P. Burke, Testimoni oculari. Il significato storico delle immagini [ed. or.: Eyewitnessing, Londra 2001], trad. it. G.C. Brioschi, Roma 2002. - Bürger [1974] 1990
P. Bürger, Teoria dell’avanguardia [ed. or.: Theorie der Avantgard, Göttingen 1974], trad. it. A. Buzzi, Torino 1990. - Crispolti 1997
E. Crispolti, Come studiare l’arte contemporanea, Roma 1997. - Danto [1992] 2010
A.C. Danto, Oltre il brillo box. Il mondo dell’arte dopo la fine della storia [ed. or.: Beyond the Brillo Box: the visual arts in post-historical perspective, Berkeley and Los Angeles 1992], trad. it. M. Rotili, Milano 2010. - De Marco 2002
G. De Marco, Postille a: rilievo, scultura, luogo di Paolo Gallerani. Problemi del fare nelle arti plastiche oggi, “Avanguardia. Rivista di letteratura contemporanea” 7 (2002),19-30. - De Marco 2011
G. De Marco, Mussolini e l’uso pubblico della storia: dalle demolizioni nel centro storico di Roma al complesso dell’E42, in D. Lacagnina (a cura di), Immagini e forme del potere. Arte, critica e istituzioni in Italia fra le due guerre, Palermo 2011, 33-48. - De Marco 2016
G. De Marco, Costruire il consenso: architettura, spazio urbano e committenza nell’Europa contemporanea, “Epekeina, International Journal of Ontology History and Critics” 1-2 (2016), 1-12. - De Marco 2016
G. De Marco, Sull’avvio del canone negli studi di storia dell’arte contemporanea nell’era della globalizzazione digitale. Spunti da uno scritto di Cesare Segre, “Classico Contemporaneo” 2 (2016), 13-34. - De Marco 2018
G. De Marco, L’Ara Pacis di Augusto e la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2006 del Comune di Roma, “Classico Contemporaneo” 4 (2018), 1-15. - De Marco 2019
G. De Marco, La Costituzione della Repubblica Italiana, l’Archivio Centrale dello Stato e l’Eur. Un esempio di potenziale risemantizzazione?, in F. La Mantia, A. Le Moli (a cura di), Persona, comunità, strategie identitarie. Convegno del dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Palermo (Palermo 27-29 novembre 2018), Palermo 2019, 3-22. - De Marco 2020
G. De Marco, La memoria come patrimonio di sofferenza. Le pietre d’inciampo (Stolpersteine) di Gunter Demnig in via Madonna dei Monti a Roma, in D. Tononi e M. Di Figlia (a cura di), Tempo e Shoah, Palermo 2020, 147-159. - De Marco 2020
G. De Marco, Perchè non è vero che Yale University ha cancellato il Rinascimento, “Artribune” (4 febbraio 2020). - Éluard 1950
P. Éluard, Le dur désir de Dürer, Paris 1950. - Gallerani 2002
P. Gallerani, Rilievo, scultura, luogo. Problemi del fare nelle arti plastiche oggi, “Avanguardia” 7, 21 (2002), 19-31. - Gentile 2007
E. Gentile, Fascismo di pietra, Bari-Roma 2007. - Giardina 2000
A. Giardina, A. Vauchez, Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini, Bari-Roma 2000. - Habermas [1962] 2005
J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica [ed. or.: Strukturwandel der Öffentlichkeit, Neuwied 1962], trad. it. A. Illuminati, F. Masini, W. Perretta, Bari-Roma 2005. - Isnenghi 2004
M. Isnenghi, L’Italia in piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1898 ai giorni nostri, Bologna 2004. - Kentridge [2014] 2016
W. Kentridge, Sei lezioni di disegno [ed. or.: Six drawing lessons, Cambridge, Massachusetts 2014], trad. it. N. Poo, Monza 2016. - Knight 2008
C.K. Knight, Public art. Theory,practice and populisme, Oxford 2008. - Lacy 1995
S. Lacy, Mapping the Terrain: new genre public art, Seattle 1995. - Lotman 1985
J.M. Lotman, La semiosfera: l’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, trad. it. e cura di S. Salvestroni, Venezia 1985. - Lyotard [1979] 1991
J.F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere [ed. or.: La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris 1979], trad. it. C. Formenti, Milano 1991. - Lowe [2020] 2021
K. Lowe, Prigionieri della storia [ed. or.: Prisoners of history, New York 2020] tra. it. C. Baffa, Milano 2021. - Mitchell 1992
W.J.T. Mitchell, Art and public sphere, Chicago 1992. - Mirzoeff [2015] 2017
N. Mirzoeff, Come vedere il mondo. Un'introduzione alle immagini: dall'autoritratto al selfie, dalle mappe ai film (e altro ancora) [ed. or.: How to see the world an introduction to images, from self-portraits to selfies, maps to movies, and more, London 2015], trad. it. R. Rizzo, Monza 2017. - Musil [1936] 1986
R. Musil, Monumenti, in R. Musil., Romanzi brevi, novelle e aforismi [ed. or. Denkmale, in Nachlass zu Lebzeiten, 1936,1957], trad. it. A. Rho, Torino 1986. - Nacci 2019
M. Nacci, Il volto della folla. Soggetti collettivi, democrazia, individuo, Bologna 2019. - Nicoloso 2008
P. Nicoloso, Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell'Italia fascista, Torino 2008. - Ricci 2006
A. Ricci, Attorno alla nuda pietra. Archeologia e città tra identità e progetto, Roma 2006. - Ricoeur [2000] 2003
P. Ricoeur, La memoria, la storia e l’oblio [ed. or.: La memoire, l’historie, l’oubli, Parigi 2000], trad. it. D. Iannotta, Milano 2003. - Romano 2015
M. Romano, La piazza europea, Venezia 2015. - Settis 2002
S. Settis, Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale, Torino 2002. - Settis 2004
S. Settis, Futuro del “classico”, Torino 2004. - Settis 2017
S. Settis, Architettura e democrazia. Paesaggio, città, diritti civili, Torino 2017. - Szymborska [2011] 2012
W. Szymborska, Basta così [Wystarczy, 2011), a cura di R. Krynicki, trad. it. S. De Fanti, Milano 2012. - Weil [1940-1941] 2012
S. Weil, L’Iliade, o il poema della forza [ed. or.: L’Iliade ou le poème de la force, “Les Cahiers du Sud”, 1940-1941], trad. it. F. Rubini, Trieste 2012.
Per citare questo articolo / To cite this article: G. De Marco, Il passato nel presente. Triumphs and Laments di William Kentridge nella lettura di Salvatore Settis (passando per un'Iliade teatrale), “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 270-283 | PDF
Prendendo in considerazione il sottotitolo del volume di Salvatore Settis – Arte contemporanea e tradizione – appare evidente a mio avviso come il problema fondamentale sia quello del rapporto fra innovazione e tradizione nella storia dell’arte. Se nella storia dell’arte tradizionale l’evoluzione è segnata dal passaggio da un paradigma all’altro, che implicava una rottura drastica con il passato e insieme un nuovo inizio, ciò che contraddistingue invece la contemporaneità è il passaggio da un’epoca caratterizzata dalla presenza di paradigmi a un’epoca nella quale l’unico paradigma è l’assenza di paradigmi. Questo significa che nelle varie espressioni artistiche contemporanee vengono ripresi, di volta in volta, alcuni paradigmi del passato per trasformarli radicalmente. In questo senso la cosiddetta tradizione artistica è di fatto il risultato di un dialogo costante tra ogni momento della storia e tutto ciò che lo precede: in altre parole, non si dà innovazione senza tradizione, né tradizione senza innovazione. Si tratta di una vera e propria presupposizione reciproca di condizione e condizionato, ovvero dell’importanza assegnata all’elemento sensibile, in quanto irriducibile all’elemento intelligibile, e che trova la sua origine nella ‘morfologia’ goethiana. La morfologia è per Goethe un’indagine volta non a ricercare le cause nascoste dei fenomeni, ma a descriverne le forme esteriori, vale a dire la loro dimensione sensibile e le configurazioni attraverso le quali tale dimensione si rende visibile. Proprio perché non c’è per Goethe un’essenza nascosta in base alla quale la nozione di forma possa essere definita una volta per tutte, il punto di vista morfologico implica la nozione di ‘metamorfosi’, ovvero una trasformazione continua della forma stessa. Che la forma sia inscritta nel contesto delle sue trasformazioni, significa allora che la forma deve essere intesa non come Gestalt, bensì come Gestaltung, nel senso che la sua unità implica la molteplicità delle diverse manifestazioni, tra le quali – per dirla con Wittgenstein e con Warburg – sono descrivibili sempre nuovi rapporti di somiglianze e differenze.
È quanto mostra per esempio un’opera che ha assunto un valore iconico nell’arte del Novecento, ovvero Les Demoiselles d’Avignon (1907) di Pablo Picasso. L’artista ci dimostra come fra antico e moderno non ci sia mai netta frattura, ma una perpetua tensione che si configura come un vero e proprio dialogo. Il problema di fondo è di riconoscere in qualcosa che vediamo per la prima volta la traccia di qualcos’altro che sapevamo già, e che per questo mette in moto la nostra memoria facendoci dialogare con la storia. Les Demoiselles d’Avignon infatti è un’opera che rompe con il passato immediato – la bellezza e il naturalismo della rappresentazione – per attingere a modelli assai lontani nel tempo e nello spazio, quali quelli offerti dalle arti oceaniane, africane e antico-iberiche. La visita di Picasso al Trocadero, che come ha detto lui stesso è stata una “rivelazione”, non rappresenta realmente il suo primo contatto con tale arte. Diverse testimonianze provano che già alla fine del 1906 Derain gli aveva mostrato un oggetto africano e Picasso aveva cominciato a collezionare arte negra; non solo, ma è altamente probabile che il pittore spagnolo abbia visto alcune maschere e statuette africane prima di cominciare Les Demoiselles. Tuttavia il Trocadero, oltre a permettere a Picasso di scoprire opere tribali di stili diversi, gli dà la possibilità soprattutto di coglierle in un contesto differente da quello dell’atelier di un artista. Insomma, se l’arte tribale non gli fa una particolare impressione tra l’autunno del 1906 e il giugno del 1907, improvvisamente nell’estate del 1907 egli comincia a considerare queste maschere e questi feticci da una prospettiva nuova che concorda con quanto intende conseguire con Les Demoiselles. Sembra comunque che anche altri fattori abbiano influito sull’opera di Picasso, e uno di essi è probabilmente la ripresa del dialogo con El Greco, e in particolare con la sua Visión del Apocalipsis o Visión de San Juan (1608-1614). Ora, se questo quadro di El Greco ha un’incidenza diretta sulle Demoiselles, non è per la particolarità del tema religioso bensì per la forma con la quale il tema è presentato: di fatto, il formato verticale delle Demoiselles si distingue da tutti gli altri suoi abbozzi, e ciò fa pensare che la compressione dei gruppi di nudi nel formato insolito di El Greco abbia potuto spingere Picasso a modificare la forma del quadro progettato. Del resto le due opere, quella di El Greco e quella di Picasso, presentano un certo numero di affinità che consistono, oltre che nella forma di esecuzione, anche nel colore generale della composizione e nei dettagli delle posture; Picasso doveva essere affascinato dal modo in cui El Greco aveva giustapposto i personaggi, divisi in tre livelli di profondità, nello spazio di un primo piano molto compresso e completamente chiuso al fondo da drappeggi di tende.
Più in generale, per capire cosa si intende per tradizione artistica, Settis si rifà da una parte a Julius Schlosser e dall’altra ad Aby Warburg. Secondo la concezione di Schlosser, che il grande artista rinnovi quelle stesse immagini che ha ereditato dalla tradizione significa che la tradizione è sempre alla base di ogni innovazione. Del resto, quella che chiamiamo ‘tradizione artistica’, è caratterizzata non dall’immobilità bensì da quel cambiamento che è il risultato appunto di un dialogo ininterrotto, tra ogni artista e quelli delle generazioni precedenti. E a volte il dialogo si presenta non come ripresa dell’arte delle generazioni immediatamente anteriori, ma dell’arte di un passato assai più remoto, come accade in modo esemplare nel Rinascimento, che si rifà ai modelli greco-romani. A questo proposito c’è da sottolineare il fatto che se fra Quattro e Cinquecento l’arte si rinnova rifacendosi ai modelli della Grecia antica, fra Otto e Novecento gli artisti, desiderosi di mettere a punto un’arte bidimensionale, si rifanno all’arte egizia e alle icone greco-russe. Insomma, sembra indubbio che nessun artista possa prescindere da un qualche dialogo con il passato. A tal proposito è importante, sempre per Settis, l’opera di Aby Warburg, che ha sottolineato la resurrezione dell’arte e della cultura greco-romana nel cuore della storia europea e in particolare nel Rinascimento. Di qui quel Nachleben der Antik (‘sopravvivenza dell’antico’) che però implicava una staticità degli schemi iconografici e della gestualità delle figure; per dare dinamicità e vita a tali figure, Warburg introduce l’espressione Pathosformel (‘formula del pathos’), nella quale – come giustamente afferma Settis – una componente – Formel, ovvero ‘formula’ – implica fissità e ripetizione di stereotipi, mentre l’altra – Pathos – implica instabilità e movimento. Così, la ‘formula del pathos’ è in grado di dare nuova vita attraverso nuove immagini interiori.
Per quanto riguarda la rappresentazione del movimento, secondo Warburg la svolta decisiva ha coinciso con il primo Rinascimento fiorentino. È stato allora che pittori come ad esempio Botticelli e Ghirlandaio, osservando opere d’arte greco-romane, impararono a suggerire all’osservatore il movimento delle figure che necessariamente erano immobili sulla tela: l’artificio al quale ricorsero fu quello di far muovere nello spazio i lembi delle vesti, i capelli sciolti e altro, insomma di far soffiare sulla tela il vento. L’Antichità appariva dunque a Warburg come instabilità, movimento, l’esatto opposto dell’idea classicista dell’arte greca come “nobile semplicità e quieta grandezza” affermata da Johann Joachim Winckelmann. Questo è quanto Warburg mostra nella sua ultima opera Mnemosyne, un’opera non-finita, anche perché si tratta di un progetto strutturalmente senza fine. Il presente come innovazione può entrare in dialogo con la tradizione proprio grazie alle Pathosformeln. Non solo, ma nella contemporaneità troviamo anche artisti che dichiarano le proprie fonti, tematizzando anzi il rapporto con tali fonti come oggetto della propria arte e dando loro un significato nuovo e diverso: è il caso, ancora una volta, delle Demoiselles d’Avignon. Proprio riflettendo su come Picasso ha realizzato l’opera, possiamo rivolgere la nostra attenzione al dialogo tra il presente e le fonti appartenenti al passato e alla tradizione artistica. L’opera rappresenta una sala di bordello con cinque donne nude, nelle posizioni tratte dalle Baigneuses di Cézanne, nella versione Cinq Baigneuses. Alcuni disegni preparatori precisano che le ragazze al centro con le braccia alzate derivano da quella a destra del Bain turc di Ingres.
Nel saggio su Renato Guttuso, con riferimento ai disegni del pittore dedicati alla morte di Pablo Neruda, Settis si concentra proprio sull’elemento del “braccio cadente verso il suolo”, una delle Pathosformeln che Warburg aveva già trattato nel suo Atlante Mnemosyne: si tratta di un gesto che dall’arte classica giunge al presente, passando per la Deposizione del Caravaggio e il Marat di Jacques-Louis David, al quale fu commissionato il giorno successivo l’omicidio dello stesso Marat. Settis, oltre a sottolineare come sia il braccio cadente verso il suolo a dare forza ed eloquenza alla denuncia del delitto, evidenzia l’identificazione di Neruda con Marat, e conseguentemente di Guttuso con David, identificazioni suggerite dalla corrispondenza dello schema compositivo: la postura del morente, la penna e il foglio nelle mani, la dedica del pittore. Il cammino della storia dell’arte non è affatto lineare, anzi è percorso da linee di frattura e sentieri interrotti, e tuttavia nulla sembra costituire una rottura così radicale con il passato quanto la video-arte. Resta il fatto che la stessa video-arte non nasce ex nihilo, come mostra in modo esemplare l’opera di un artista come Bill Viola, dove il passato è sempre richiamato in modalità differenti. Alcune opere di Bill Viola trasformano le fonti della tradizione: è il caso di Emergence (2002), che riprende uno dei grandi temi dell’arte cristiana, ovvero il ‘Cristo al sepolcro’. Qui, il corpo del giovane, che esce dal sepolcro-pozzo spinto dal getto di acqua e al quale si avvicinano due donne (il che potrebbe somigliare alla figura del Cristo accudito da Maria e dalla Maddalena), è un corpo morto e non, come quello della tradizione religiosa, il corpo del Cristo resuscitato. Proprio a indicare la morte del corpo, ritroviamo quel braccio cadente di cui abbiamo parlato, che riattualizza in ambito video-artistico la classica Pathosformel della tradizione passata. Il rapporto tra The Greeting (1995) e la Visitazione del Pontormo (1528) è probabilmente il più famoso tra i molti che intercorrono fra le opere di Bill Viola e quelle dei maestri del passato. Le somiglianze compositive, di formato, di tema e di sviluppo narrativo, sono qui così marcate che si potrebbe essere tentati di descrivere il video come la trasposizione fedele del dipinto, con minime oscillazioni e deviazioni (come gli abiti delle protagoniste), tutte nella direzione di una secolarizzazione della scena, che pure conserva in sé una forte carica allusiva al quadro religioso che ne è all’origine. Non si tratta comunque di una semplice trasposizione illustrativa. Quel che Pontormo ci mostra nel suo quadro è un incontro molte volte rappresentato nell’arte cristiana: la Visitazione della Vergine Maria a Santa Elisabetta. Le due donne, che nel quadro del Pontormo assistono all’incontro guardando lo spettatore (Viola le riduce a una), con la loro solenne fissità sembrano consapevoli di quel che sta avvenendo, e invitano l’osservatore a considerare quell’incontro oltre le apparenze del visibile, sia per il mistero che simboleggia, sia per il futuro che rivela. Nonostante la straordinaria intensità della scena evangelica, e di questa sua rappresentazione a opera del Pontormo, non sembra in questo caso che sia il tema ad aver attratto l’attenzione di Bill Viola, quanto piuttosto le sue modalità rappresentative. Se nel Pontormo la Visitazione della Vergine Maria a Santa Elisabetta è di fatto l’incontro tra Gesù e il Battista, entrambi nel grembo delle madri incinte, quello che tuttavia – come sottolinea bene Settis – attira l’attenzione di Bill Viola non è questa tradizione religiosa ma piuttosto il movimento delle figure che nel Pontormo è denotato dalle vesti mosse dall’aria. Per Bill Viola, che secondo Settis non conosceva Warburg, il punto centrale è che il movimento non ha bisogno di essere rappresentato come nella pittura rinascimentale dagli “accessori” (vesti, capelli), dal momento che può essere rappresentato direttamente dal medium elettronico. Questo video-artista, che pensa se stesso come un pittore, fa e rifà continuamente i conti con la tradizione artistica, stabilendo con l’osservatore un dialogo che presuppone il riferimento a saldissime radici nella storia pittorica precedente. Bill Viola, nell’ereditare problemi e procedure proprie della tradizione artistica, li declina in una nuova forma espressiva, instaurando e proseguendo un dialogo proficuo con la tradizione artistica, mantenendo questo dialogo intenso con l’arte del passato anche nell’epoca della cultura digitale.
Nel saggio Marcel Duchamp si taglia la testa, troviamo una foto del 1937, dove una donna abbigliata in vesti vagamente all’antica guarda fuori campo mentre tiene in mano un metro da sarto; nello stesso tavolo vediamo la testa di un uomo che sembra appoggiato su di esso. Non avendo titolo, Settis propone di chiamare questa foto Doppio ritratto: lui, il decollato, è Marcel Duchamp, lei è la sua compagna Mary Reynolds. Ora, se come afferma Settis quello con cui qui abbiamo a che fare è una donna indifferente alla testa mozzata dell’uomo, c’è da dire che si conoscono alcune serie iconografiche che possono essere descritte allo stesso modo: Giuditta con la testa di Oloferne, Salomè con quella del Battista, e possiamo aggiungere anche il giovane Davide con la testa di Golia. Secondo una tradizione pittorica che Settis condivide, la testa tagliata rappresenta il pittore che è stato l’autore di quel dipinto. Il riferimento più noto è Giuditta e Oloferne di Cristoforo Allori (1612): secondo una certa tradizione, il pittore avrebbe voluto qui riflettere il proprio tormento amoroso a causa dell’infedeltà della donna della quale era innamorato; per questo ritrasse la donna nella figura di Giuditta, e se stesso in quella di Oloferne. In questo modo il pittore vuole esaltare il potere della rappresentazione, riscattando il proprio dolore grazie alla forza dell’arte.
Il Davide con la testa di Golia di Caravaggio mostra un’assonanza con il famoso autoritratto di Rembrandt del 1658. Nell’opera di Caravaggio, il bagliore accecante di ciò che emerge dall’oscurità rende visibile solo l’arco della composizione, il fanciullo con le sue guance ancora tonde regge l’enorme testa del nemico sconfitto; questa già perde colore e gli occhi sono privi di espressione. I vestiti del fanciullo hanno le stesse tonalità dell’autoritratto di Rembrandt: il bastone nella mano sinistra splende di un metallo opaco, come la spada dietro le spalle di Davide, e la tunica gialla sul petto è come una corazza da cui spuntano le pieghe della camicia. Guardando bene Davide con il suo trofeo, in equilibrio tra l’uccisore e l’ucciso, tra ciò che è in ombra e ciò che è in luce, vale a dire tra il ‘decomporsi’ e il ‘fiorire’, si scopre che non c’è differenza tra vincitore e vinto. Il quadro sembra parlare di questo e se ne ha conferma quando ci si rende conto che il fanciullo vivo e il gigante morto hanno lo stesso volto: sono fasi diverse di uno stesso processo, una dimostrazione del ‘prima’ e del ‘dopo’. Se è vero che la testa di Golia non è altro che un autoritratto di Caravaggio, diventa allora ancora più interessante, nel confronto dei tratti, accorgersi che l’autoritratto è doppio. Quello a cui assistiamo sono i cambiamenti del volto nel suo movimento dall’inizio alla fine: è forse questo il primo caso in cui per l’artista il soggetto non è solo un io-definito, ma un io-flusso. Anche per questo l’opera di Caravaggio si avvicina a Rembrandt, soprattutto al Rembrandt degli autoritratti, dal momento che, messi in fila ed esaminati uno dopo l’altro, questi autoritratti formano una sorta di catalogo: una serie di riflessi catturati in casi di emergenza di quella stessa propensione a seguire la natura. Forse l’idea non stava nel cogliere il passaggio tra la fine di un autoritratto e l’inizio di quello successivo, ma nel serbare accuratamente il ‘tipo’: il Rembrandt dipinto cambia di tela in tela, mantenendo intatto il nucleo, e sembra dirci ‘questo ero, questo non sarò più’. Allo stesso modo, tra l’altro, funziona anche il selfie, genere che pervade la contemporaneità: la ricerca delle differenze è stata sostituita dalla produzione di duplicati. Se Jean Cocteau parla del cinema come dell’unica arte che attesta il lavoro della morte, gli autoritratti di Rembrandt, che non fanno altro che questo, possono essere equiparati a una sorta di protocinema, mentre i chilometri di selfie, scattati da tutti e a tutti accessibili, sembrano il rovescio, l’altra faccia della medaglia: una cronaca di morte in atto nel consorzio umano, che non interessa più a nessuno già da un pezzo. In particolare, nel tableau vivant fotografico creato da Duchamp, resta oscuro il significato del metro da sartoria che Mery Reynolds sta maneggiando: forse, come dice Settis, Duchamp vuole mostrare un togliersi via dalla tradizione artistica prendendone le misure con un metro sartoriale. Resta tuttavia il fatto che “dentro o dietro un ripudio così radicale, la tradizione artistica in qualche modo – come residuo, rifiuto, rimasuglio – c’è ancora tutta” (Settis, Incursioni, 63).
Settis dedica una particolare attenzione a un protagonista dell’arte italiana del Novecento, ovvero Giuseppe Penone, nella cui arte è espresso in modo esemplare il tema del rapporto fra innovazione e tradizione. Per quanto riguarda il tema della tradizione, Settis fa notare come inizialmente il tempio greco aveva colonne di legno, sostituite poi con la pietra, sì che legno e pietra sono stati a lungo fianco a fianco. Non solo, ma nella forma di una colonna, che fosse di pietra o di legno, il greco ‘leggeva’ la figura umana. Anche le statue di legno erano concepite dai greci come una fase primordiale della scultura, e questa vicinanza dell’albero (del legno) all’uomo si spinge quasi fino all’identità, come mostra Ovidio nelle metamorfosi in piante di uomini o ninfe. Nelle Metamorfosi, infatti, troviamo spesso la trasfigurazione di un corpo umano o divino in una pianta, come mostra la metamorfosi di Dafne inseguita da Apollo. Giuseppe Penone, nel riconoscere nel bosco l’inizio della sua scultura, esprime il ripudio della concezione dell’arte come rappresentazione; di qui quel ‘grado zero’ della scultura che è tutt’uno con il ‘fare’. Così la scultura, non avendo un fine predeterminato, giunge a un risultato non previsto e che, come tale, non può che sorprenderci. Penone prende le distanze dalla tradizione culturale italiana che non rifiuta l’immagine e la rappresentazione, mentre quello che lui ricerca è la materia che ha un valore in quanto tale, indipendentemente da ogni sua capacità raffigurativa. Così Penone, ponendo la rappresentazione in sintonia con la cultura cattolica e la sua negazione con l’ebraismo, sembra richiamarsi al comandamento biblico “non ti farai idolo né immagine alcuna”. Sulla base di questo divieto, Penone lavora con la materia in modo tale da ‘vedere’, come accadeva a Vitruvio, la figurazione dove non c’è: un corpo di uomo in una colonna dorica, una donna in una colonna ionica, una fanciulla in una colonna corinzia. Così – mette giustamente in evidenza Settis – la radicale novità della scultura di Penone fa tutt’uno con le sorgenti stesse della tradizione. Di fatto la metamorfosi della materia durante il lavoro dell’artista comporta l’identificazione tra uomo e natura; la scultura di Penone, basata sul divieto della raffigurazione e sulla convinzione che la materia possegga una creatività innata, costituisce un nuovo inizio dell’azione artistica fondato sulla materia e il tempo: l’artista infatti fa dialogare la nostra temporalità con quella inesorabile e lenta della natura. Penone quindi recupera la pienezza della figura umana proprio nella natura, facendosi natura e non più copiando la natura stessa.
Per citare questo articolo / To cite this article: G. Di Giacomo, La necessaria complementarietà fra innovazione e tradizione, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 284-291| PDF
Exegi monumentum aere perennius (Orazio, Odi III, 30, 1). Se l’arte antica, parafrasando l’ode di Orazio, si erge quale “monumento più duraturo del bronzo”, l’arte contemporanea è spesso effimera, costituita da istallazioni temporanee, da performance che vivono nell’hic et nunc di un dato contesto spazio-temporale, da prodotti transeunti e mutevoli. Eppure l’arte contemporanea non nasce dal nulla: si nutre della tradizione che l’ha generata, dando origine a rapporti di ‘parentela’ vicina o lontana che trovano un’appropriata chiave euristica nella nozione di ‘somiglianza di famiglia’. Tale concetto, originariamente proposto da Ludwig Wittgenstein per i giochi linguistici (Wittgenstein [1953] 1995), è stato utilizzato da Władisław Tatarkiewicz per interpretare il dialogo che si instaura tra opere distanti nel tempo (Tatarkiewicz [1976] 1993, 64): la dialettica tra tradizione e innovazione costituisce il segno dell’arte contemporanea più significativa.
Il libro di Salvatore Settis raccoglie dieci ‘incursioni’ nell’arte contemporanea realizzate con lo sguardo dell’antichista che sa cogliere le stratificazioni culturali nella consapevolezza che “tra ‘antico’ e contemporaneo non c’è netta frattura, ma una perpetua tensione, che continuamente si riarticola nel fluire dei linguaggi critici e del gusto, nei meccanismi di mercato, nel funzionamento delle istituzioni, nella ‘cultura popolare’” (Incursioni, alla pagina 11).
Uno dei fil-rouge che attraversa gran parte delle incursioni di Settis è riconducibile alla dialettica straordinario-ordinario. L’arte è un evento che si colloca al di fuori della vita quotidiana: ci sono opere che esprimono i ‘valori cultuali’ legati al rito e alla dimensione del sacro, altre dense di ‘valori espositivi’ connessi agli spazi museali (gallerie, mostre, musei). In ogni caso sia gli uni sia gli altri valori conferiscono all’opera d’arte l’aura, cioè nei termini di Walter Benjamin (Benjamin [1955] 19983, 25), quella distanza metafisica che ce la fa apparire lontana per quanto possa essere a noi vicina. Nonostante questo l’arte è anche il prodotto di un fare in cui la materia viene plasmata dalle mani dell’artista e in cui il gesto ha una centralità assoluta. Pertanto l’arte non può essere circoscritta alla sola dimensione extra-ordinaria, ma va colta nella dialettica con la vita di tutti giorni perché è da questa dialettica che trae linfa vitale, inverando il senso dell’esistenza.
Non è possibile tracciare questo fil-rouge attraverso tutti i capitoli del libro, ma si proverà a metterlo in luce, in modo esemplificativo, attraverso due artisti: Giuseppe Penone (capitolo 7) e Bill Viola (capitolo 8). Nel primo l’arte si confronta con la natura, nel secondo con la tecnologia. Benché Penone e Viola siano molto distanti sul piano dei materiali e della tecnica, sono accomunati dalla ricerca del sacro che ogni opera d’arte cela e al contempo rivela.
Giuseppe Penone è uno scultore. Scolpisce alberi, dando avvio a processi di metamorfosi che richiamano Ovidio e Bernini. Ma Penone non conferisce al legno tratti antropomorfici; scavando dentro l’albero, nel corpo dell’albero, ne scopre i nodi, le trasformazioni avvenute nel corso degli anni; in tal modo Penone “scolpisce il tempo” (Incursioni, alla pagina 214). La dimensione temporale è al centro della ricerca di Penone e viene articolata nella tensione tra ordinario e straordinario che Settis mette in luce richiamando alcuni testi della cultura greco-latina. Nelle società antiche il legno era un materiale presente in tutti gli aspetti della vita quotidiana, come ci ricorda Plinio il Vecchio: “Con gli alberi solchiamo i mari, costruiamo le case, i templi e i mobili, ci nutriamo, fabbrichiamo le statue degli dèi” (Plinio, Hist. Nat. XVI, 184); ma gli Antichi erano consapevoli che le piante non sono prive di anima, e che nemmeno la più preziosa statua d’oro e d’avorio “suscita in noi maggior venerazione di un bosco sacro e del profondo silenzio che vi regna” (Plinio, Hist. Nat. XII, 3). E Pausania racconta la festa dei daidala che si ripeteva ogni sei anni in Beozia:
Gli abitanti di Platea si recano in una foresta di querce gigantesche, e vi gettano pezzi di carne cotta. Non appena un corvo prende nel becco un pezzo di carne e va a posarsi su una quercia, subito la tagliano e vi scolpiscono una statua, che chiamano ‘daidalon’.
Questo rituale, ripetuto per quattordici volte, dava origine a quattordici daidala destinati a essere arsi sull’altare sacrificale durante una festa a cui prendevano parte tutte le città della Beozia al fine di sancire con una cerimonia sacra la loro alleanza e il comune intento di propiziarsi la divinità.
Azione rituale è anche quella di Penone. L’artista non mira a creare oggetti e forme rappresentazionali ma si concentra sul gesto “che imprime sulla materia non tanto una forma predeterminata, ma una traccia performativa” (Incursioni, alla pagina 197). Potremmo interpretare il ‘fare’ di Penone come artification, nel senso che a questo termine conferisce l’etologa Ellen Dissanayake (Dissanayake 2014, 44). Con questa nozione la studiosa indica alcune predisposizioni comportamentali volte a ‘rendere speciale’ (making special) qualcosa, qualcuno o un’azione all’interno di una comunità che condivide gli stessi valori (Dissanayake 1992, 225). Tali comportamenti ‘artificati’, tipici delle cerimonie rituali, si servono di formule e simboli, volti ad attirare l’attenzione degli astanti per produrre effetti emotivi e cognitivi e creare affiliazione sociale. Il gesto di Penone, focalizzando l’attenzione dello spettatore sugli alberi, ce li mostra in modo nuovo, facendoci sentire parte di quell’armonia ecosistemica in cui ogni elemento, inorganico e organico, vegetale e animale, riveste un ruolo essenziale nel quadro della biodiversità.
La meraviglia suscitata dal gesto è il senso profondo dell’arte di Penone. È un’arte che non racconta miti o storie ma che mostra il perpetuo processo naturale sia quando ‘scolpisce il tempo’, scavando gli alberi e creando insoliti innesti di legno e bronzo o pietre (L’Albero delle vocali 1999-2000; Ombra del bronzo 2002; Tra scorza e scorza, 2003; Idee di pietra, 2003), sia quando plasma il ‘respiro’ (Soffio, 1978) per mostrare il soffio vitale del mondo. In questi gesti rituali, potremmo dire ‘artificati’, Penone ci rivela quanto straordinario sia ciò che consideriamo ordinario: la vita.
Considerato che per Benjamin la ‘decadenza dell’aura’ è prodotta dalla riproducibilità tecnica, nulla di meno ‘auratico’ potrebbe esserci della video-arte, la cui nascita presuppone la fotografia, il cinema, la televisione e da qui la cultura di massa. Tuttavia, con il sovvertimento dei linguaggi artistici tradizionali, avvenuto nella seconda metà del Novecento, nuovi mezzi espressivi, compresi quelli tecnologici e digitali (Rush 2005), hanno fatto ingresso nel mondo dell’arte. La video-arte ha così acquisito i ‘valori espositivi’ tipici delle opere contemplate negli spazi museali, ma difficilmente – si pensa – potrebbe possedere i ‘valori cultuali’ che secondo Benjamin sono collegati al rito. Questa supposizione viene smentita da Bill Viola che, trascendendo l’‘ordinarietà’ del mezzo, riesce a esprimere la dimensione del sacro al pari dei più grandi artisti rinascimentali a cui si ispira. Non è un caso che abbia esposto spesso le sue video-istallazioni nelle chiese: The Messenger (1996) nella cattedrale di Durham; Ocean Without a Shore (2008) nella chiesa di San Gallo a Venezia; The Greeting (1995) nella chiesa di San Michele a Carmignano accanto alla Visitazione del Pontormo (ca. 1528), di cui il video rappresenta una sorta di trasposizione in un nuovo medium. A differenza di queste istallazioni, mostrate in un luogo sacro solo temporaneamente, le due ‘pale’ Martyrs (2014) e Mary (2016), sono state commissionate per fiancheggiare l’altare maggiore della cattedrale di San Paolo, a Londra; pertanto hanno non solo un ‘valore espositivo’ ma anche un ‘valore d’uso’ – direbbe Benjamin – di tipo devozionale al pari delle pitture tradizionali.
Ordinario e straordinario si intrecciano continuamente nelle video-istallazioni di Viola, a volte attraversando i temi della sua riflessione, a volte le forme dei suoi mezzi espressivi. Ad esempio, Nantes Tryptych (1992) ripropone attraverso immagini di vita comune (una partoriente, una figura maschile fluttuante in un ambiente acquoreo, la sua stessa madre morente) un tema centrale dell’iconografia sacra (la nascita, una sorta di rinascita/resurrezione, la morte) proposto su tre grandi schermi che richiamano la tipologia del trittico. Allo stesso modo The Greeting (1995) rilegge la visitazione di Pontormo attraverso l’incontro di due amiche sullo sfondo di una scena urbana presumibilmente americana. Infine, Catherine’s Room (2001) mostra una stanza dove una donna compie semplici azioni routinarie: lavarsi faccia, fare esercizi di yoga, cucire, studiare, leggere, dormire. Però tali scene di vita quotidiana sono sublimate dalla cornice rappresentativa che, ancora una volta, attinge all’iconografia sacra. Il formato dei cinque piccoli schermi piatti, tutti delle stesse dimensioni e disposti in sequenza orizzontale, ricorda – come sottolinea Settis – le ‘predelle’, un genere della pittura religiosa che veniva posta ai piedi di pale d’altare o polittici, allo scopo di narrare alcuni episodi biografici della figura religiosa celebrata nella pala o polittico soprastante. Pur richiamandosi a una tavola di Andrea di Bartolo (ca. 1393-1398) dedicata a Santa Caterina da Siena, la video-installazione di Viola non racconta la vita di una Santa, ma i gesti rituali di una donna, colta nell’intimità della sua vita solitaria, riuscendo a esprimere attraverso la corporeità individuale una spiritualità universale. In tal modo Viola realizza una sorta di “sacralizzazione del quotidiano” ((Incursioni, alla pagina 246), un tema oggi ampiamente dibattuto secondo differenti prospettive estetiche (Formis 2010; Leddy 2012; Saito 2017).
Come per Penone anche per Viola il gesto è il fulcro dell’operazione artistica; o meglio il ritmo del gesto, poiché Viola utilizza la tecnica dello slow motion per rallentare il tempo. Così se Penone ‘scolpisce il tempo’, Viola lo ‘dipinge’, trasfigurando le azioni e le passioni quotidiane attraverso un registro sublime che riesce a cogliere lo straordinario nella vita di tutti i giorni.
Riferimenti bibliografici
- Benjamin 1955] 19983
W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica [ed. or.: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in Schriften, Frankfurt am Main, 1955], trad. it. E. Filippini, Torino 19983. - Dissanayake 1992
E. Dissanayake, Homo Aestheticus: Where Art Came From and Why, New York 1992. - Dissanayake 2014
E. Dissanayake, A Bona Fide Ethological View of Art: The Artification Hypothesis, in G. Apfelauer, J. Forster et al. (eds.), Art as Behaviour: An ethological approach to visual and verbal art, music and architecture, Oldenburg 2014, 43-62. - Formis 2010
B. Formis, Esthétique de la vie ordinaire, Paris 2010. - Leddy 2012
Th. Leddy, The Extraordinary in the Ordinary: The Aesthetics of Everyday Life, Peterborough (ON) 2012. - Rush 2005
M. Rush, New Media in Art, London 2005. - Saito 2017
Y. Saito, Aesthetics of the Familiar. Everyday Life and World-Making, Oxford 2017. - Tatarkiewicz [1976] 1993
W. Tatarkiewicz, Storia di sei idee [ed. or.: Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976], trad. it. a cura di K. Jaworska, postfazione di L. Russo, Palermo 1993. - Wittgenstein
L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche [ed. or.: Philosophical Investigations / Philosophische Untersuchungen, Oxford 1953], trad. it. M. Trinchero, Torino 1995.
Per citare questo articolo / To cite this article: E. Di Stefano, Incursioni dello straordinario nell'ordinario, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 292-297 | PDF
L’uso di una Pathosformel è sempre intenzionale? Non necessariamente, risponde Salvatore Settis a proposito del pittore espressionista Emil Nolde:
La memoria inconsapevole della tradizione artistica ha agito in lui in modo ancor più forte, ancor più penetrante. “Un irresistibile impulso”, appunto (Incursioni, alla pagina 352).
Tra le avanguardie storiche, l'espressionismo con la sua febbre emozionale appare la corrente artistica più attraversata dall’“irresistibile impulso” a ricreare temi e posture che, venendo da lontano, si impongono all'immaginazione. Gesti icastici, come nel Ritratto del dottor Gachet di Van Gogh o in uno dei tanti autoritratti di Egon Schiele, meritano di essere annoverati nel grande catalogo delle Malinconie di ogni tempo. Anche Munch, un altro dei più potenti precursori dell'espressionismo, dispiega nella sua pittura ardente un repertorio di remote formule espressive, fantasmi di un patrimonio visivo interiorizzato. La loro risonanza chiarisce in parte il loro forte impatto comunicativo.
Sono quasi coetanei Aby Warburg e il pittore norvegese Edward Munch, il primo nato nel 1866 e il secondo nel 1863. Ambedue vivono un Seelendrama e combattono per tutta la vita con le ombre della propria psiche. Nel tempo in cui il primo teorizza e individua le Pathosformeln e ne raccoglie le immagini per comporre il suo Atlante Mnemosyne, il secondo compone un insieme di opere che chiama Fregio della vita, dove la stessa forza espressiva dello stile semplificato, radicale e innovativo, pare basarsi con naturalezza su alcuni remoti modelli e indimenticate posture. Come quell'eterno gesto della mano che, appoggiata al mento e alla guancia, sorregge un volto assorto, caratterizzando attraverso i secoli il sentimento della Melanconia. E ben figurerebbe in coda all'atlante warburghiano la Melanconia di Munch del 1891 [Fig. 1]: nell’angolo della tela e in primo piano, un personaggio chiuso dentro i contorni di una massa scura, che esprime la sua introversione, è posto di fronte a un paesaggio di costa con l’atteggiamento meditativo consacrato dalla tradizione iconografica.

1 | E. Munch, Malinconia, 1891, olio su tela, coll. priv.
Le sfumature giallo-verdi del volto sono le medesime tinte solforose e tristi del crepuscolo luttuoso, come se quei colori e le linee ondulate della riva non fossero che l’emanazione di quell’uomo solitario, e perfino la coppia sul fondo non fosse che una visione evocata dal suo raccolto tormento. Se Munch poteva avere una limitata consuetudine con la tradizione classica, non ignorava di certo la celebre incisione di Dürer. Si ritiene che la figura dell'uomo malinconico nel paesaggio gli sia stata ispirata da un’acquaforte di Max Klinger, Sera (1889), artista a lui ben noto, che come scultore aveva una profonda conoscenza dell’arte antica.
Eppure, Munch aveva già utilizzato in precedenza il motivo in Notte a Saint-Cloud (1890): si tratta di un interno notturno, in fondo il profilo d'ombra di un uomo seduto davanti alla finestra, il cui braccio appoggiato al davanzale sorregge la testa evidenziata dal cappello a cilindro. Virato in azzurro, il dipinto è gravato da una tristezza autobiografica: in Francia, dove si è recato a studiare la pittura moderna, l’artista vive un periodo difficile e riceve la notizia della morte del padre. Nell'ombra malinconica alla finestra, come si evince dai suoi diari, rappresenta se stesso e contemporaneamente il padre “quando era seduto nell'angolo del canapè davanti alla finestra – nel fumo bluastro del tabacco”. La luna proietta nella stanza la doppia croce della finestra, ossessivo raddoppiamento di un simbolo di morte che chiude a tenaglia uno spazio dilatato dalla diagonale prospettica, ma soffocato dalle tende-sipario.

2 | Mummia peruviana, esposta nel 1889 a Parigi, Musée de l’Homme.
Tra l’uno e l'altro dipinto, Munch matura il suo peculiare linguaggio espressivo: se in Notte a Saint-Cloud fonde la “pittura in blu” del neoromanticismo nordico con il taglio e la struttura lineare di Degas e con il tratteggio cromatico di Monet (anche se la restituzione così sommaria della figura non ha precedenti nell’impressionismo), l’anno successivo in Malinconia mostra di avere individuato attraverso Van Gogh, Toulouse-Lautrec e Gauguin, il passaggio alla pittura dell'avvenire, la sua, dove solo la necessità espressiva è regola di verità. Ma, ambedue le opere, così come l’intero Fregio della vita, si fondano sull’intenzione esplicita di trasformare le proprie esperienze personali in intuizioni figurative di valore universale. Lo strumento, consapevole o meno, di questa trasformazione è la Pathosformel.
Sotto la spinta della propria eccedenza emotiva, crea ne Il grido del 1893 una indimenticabile “formula di pathos” moderna, vera icona dell’angoscia, male oscuro che nel Novecento diventerà una sorta di malattia sociale. Né uomo, né donna, quella creatura, che urla e contemporaneamente si tappa le orecchie con le due mani per non sentire, è semplicemente l’umano ridotto alla sua essenza, al suo destino di morte già inscritto nell’atto della nascita. Il panico contrae e stravolge le linee ritmiche e ondulate dell’Art Nouveau in tentacoli sinistri, rendendo allucinate e implosive le sonorità cromatiche dei simbolisti, mentre il duro impatto diagonale del parapetto appare proiettato addosso allo spettatore. Ma la potenza espressiva del dipinto risiede sopratutto in quel gesto inedito di difesa dalla pressione di un sentire insostenibile.
Robert Rosenblum ne ha suggerito un possibile modello in una macabra mummia peruviana con le mani raccolte attorno al teschio, esposta nel 1889 all’Esposizione Universale a Parigi (Rosenblum 1978, 7-8; [Fig. 2]), che aveva già ispirato Gauguin in alcuni disegni e nel dipinto La vie et la mort del 1889 (Eggum 1991, 147).
È probabile che Munch, durante il suo soggiorno francese abbia visto l’una e l’altro. Ma quel gesto straziante ed eloquente, l'artista in realtà se lo porta dentro da sempre, come una sigla della propria infanzia. È infatti il gesto della sorella bambina che, davanti al letto di morte della madre, si tappa istintivamente le orecchie perché ci sono silenzi che possono ferire l'udito più di qualsiasi rumore, un gesto disperato che in un dipinto del suo ciclo autobiografico, La madre morta e la bambina (1897-1899), Munch restituisce alla cronaca familiare [Figg. 3-4].
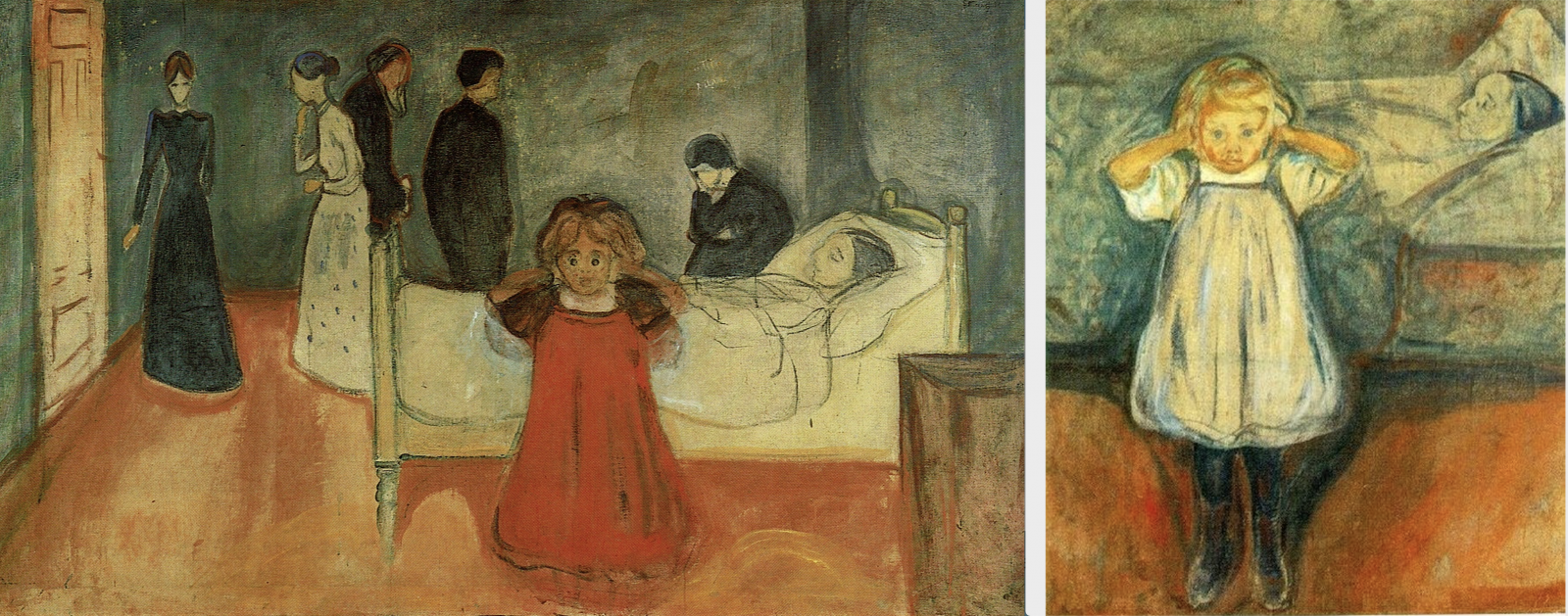
3 | E. Munch, La madre morta e la bambina, 1897-1899, olio su tela, Oslo, Munch Museet.
4 | E. Munch, La morte e la bambina, 1899, olio su tela, Brema, Kunsthalle.
Lo stesso anno della prima versione de Il grido, in un’opera il cui titolo, La tempesta (1893), appare semanticamente ambiguo, riferibile indifferentemente al tumulto dell'anima e allo sconvolgimento atmosferico, quel gesto diventa corale: un gruppo di donne davanti a una casa illuminata si comprime le orecchie per difendersi dal rumore del vento notturno o della psiche agitata. Dal gruppo si distacca, avanzando verso il centro del quadro, una donna vestita di bianco, nella quale avvertiamo un fantasma dell’ansia [Fig. 5].

5 | E. Munch, La tempesta, 1893, olio su tela, New York, Museum of Modern Art.
La dama in bianco, più spesso in figura di fanciulla, memore dei preraffaelliti e dei verginali cortei di Burne-Jones, è un soggetto ricorrente nella pittura e letteratura simbolista (si pensi a La principessa bianca di Rilke), e può essere interpretata semplicemente come un casto antidoto contro l’altrettanto ricorrente stereotipo fine secolo della femme fatale. Ma, la pittura di Munch, dove la fanciulla in bianco è un'apparizione ricorrente, ci dà la chiave della complessità di questa immagine, che riemerge da un passato antico. In innumerevoli dipinti, una giovane donna vestita di bianco guarda il mare, sola o dando le spalle alla figura maschile da cui è irrimediabilmente separata. Come la “principessa bianca” di Rilke e la Ellida di Ibsen rappresenta una figura dell’inaccessibilità e dell’attesa. Furio Jesi, che ha identificato nella letteratura tedesca tra Otto e Novecento la presenza ossessiva del mito di Kore, legge in quest’ottica anche il testo di Rilke (Jesi [1967] 1995, 69), e potremmo riconoscere la stessa emergenza mitica, consapevole o meno, nella pittura di Munch. Un’ipotesi confortata anche dalla sua personale formulazione di un tema frequente nell'arte simbolista: la trilogia del femminile, debitrice di temi iconografici tradizionali come il giudizio di Paride, o le tre età della donna o ancora le tre grazie (Hofmann 1986, 283-301). Del dipinto La donna in tre fasi esistono due versioni (1893, 1894) e numerose varianti grafiche: un paesaggio psichico (la medesima linea sinuosa della riva di Malinconia) abitato dalla fanciulla in bianco che guarda verso il mare, da una donna nuda al centro che offre se stessa sfrontatamente, e da una terza in nero come uno spettro nell'ombra. Un personaggio maschile che arretra, ingabbiato tra gli alberi, sarà espunto dalle successive versioni grafiche [Fig. 6].
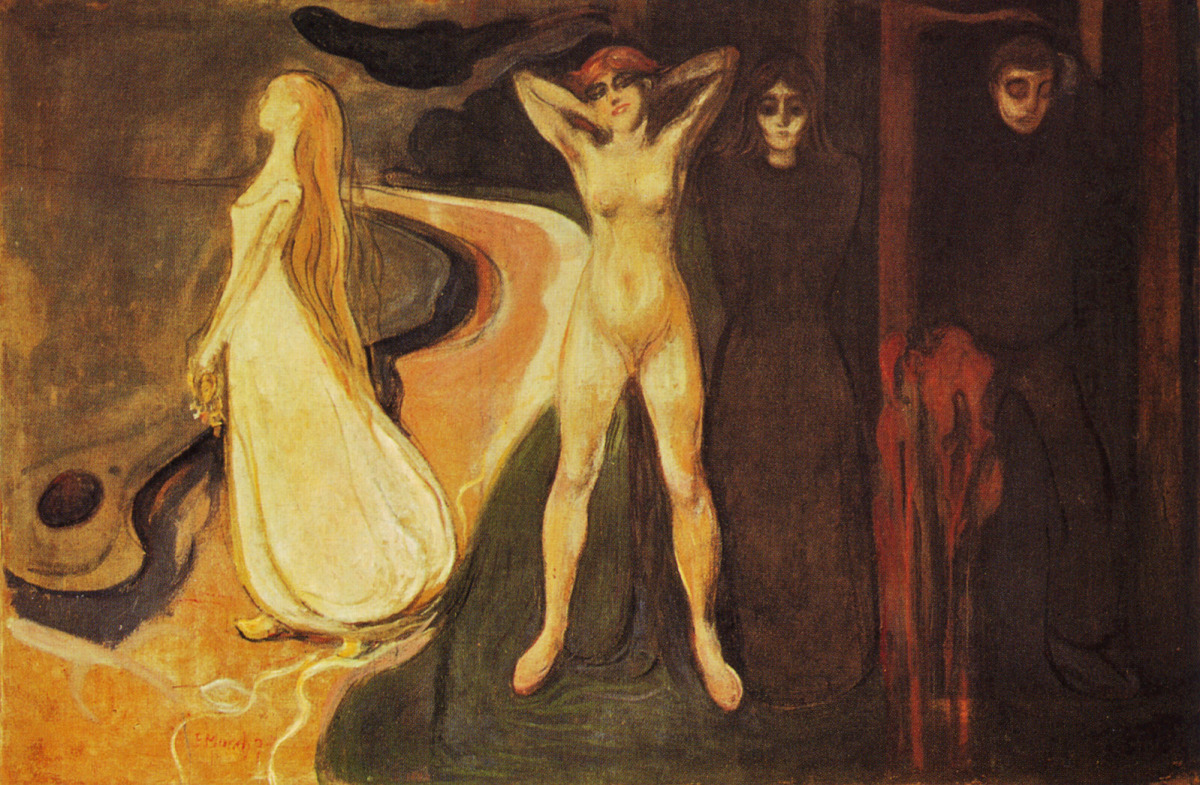
6 | E. Munch, La donna in tre fasi, 1894, olio su tela, Bergen, Rasmus Meyer Collection.
Presentando l'esposizione del dipinto a Parigi nel 1896, lo scrittore August Strindberg identifica nelle tre figure le personificazioni demoniache della lussuria femminile: “l’amante, la furia, la peccatrice”. Le interpretazioni sono le più varie, ma concordano nell’evidenza che il dipinto metta in scena un conflitto tra le seduzioni della vita e della morte: è uno spazio teatrale che presenta i personaggi del dramma, ciascuno caratterizzato dal linguaggio del corpo, come la figura centrale dalle braccia incrociate dietro la testa, il gesto di una Afrodite impudica che offre la sua nudità come una meretrice. Ma, il vero centro emozionale a me appare invece spostato a sinistra nella luce, dove l'evanescente fanciulla in bianco, figurativamente stilizzata in una forma fluttuante, dà le spalle alle altre e all’oscurità del bosco, guardando lontano. Nella sua giovinezza porta le insegne della vita e della morte (in quei fiori volti in basso, in quel fluttuare senza poggiare davvero, in quel volgersi verso l'altrove), è un sogno di morte allo stesso modo del suo alter ego in nero, un sogno funesto che svela il senso ultimo dell'offerta erotica della figura centrale. Come la mitica Kore, la figura in bianco sta sul limite, è contemporaneamente viva e morta, vergine e violata, donna della primavera e regina degli inferi e della morte [Figg. 7-8].
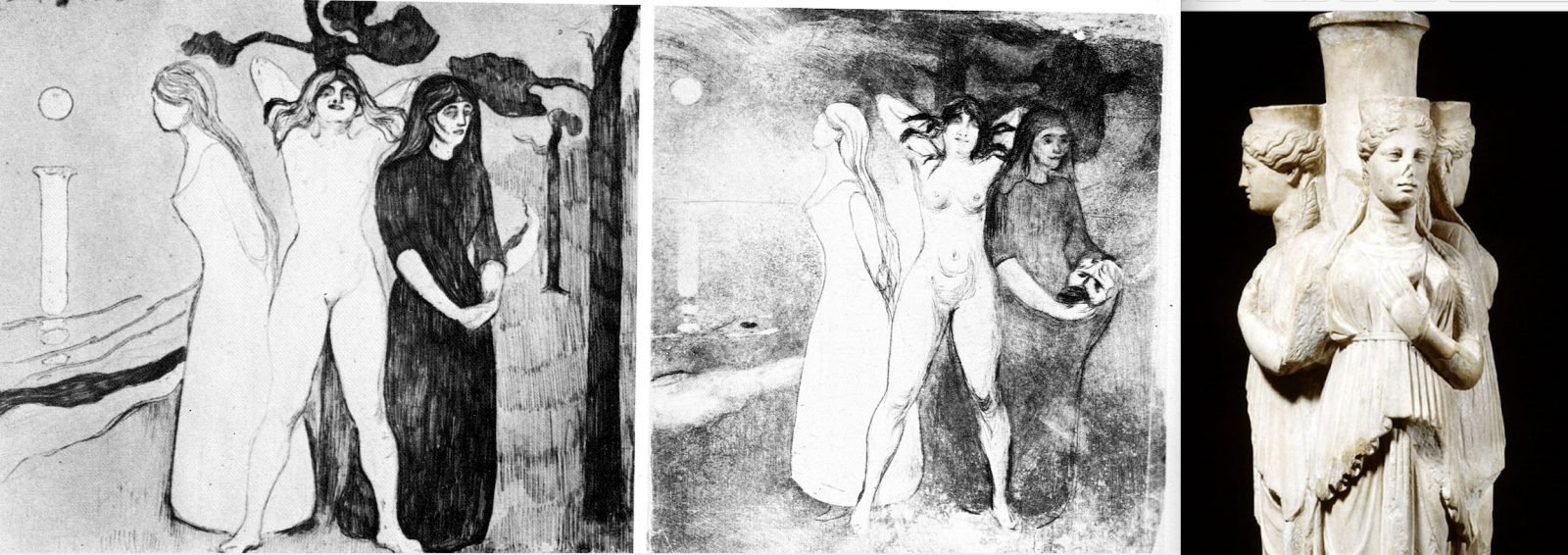
7 | E. Munch, Due varianti dell’incisione La donna, 1895, puntasecca e acquatinte, Oslo, Munch Museet.
8 | Hekate triformis, 50-100 d.C. (ispirata alla scultura di Alkamenes per l’Acropoli di Atene, 430-420 a. C.), Leida, Museo Nazionale-
In altra sede ho approfondito la lettura del dipinto (Di Stefano 1999), qui propongo all'attenzione un’incisione successiva, del 1895, che riprende il soggetto con alcune varianti e dove la presenza sottesa del mitologema risulta più evidente [Fig. 9].

9 | E. Munch, Fiore avvelenato che introduce la serie Alpha Omega, litografia, 1908, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, inv. 304.
Eliminata la figura maschile, le tre donne stanno addossate a un tronco, manifestando la loro sostanziale identità. Inoltre, la mortifera figura in nero tiene in mano una testa o una maschera d’uomo. Nell’Antichità tre donne addossate a una colonna rappresentavano la triplice Ecate, la dea della notte e della luna che è anche la dama nera inseparabile compagna di Persefone negli inferi. Una formula visiva, “un’immagine insepolta” secondo la nota definizione di Didi-Huberman, che sopravvive nella memoria emotiva moderna e torna, come registra Jung, nei sogni dove Kore appare nelle vesti di una fanciulla sconosciuta e inaccessibile, con cui si desidera e si teme il contatto, e il cui atteggiamento oscilla tra i due estremi della dea e della prostituta (Jung in Jung, Kerényi [1941] 1972, 223-248). Dal punto di vista psicologico, continua lo psicoanalista svizzero, la triplice figura è un archetipo dell'anima in cui l'inconscio maschile proietta la propria dimensione emozionale.
Alcuni anni dopo, Munch ritorna ancora una volta sul tema della triade femminile, riducendola alla sua essenza: solo i tre volti a formare la corolla di un fiore emblematico, che l’artista definisce “avvelenato”, e che per analogia a posteriori ci richiama il saggio su Kore di Kerényi, dove il grande studioso del mito sostiene che le figure mitologiche si presentano come condensazioni di significato “chiuso come un bocciolo di fiore”, che ha “la capacità di svilupparsi e d’altra parte di racchiudere e formare in sé un cosmo particolare” (Kerényi in Jung, Kerényi [1941] 1972, 158).
Nello spirito dell’Atlante warburghiano, non si tratta qui di dimostrare le influenze dell’antico, ma di individuare/immaginare un viaggio erratico, regolato dall'inconscio, dove alcune figure sopravvivono sotto mutate spoglie. Dunque, nonostante il rapporto di Munch con le fonti antiche sia molto probabilmente indiretto, la fanciulla in bianco potrebbe rappresentare una moderna (e secolarizzata) condensazione epifanica del mito. Giunge fino a noi attraverso percorsi misteriosi e mille travestimenti, ereditata senza saperlo, sopravvissuta in clandestinità, forse soltanto oscuramente sognata, fino a quando “un irresistibile impulso” non l'ha fatta riemergere dal giacimento culturale e psichico dell'occidente.
Riferimenti bibliografici
- Didi-Huberman [2000] 2006
G. Didi-Huberman, L'immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte [ed. or. L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris 2000], Torino 2006. - Di Stefano 1999
E. Di Stefano, Donne in bianco e nero. Digressioni intorno a un dipinto di Munch, in Cantami o Diva. I percorsi del femminile nell'immaginario fine secolo, a cura di S. Sinisi, Cava de' Tirreni 1999, 97-108. - Eggum 1991-1992
A. Eggum, Munch et la France, Exposition Paris, Musée d'Orsay 28 septembre 1991-5 janvier 1992; Catalogues d’exposition Collectif, Arne Eggum, Rodolphe Rapetti, direction Réunion des musées nationaux, Paris 1991. - Hofmann 1986
W. Hofmann, Eva und die Zukunft, München 1986. - Jesi [1967] 1995
F. Jesi, Germania segreta. Miti nella cultura tedesca del Novecento, [I edizione Milano 1967], Milano 1995 - Jung, Kerényi [1941] 1972
C.G. Jung, K. Kerényi, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia [ed. or. Einführung in das Wesen der Mythologie: Gottkindmythos, eleusinischen Mysterien, Amsterdam 1941], trad. it. A. Brelich, Torino 1972 - Rosenblum 1978
R. Rosenblum, Edward Munch: Some Changing Contexts, in Munch. Symbols & Images, mostra Washington, National Gallery November 11, 1978 – March 4, 1979; catalogo Washington 1978, 1-9.
Per citare questo articolo / To cite this article: E. Di Stefano, Un "irresistibile impulso": Munch e la Pathosformel, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 298-306 | PDF
incursióne s. f. dal lat. incursio -onis, der. di incurrĕre ‘correre contro’.
Così il Vocabolario Treccani, ma qui vorrei, enfatizzando e travisando l’in-, intendere l’incursione come un correre incontro, in particolare un correre insieme incontro al senso del passato non trascorso, della memoria, della tradizione concepita anche come segno di infedeltà, di inversione, di eventuali fraintendimenti nonché di persistenze che costellano il complesso rapporto tra contemporaneo e antico squadernato nello spettacolare libro di Settis. Tra le riflessioni rese possibili da Incursioni mi limiterò a una rapida (non potrebbe essere altrimenti, la rapidità è propria dell’incursione, che è anche un atto di rapina, di pirateria: appropriarsi di idee altrui per usarle in proprio) incursione relativa a Bill Viola, perché le sue opere, come del resto quelle assai differenti di William Kentridge, mi pare esprimano esemplarmente quella “nobiltà della memoria” a suo tempo evocata da Maurice Merleau-Ponty:
Husserl ha adoperato la bella parola Stiftung – fondazione – per indicare l’illimitata fecondità di ogni presente che, proprio perché è singolare e passa, non potrà mai cessare di essere stato e quindi di essere universalmente – ma soprattutto quella dei prodotti della cultura che continuano a valere dopo la loro apparizione e aprono un campo di ricerche che vivono perpetuamente. Così, il mondo dacché è stato visto dal pittore – i suoi primi tentativi artistici e tutto il passato della pittura affidano al pittore stesso una tradizione, ossia, commenta Husserl, il potere di dimenticare le origini e di dare al passato non già una sopravvivenza, che è una forma ipocrita dell’oblio, ma una nuova vita, che è la forma nobile della memoria (la forme noble de la mémoire) (Merleau-Ponty 2003, 86).
“Bill Viola – scrive Settis – è a ogni effetto un pittore […] dipinge con le tecniche video” (Incursioni, alla pagina 240). Queste tecniche implicano il movimento dell’immagine e ci permettono di intendere la pittura quale arte del movimento (al punto di produrre “una rimeditazione spontanea, preziosa perché nient’affatto libresca, sul problema del movimento nel primo Rinascimento italiano” (Incursioni, alla pagina 261). Ora il movimento, nella video-arte di Viola, implica una riflessione sul tempo, almeno se il tratto distintivo delle operazioni di Viola sia, come a me pare, il rapporto tra movimento quale espressione di un senso del tempo e pathos, paticità fondamentale dell’umano. Si tratta allora di riflettere su quale sia la qualità del tempo pensata dall’arte di Bill Viola, poiché ‘tempo’ si dice in molti modi. Per introdurre la questione può essere utile una digressione. Credo che la nostra forma d’epoca produca in modo potente e pervasivo una superficializzazione dell’esperienza del tempo nella direzione di un’astrazione distintiva: il plesso spazio-temporale viene enucleato non come complesso realmente indistricabile ma come regime confusivo in cui il tempo si piega sullo spazio producendo una indefinita polarizzazione del desiderio. Il sentimento contemporaneo del tempo, almeno nell’Occidente/Oriente ipertecnologico, sembra caratterizzato da un eccesso di precarietà, da uno smarrimento tra l’assenza della memoria e la fragilità del progetto sul quale si affermano formattazioni potenti dell’esperienza del mondo attraverso agenzie che donano un’effimera stabilità. Influenzata dalle modalità con cui i dispositivi identificano e strutturano abitudini personali e collettive, permettono forme di socialità e ultimamente costruiscono sfondi epocali, la nostra identità psicologica e sociale dipende da un insieme di prassi collettive di indirizzo e controllo in continuo e rapido mutamento.
Ora se l’identità personale e collettiva si costituisce almeno parzialmente come stabilità della relazione temporale con il mondo, allora l’identità possibile per l’epoca è fluttuante, e perciò ancora più pervasivi e persuasivi sono i linguaggi che tendono a stabilizzarla, seppure in modo effimero, elaborando una relazione almeno provvisoriamente sensata tra sé sociale e mondo. Perciò nell’epoca della disarticolazione temporale dell’esistenza, l’accesso pubblicitario al sistema delle merci e il linguaggio dei consumi acquistano rilievo notevole per la costituzione dell’identità poiché creano micronarrazioni del sé, apparecchiano la frammentazione in un ritmo sufficientemente armonico da poter essere apprezzato, svolgono la novità degli eventi secondo brevi costanze interessanti. La moda, speculativamente, è allora in sintesi la forma del tempo contemporaneo, un modo di dar forma all’identità per mezzo del tempo: sfrutta la contrazione della durata e la frammentazione della costanza narrativa tipica della forma deformata dell’epoca, ma non consente una completa destrutturazione del sé, lavora sulle piccole stabilità; è una rilevante strategia attraverso cui la frammentazione viene dominata e ricondotta all’ordine: configura pratiche, comportamenti, abiti della vita, genera, nella produzione di una serie temporale, non un doloroso e reiterato senso di frustrazione, bensì forme di godimento immaginativo che rendono in qualche modo il consumatore, cioè noi, custode di un desiderio senza fine che è forma del tempo presente, sua incisione patica o inquietudine. Allora l’arte contemporanea è tanto interessante quanto oltrepassa tutto ciò facendosene consapevolmente carico. Da questo punto di vista essa non è antidoto, non è farmaco (non ha questo diabolico potere per fortuna), e non produce alcuna consolazione; non è propriamente nemmeno via di uscita rispetto alla forma attuale della temporalità. È però un evento del tempo che dice un’esperienza possibile del tempo che non sta in questo nostro tempo.
Si dà a questo proposito un rapporto tra una tipica arte del tempo, il cinema quale arte dell’immagine-tempo, e una forma della video-arte contemporanea che esplicitamente assume il tempo come proprio oggetto. Ora l’esperienza del tempo attesta, a livello trascendentale, il divenire come annullamento: si tratta di un’esperienza comune, che talvolta, in relazione alla sua determinazione, accade così acuta nella sua irrimediabilità; ora questa esperienza nel cinema è precisamente formalizzata, al punto da fare del cinema lo specchio della vita: nel cinema si dà lo scomparire continuo e irrimediabile dell’immagine, e in tale inabissarsi della singolarità dell’immagine nel nulla si dà il senso del divenire stesso. Appare non il nulla, ma l’annullamento, il margine che tiene essere e nulla legati alla storicità contingente della narrazione. L’immagine cinematografica perennemente trapassa, appartiene sempre al passato, non sta, e nel cinema si vede bene il significato ontologico di questo non stare; ma si tratta di un essere del passato produttivo: mostra la forza e la forma del tempo, la fluidità dell’essere e quella metamorfosi incessante che è il reale.
Dall’esorcismo di questa potenza distruttiva del tempo, emerge quell’idea di immagine-tempo che Deleuze traeva dalle profondità del tempo bergsoniano, l’immagine cinematografica come immagine-cristallo:
Ciò che costituisce l’immagine-cristallo è l’operazione fondamentale del tempo: dato che il passato non si forma dopo il presente che esso è stato, ma contemporaneamente, il tempo deve in ogni istante sdoppiarsi in presente e passato […] Il tempo deve scindersi mentre si pone o si svolge: si scinde in due getti asimmetrici uno dei quali fa passare tutto il presente e l’altro conserva tutto il passato. Il tempo consiste in questa scissione, è essa, esso che si vede nel cristallo (Deleuze [1985] 1989, 96).
Nel cinema l’immagine si mostra sempre nel suo cadere, si mostra in quanto e poiché va nel nulla, ma di rimbalzo ordina in qualche modo il caos, se è vero che il montaggio è consustanziale all’essere stesso del cinema. Eppure è proprio attraverso l’assolutizzarsi del montaggio che nel passaggio dall’analogico al digitale, nel cinema si dissolve, o tende a dissolversi, la profondità del tempo:
L’immagine, costituita tramite l’acquisizione digitale o tramite la sintesi, è sempre un “montaggio”, nel senso di una singola combinazione di elementi discreti […]. Dato che l’unità spaziale dell’immagine nel tempo non può essere accertata o attestata dall’immagine digitale poiché le forze dell’indessicalità vengono indebolite e decentrate dal processo di conversione digitale, l’espressione della durata viene trasformata […]. Nel cinema digitale non cerchiamo più di vincere la nostra alienazione temporale dal passato, per prima cosa perché la catena causale dell’analogia si è spezzata e in secondo luogo perché lo schermo elettronico esprime un’altra ontologia (Rodowick [2007] 2008, 184).
Questa “altra” ontologia è ancora in gran parte da pensare, e sarà da pensare approfondendo l’idea di virtuale a essa sottesa, eppure è chiaro che le tecnologie digitali sono riserve potenziali enormi per l’immagine-tempo elettronica di cui si serve la video-arte. Ora Bill Viola, lavora per lo più rielaborando l’analogico attraverso processi di digitalizzazione per ottenere effetti di dilatazione temporale dell’immagine:
Il ralenti applicato a brevissime sequenze di girato produce un senso di dilatazione del tempo fino alla stasi fluttuante delle immagini […] siamo ora introdotti nel regno di figure gonfie di tempo, che guadagnano la relativa stabilità di una scena proprio grazie alla saturazione della dimensione temporale. Non si tratta dunque tanto di immagini in movimento, quanto di immagini che custodiscono il tempo al loro interno e, così facendo, svelano la loro profondità, la loro densità e guadagnano al tempo stesso sussistenza spaziale (Vizzardelli 2010, 129).
In opere quali per esempio The Greeting, The Quintet of the Silent o Tempest, Viola produce nell’osservatore un’esperienza emotiva intensa del tempo, soprattutto delle passioni come espressioni temporali, elaborando una tipica esperienza auratica contemporanea, che ancora una volta dice come il depauperamento dell’aura non sia ontologicamente connesso alla riproducibilità tecnica, ma sia sintomale, legato alle abitudini estetiche dell’epoca e ai processi di massificazione dell’esperienza estetica, in specie dell’esperienza diffusa e frammentata della temporalità.
Rallentamento e inversione: è come se procedendo verso l’immobilità dell’istante il tempo non si fermasse bensì si dilatasse, come se la durata giungesse ad abitare l’istante; lo stare nella durata a cui viene invitato l’osservatore, consente di giungere in prossimità dell’istante, quel punto impossibile dell’attimo antitetico alla spazializzazione del tempo tipica del contemporaneo, in cui il pathos può dispiegarsi nella sua intensità; la pietà, la malinconia, le figure del dolore, legate al trascorrere percepito come tale: il senso del passare nell’attenzione a ciò che rallenta e quasi si ferma, la quasi-sospensione, il quasi-nulla del movimento che prende tempo. E insieme, come soprattutto mostrano opere quali Inverted Birth, Earth Martyr o Tristan’s Ascension, Viola conduce l’ontologia tragica del tempo cinematografico, astratta come tale da qualsiasi contenuto, in una possibilità di esperienza drammatica del tempo tesa verso una catarsi almeno potenziale. La ricerca evidente di indessicalità nel divenire implica allora l’apertura a una dimensione narrativa che produce dall’interno del tempo, dal lavoro del tempo, una fragile normalizzazione del caos: un caosmos, che è resistenza nonostante, matrice di senso nel rispetto profondo del divenire inarrestabile.
Riferimenti bibliografici
- Deleuze [1985] 1989
G. Deleuze, L’immagine-tempo [ed. or.: Cinéma 2. L’image-temps, 1985], trad. it. L. Rampello, Roma 1989. - Merleau-Ponty [1952] 2003
M. Merleau-Ponty, Il linguaggio indiretto e le voci del silenzio [1952], [ed. or.: Le langage indirect et ‘Les Voix du silence’, “Le Temps Modernes” 80 (1952), 2117-2144; 81 (1952), 70-94], trad. it. in Segni, a cura di A. Bonomi, Milano 2003. - Rodowick [2007] 2008
D.N. Rodowick (2008), Il cinema nell’era virtuale [ed. or.: The Virtual Life of Film, 2007], a cura di A. D’Aloia e R. Busnelli Milano. - Vizzardelli 2010
S. Vizzardelli, Verso una nuova estetica. Categorie in movimento, Milano 2010.
Per citare questo articolo / To cite this article: R. Diodato, Un'incursione, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 307-312 | PDF
Cambiare il paradigma
Le emergenze impongono la necessità di trovare una soluzione e una riflessione sulle cause per poter formulare ipotesi progettuali. La condizione nella quale si trova la cultura nel pieno trauma della pandemia, offre l’opportunità di una domanda sulle possibilità della sua produzione e fruizione. L’unica risposta fornita dai governi, ma in modo più radicale in Italia, è stata quella della chiusura di ogni attività culturale, dalla didattica, alla formazione, alla fruizione. Il paradosso si rileva nella contestuale inarrestabilità delle pratiche sociali che, seppur con qualche limite, continuano a manifestarsi nella modalità delle aggregazioni, della folla, dei percorsi nella disfunzione della mobilità pubblica. La pandemia quindi, causata da un evidente cortocircuito ambientale, ha rilevato l’insostenibilità del paradigma distopico della ipermodernità fondato sul ciclo-produzione-consumo-profitto a livello globale. Nella modernità occidentale la cultura ha bisogno di giustificare la propria esistenza, ormai separata dall’esistenza integrale nell’oikos e nella polis.
La cultura nella modernità si declina nel paradigma della società di massa dove il concetto di Volk, nella accezione di popolo, si traduce in quella moderna di pubblico, in quella contemporanea di audience e, oggi, con il predominio dei social media, di followers. Rimane tuttavia invariato il modello di totalità della forma spettacolare, in una accezione di alienazione, nella quale la cultura si declina in termini di consumo. La cultura si declina nella logica dello spettacolo come funzione del consumo e del marketing, prevalentemente di immagine. Il paradigma del ‘consumo culturale’ si è consolidato come luogo comune del discorso sulla cultura, fino alla radicalizzazione della funzione di ‘giacimento’. Gli anni ’80 del secolo scorso hanno fondato sul concetto di ‘giacimento culturale’ il paradigma giustificativo della funzione culturale nella società come una delle possibili diversificazioni del consumo commerciale. Arte, musica, teatro, letteratura, museo, si declinano come funzioni del mercato e, appunto, del consumo di una forma di produzione, nella specifica accezione di utilizzazione del ‘tempo libero’ come alienazione. Le istituzioni culturali, dai musei alla stessa formazione, partecipano di questo processo omologante della produzione di forme di conoscenza, di riflessione, di capacità critica, di interrogativo e di interrogazione sul presente, sull’esistente e sulle relazioni. L’impiego delle tecnologie digitali negli anni ’70 aveva una funzione di esplorazione di possibilità percettive e produttive di senso. Le avanguardie artistiche impegnate in questa direzione trovavano anche un interessante riscontro nelle sedi istituzionali, negli Stati Uniti come in Europa, con interessanti risultati nella ricerca di nuove possibilità esplorative e di integrazione fra corpo e macchina, fra dimensione corporea e dimensione virtuale. Nel giro di pochi anni il processo di omologazione della cultura alle modalità produttive del mercato è stato così radicale e globale da delegittimare di fatto quella nozione di avanguardia che il Novecento aveva registrato come fenomeno di rilevanza di senso. Riscontriamo adesso quanto sia importante la relazione fisica, la presenza, quella relazione fra occhio e corpo-materia che crea sguardi. Nella condizione imposta dalla pandemia il paradigma del ‘consumo culturale’ si è rovesciato. Da un modello sociale fondato su un vertiginoso ed esponenziale consumo di massa – in termini di quantitativi di biglietti venduti considerato come unico parametro di rilevanza e di valore – al paradigma opposto, in senso radicalmente riduttivo, della chiusura totale con il conseguente azzeramento di ogni possibilità di introito. In questa logica si è rovesciato anche il paradigma su cui è stata fondata la politica dei beni culturali nell’ultimo decennio, quello dell’apporto salvifico del privato. Le istituzioni si sono dovute rivolgere piuttosto alle tradizionali e scontate soluzioni pubbliche. Il cortocircuito pandemico ha costretto il privato a dirottare le risorse verso urgenze più cogenti rispetto a quelle del mecenatismo. Alla improvvisa sparizione di ogni pratica di fruizione e di produzione della cultura, subentra un convincimento diffuso della possibilità di sostituzione con pratiche virtuali fortemente modellate sullo stesso paradigma di consumo, declinate sul piano globale, in un processo di omologazione tanto radicale quanto veloce. Della cultura si perde il senso della produzione, delle prassi, come interrogativo e conoscenza. Può una processualità basata su algoritmi sostituire la processualità originaria dalla metis del corpo tipica della funzione artistica? Può uno ‘specchio nero’ bidimensionale sostituire l’operatività artistica che nasce dall’esperienza progettuale del corpo? Porre questo interrogativo può aiutare a ripensare la funzione artistica nella modernità.
Va in sostanza ripensato l’intero rapporto fra tecnologia e produzione culturale come relazione di senso. Il problema della tecnica sembra essersi ridotto a una conoscenza funzionale alla soluzione di problemi posti dalla stessa tecnica. Il paradigma della produzione culturale della tecnologia sembra fortemente omologato alle processualità linguistiche e comportamentali globali e totalizzanti, nonché fortemente modellizzanti, degli schematismi tecnologici. L’artista scienziato rinascimentale operava unitariamente fra arte tecnica e scienza in un processo di tipo conoscitivo e creativo. Così come l’artista della modernità del Novecento è stato capace di interagire fra immagine meccanica ottica, cinema e fotografia, e immagine digitale, verso possibilità inedite, all’insegna di una sintesi di linguaggi capaci di riconfigurare il sentire e di aprire inedite possibilità espressive. Le operatività delle poetiche erano comunque fortemente radicate nei percorsi del pensiero e delle estetiche del contemporaneo. Una ricognizione sulle poetiche e sulle teoriche del cinema, della fotografia, delle arti visive e dei linguaggi tecnologici, offre una vasta possibilità di aperture di sguardi. Il tempo presente è piuttosto caratterizzato da una carestia estetica e da una povertà poetica a favore di una concentrazione di effetti sensazionali giocati sulla tecnologia di intrattenimento, fortemente alienanti.
‘Incursioni’ per attivare lo sguardo
L’ultimo volume pubblicato da Salvatore Settis Incursioni. Arte contemporanea e tradizione costituisce una occasione per riflettere sulla produzione e soprattutto sulla fruizione di alcuni percorsi culturali (non solo riferiti alle arti visive) capaci ancora di esprimere una rilevanza, di ‘dare da pensare’, di offrire cioè pensiero nel loro partecipare a un processo di senso nella comunità. Ci chiediamo se, nelle attuali condizioni di chiusura dei teatri e dei musei, nella sostituzione del pubblico del teatro con sagome o palloncini, o con puntini luminosi nello schermo, se nelle piattaforme virtuali della didattica a distanza (distanza dalla didattica), se nelle immagini da remoto Antonin Artaud avrebbe potuto immaginare Il teatro e Il suo doppio, lo sguardo su Van Gogh, il Teatro e la peste (grande profezia!); se Bertolt Brecht il suo "effetto di straniamento”, Pirandello quei sei personaggi che, fra il pubblico inferocito del Teatro Valle di Roma, reclamavano il loro autore. Ci chiediamo se i “tour virtuali dei musei” nella loro noiosa e stanca ripetitività e unidirezionalità, nella loro povertà di sguardo, nella loro impossibilità di generare visioni, fortemente omologate al turismo occasionale, possano mai produrre lo stesso effetto della Veduta di Delft su Bergotte nella narrazione di Proust. Difficilmente un tour virtuale potrebbe provocare una sindrome di Stendhal. Come la mettiamo poi con i Concetti Spaziali di Fontana, con il Vuoto di Yves Klein, con la Base del mondo di Manzoni? Che ne sarebbe delle performance e degli happenings degli anni ’70? E, ancora, negli anni più recenti, della ricerca sperimentale sulle nuove tecnologie digitali operate da Nam June Paik, dai Wasulka, fino a Studio Azzurro e a quella meravigliosa esperienza del teatro e dell’arte che, interrogandosi sulle nuove tecnologie elettroniche e digitali, reagiva creativamente alla omologazione della televisione.
Nel complesso percorso della modernità abbiamo una certezza, la consapevolezza che le sperimentazioni dei linguaggi artistici siano state caratterizzate dalla relazione fra linguaggi e pratiche, nella consapevolezza di un ruolo evolutivo della funzione artistica, riconoscendo all’arte la capacità di riconfigurare il presente come ‘possibile’, dunque modificabile. La dimensione utopica delle avanguardie si caratterizza come tensione verso un possibile, come ‘differenza’ rispetto al presente, come riconfigurazione di sguardo. In questo senso il contemporaneo non coincide automaticamente con l’attuale. Se il contemporaneo è la capacità di misurarsi con il proprio tempo in una tensione critica, l’attuale è mera compresenza cronologica, adesione al proprio tempo, semplificazione non conflittuale. Caratteristica della processualità artistica è la possibilità di trasformazione, di riprogettazione, di ricombinazione, dell’esistente verso un altro che prima di essere forma è sguardo. Di questo processo ne è partecipe il pubblico, lo spettatore che, nella fruizione artistica, ripercorre quel processo che riconduce alle pratiche e alle strategie originali e creative dell’artista. Le ‘Incursioni’ di Settis si articolano in dieci motivi fortemente radicati nel paradigma del confronto fra contemporaneo e tradizione nel rigoroso e produttivo sguardo sul Futuro del classico che caratterizza il metodo analitico del teorico (Settis 2004). Marcel Duchamp, Renato Guttuso, Ingmar Bergman, Mimmo Jodice, Tullio Pericoli, le icone sovietiche, Giuseppe Penone, Bill Viola, William Kentridge, Dana Schutz. Ognuno di essi costituisce, nella diversità, altrettante occasioni di lettura di prassi, di sguardi, di percorsi di formatività e di teoresi, come consapevolezza critica sul presente. Pratiche sperimentali di linguaggi derivati da sguardi che si configurano come un ‘guardare attraverso’ (Garroni 1992), come un lavoro di traduzione del proprio tempo e come sguardo possibile sulla tradizione.
Si può scorrere ‘Incursioni’ come un nuovo Museo dei Musei di André Malraux (Malraux [1951] 1957). Le ‘Incursioni’ di Settis articolano un percorso non nella storia dell’arte, ma come in un museo immaginario, un percorso narrativo fra linguaggi e operatività differenti, dove classico e contemporaneo formano una trama continua di pensiero e di sguardo. L’arte non è vista come storia ma come percorso. Settis mette in guardia dal rischio di un eterno presente, di una “barriera autistica” che caratterizza l’arte “solo cronologicamente contemporanea” incapace di elaborare le sedimentazioni, la memoria in un presente cristallizzato eterno e appiattito. Si è spezzato il filo della tradizione che ha funzionato come possibilità di traduzione nel presente, di tensione e di sguardi possibili. Il museo, con la sua organizzazione, con il suo costituirsi come ambiente estetico, rende leggibile l’arte come processualità organica al mondo, abitabile come forma di conoscenza e di esperire. Le ‘Incursioni’ di Settis costituiscono un laboratorio dello sguardo sulle pratiche e sui linguaggi artistici del contemporaneo. Gli esempi presi in considerazione vengono letti in un percorso formativo all’insegna del rapporto con un passato che, se adeguatamente interrogato, è capace di irradiare energie straordinarie. In questo senso l’oggetto artistico (anche nel suo statuto di immagine, analogica, cinema, fotografia e digitale, Bergman, Jodice, Bill Viola) acquisisce il senso di un laboratorio caratteristico del lavoro di sguardo, del guardare attraverso che è specifico della operatività artistica. Gli esempi poetici e ed estetici che scaturiscono dalla lettura dello studioso funzionano come altrettanti stimolatori per le dinamiche creative e operative, ad uso di chi opera nel contemporaneo con una logica differenziata dalla omologazione estetica imposta dal mercato e dalla comunicazione. Il filo della tradizione si dimostra capace di generare sguardi e modalità operative originali e originari. Come già accaduto in grandi epoche dell’arte con l’investimento di nuovi sguardi sul Classico, nelle rinascenze, capaci di attivare dinamiche creative originali, nel nostro contemporaneo abbiano bisogno di operare sguardi e di aprire passaggi su esperienze che non possono essere archiviate come Storia, ma come istanze dinamiche di creatività. Il rischio della cosiddetta arte cronologicamente contemporanea, in realtà arte solo attuale, è quello di rendere il museo una mera esperienza sensazionale e, la produzione artistica, esperienza subordinata alla comunicazione nella dimensione effimera e omologante del capitalismo estetico (Di Giacomo 2016).
La funzione moderna dell’arte si inaugura nel XVII secolo con la compresenza strutturale e funzionale di tre istituzioni: il museo moderno, le Accademie di Belle Arti e l’Estetica. I tre istituti agiscono in piena sintonia e relazione. Le accademie si rifunzionalizzano all’insegna delle Belle Arti, nella consapevolezza che la funzione dell’arte moderna è la produzione del bello come qualità etica (Evola 2018). Nelle accademie l’arte non si trasmette, piuttosto si pratica, in una continuità ideale con le Accademie Del Disegno e di San Luca istituite a Firenze e a Roma nel XVI secolo come superamento dell’artigianato di bottega. Il Museo moderno che ha come paradigma il Museo Capitolino esemplifica l’arte come forma dell’idealità classica. Nel museo moderno l’arte è laboratorio di sguardo, possibilità di istituire uno sguardo attraverso, non a caso le collezioni museali sono spesso all’interno delle stesse accademie, come materiale di lavoro per gli artisti. Dal XIX secolo le Accademie di Belle Arti, diffuse in tutta Europa, sulla scorta di Winckelmann e Mengs, si esercitano su una koine poetica fondata sulla tradizione del classico attraverso le copie, i calchi in gesso, la pratica del disegno dal vero, lo studio dell’anatomia, la formazione filosofica e culturale di alto livello. L’artista formato in Accademia acquisisce lo status di intellettuale. L’estetica moderna si configura come lo strumento interpretativo per la formazione e per la critica del gusto come facoltà soggettiva. L’arte si legittima come occasione di pensiero. Antico e contemporaneo superano il conflitto e si pongono come continua relazione di tensione. Paradossalmente l’antico diventa moderno nella nuova prassi artistica fondata su una mimesis rifunzionalizzata verso una etica moderna dell’arte. Il solco aperto da Winckelmann apre una cultura dell’innovazione originata dal modello dell’antico. Il collezionismo, il museo, sono dispositivi che attivano lo sguardo sull’antico come sguardo sul possibile Contemporaneo. La condizione dell’arte attuale si caratterizza piuttosto come tabula rasa senza storia in un presente compulsivo e assoluto. Da questa condizione la perdita del carattere veritativo dell’arte per una funzione meramente sensazionalistica.
L’operatività artistica e il museo come laboratorio dello sguardo
Dunque ripensare il presente attraverso la prassi artistica significa ripercorrere i motivi costitutivi della artisticità nei suoi statuti, il luogo dell’esercizio, le Accademie, la cui missione si riassume nella triade insegnare, praticare, produrre (Michaud 2010), secondo quell’originale procedura dell’imparare praticando, proiettato in una prassi progettuale, produttiva. Fin dalla loro istituzione le Accademie, nella pratica espositiva del Salon, sono anche le sedi istituzionali del mercato e della formazione del gusto del pubblico. Con la pratica della esposizione al pubblico nasce la critica di cui Diderot e Baudelaire costituiscono i momenti fondanti del gusto moderno. Si organizza il museo come collezione, ma soprattutto come dispositivo di comunicazione e di tutela in un rapporto interdipendente. Il museo moderno si istituisce come storia nel percorso espositivo e come dispositivo istitutivo dell’arte come storia. Il museo moderno è soprattutto un ambiente estetico che legittima le forme d’arte, come “cenere che custodisce il fuoco”, per richiamare la citazione di Settis da Mahler. Il museo si pensa come ambiente di una tradizione che si significa nel suo operare come prassi trans-formatrice di forme del passato, e come forma sensibile del presente. In questo senso il museo più che come spazio contenitore, si costituisce come luogo, come un ambiente estetico.
Alla luce di queste considerazioni storiche appare problematico il ruolo attuale del museo. Distanti anni luce dalla formula della distinzione come amore dell’arte ipotizzata da Bourdieu negli anni ’70 (Bourdieu 1972), il pubblico vive oggi una musealizzazione diffusa mentre il museo vive una presentificazione omologata ai canoni della spettacolarizzazione e della ritualità sociale dell’evento. L’effetto della sensazione, la feticizzazione dell’oggetto, la prevalenza della comunicazione sulla riflessione, il prevalere del valore espositivo sul valore d’uso. La valorizzazione diventa la monetizzazione. Oggi appare curiosa la decisione di chiudere i musei con una inversione di paradigma cosi immediata e radicale rispetto a pochi mesi fa, quando cioè la missione del museo veniva forzatamente orientata sulla rilevanza delle presenze indifferenziate, della quantità di pubblico, incuranti dello stress considerevole a cui vengono sottoposte le opere, il personale, il contenitore. L’attenzione della comunicazione museale è centrata sul canale di comunicazione, orientando e omologando così lo stesso sguardo dello spettatore, sollecitato in modo compulsivo dalla comunicazione pubblicitaria. Le ‘Incursioni’ di Settis si propongono come un ideale percorso museale interdisciplinare e intermediale, dalle arti visuali tradizionali, al cinema alla fotografia, ai dati della cultura di massa, alle nuove tecnologie digitali ed elettroniche delle nuove immagini. Questo originale paradigma ci permette di aprire una riflessione sulla praticabilità dei musei oggi. In modo puntuale ed efficace Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, in tre interventi pubblici, che riportiamo di seguito, ha delineato molto chiaramente situazione e possibilità per i musei nella situazione attuale. In prima istanza Greco sottolinea che la funzione del museo, delle sue collezioni, è quella di “costruire relazioni sociali tra gli esseri umani che vanno ben oltre i confini fisici del museo e condizionano processi che coinvolgono intere comunità consentendo di definire la relazione con oggetti, luoghi e tempi lontani” (Greco 2020b). L’oggetto che costituisce la collezione è infatti un semioforo, secondo la felice definizione di Pomian (Pomian 2004), oggetto trasportato, movimentato che, a sua volta, è veicolo e portatore di narrazioni, di esperienze e di relazioni spazio temporali. Lo spettatore diviene partecipe di una agency sociale che non si limita alla relazione con il “pezzo da museo” (Marini Clarelli 2017) ma prosegue nel complesso apparato organizzativo del museo che produce, nel suo complesso, il senso del museo come ambiente estetico. Esposizione, ricerca, formazione, emozione fanno parte dell’insieme dell’esperienza estetica del museo come forma di conoscenza e non solo di sensazione. Su questo aspetto sarebbe necessaria una riflessione sul criterio espositivo contemporaneo sempre più centrato sulla sensazione che prevale sulla funzione conoscitiva (D’Angelo 2020). In questo senso il ‘pezzo da museo’ non si configura come passato ma come presente in atto nella sua funzione formativa e conoscitiva. La collezione museale e l’intero complesso produttivo del dispositivo museale si pongono come laboratorio di conoscenza e di innovazione. Nel contatto che la collezione stabilisce, si aprono relazioni originate da esperienze di conoscenza. La relazione tra materialità e immaterialità della conoscenza definisce il senso del percorso espositivo, e la percezione del particolare ambiente estetico. Nel contatto con la collezione, nell’esperienza del percorso si stabiliscono relazioni in cui i processi culturali vengono creati e contestualizzati. Negli ultimi anni i musei sono sottoposti a uno stress di attività espositiva e di ricezione di pubblico che allontana sempre di più le istituzioni di maggiore attrazione dalle realtà minori e periferiche diventate sempre più marginali anche rispetto al territorio di appartenenza. Il riferimento del pubblico museale, rovesciando il paradigma di Bourdieu della ‘distinzione’, è quello indistinto del turismo di massa. A questo proposito Greco in un altro intervento rileva che “Il museo non è dunque una mera raccolta materiale, una scenografia, ma costituisce una rete sociale” (Greco 2021). Oggi ci si interroga se aprire i musei o no per mancanza dei turisti. Il museo è percepito come luogo riservato ai turisti “e ci siamo dimenticati che, invece, costituiamo una enciclopedia materiale che permette di sapere, capire, scegliere. Il valore aggiunto dei musei non è costituito dalla vendita dei biglietti ma dal fatto che contribuiscono a definire quale sia il nostro ruolo all’interno della società” (Greco 2021).
I ‘pezzi da museo’ sono infatti fenomeni portatori di complessità e di relazioni. Rimane molto da pensare ancora sulle funzioni del museo non solo come tutela e valorizzazione, ma come insieme di esperienze didattiche integrate nel processo di una valorizzazione autentica, riconsiderando il concetto di valorizzazione come produzione di conoscenza. Il dialogo fra materiale e immateriale dovrebbe costituire la missione principale della didattica museale. In questo senso l’ambiente museale deve essere pensato sempre più come luogo di inclusione e di relazione, in osservanza all’articolo 9 della Costituzione Italiana, mettendo al centro il concetto di cultura come cittadinanza sociale e non come consumo di giacimenti.L’esperienza del museo partecipa del processo cognitivo nella relazione che si instaura fra materialità e immaterialità. I beni culturali così come la musica, il teatro, il cinema, dovrebbero costituire parte integrante del curriculum formativo di ogni cittadino. La gestione dei beni culturali non può essere considerata come un fardello economico né come una pertinenza esclusiva del turismo:
La cultura è un immenso laboratorio di innovazione dove nuove modalità di espressione e tecnologie all’avanguardia possono dialogare con il passato e fornire risposte sempre più nuove alle istanze della società (Greco 2020a).
Alla luce di queste considerazioni bisogna chiedersi il senso di operazioni mediatiche, annunciate con clamore, di fatto poi disattese. Ci riferiamo al clamoroso fallimento del progetto di valorizzazione “Verybello”, al Fondo di investimento sul patrimonio culturale, con la compartecipazione del privato, ai reiterati annunci per una ‘rivitalizzazione’ in chiave spettacolare del Colosseo, infine alla “Netflix della cultura, It’s Art” ancora in discussione, al momento in cui scriviamo. La lettura delle ‘Incursioni’ di Settis nel contemporaneo, nel museo, negli sguardi di artisti su artisti, nel riflesso delle operatività artistiche, nelle poetiche e nelle estetiche esercitate da artisti che si confrontano con il passato in un tempo presente, si offrono come riflessione sul museo e sulla didattica dell’arte e sull’uso delle istituzioni. La necessità di ripensare la stessa definizione del museo come luogo di inclusione è oggi al centro del dibattito all’interno dell’International Council of Museums. Si può in conclusione riflettere sulla situazione attuale come una occasione perduta, quella di non avere pensato ad abitare l’ambiente museo come nuova opportunità per sperimentare (si badi: sperimentare, non applicare o trasmettere!) una modalità didattica capace di mettere al centro la prassi e lo sguardo dell’arte sull’arte. Oggi il museo si ridefinisce piuttosto come attrattore in termini di marketing dando per scontato che si è spezzato il filo che lega tradizione e contemporaneo. La relazione con la produzione contemporanea non si pone come ‘traduzione della tradizione’ ma come frattura permanente in un presentificazione continua. Il filo storico della modernità appare incomprensibile, come relative appaiono le definizioni di moderno e di contemporaneo. Si definiscono contemporanei fenomeni e poetiche caratterizzate da interventi sul presente datati ben cinquanta anni or sono. Il museo storico diventa cornice, location per eventi o per giustificare operazioni di marketing allo scopo di valorizzare (monetizzare) operazioni di scarsa rilevanza artistica e culturale che acquisiscono rilevanza in una strategia di marketing nell’ambiente museo (Montanari, Trione, 2017).
Il paradosso è quello di utilizzare il museo storico o istituzionale come ambiente nel quale leggere l’artista contemporaneo. Quanto ha bisogno Guido Reni di Damien Hirst? O è vero piuttosto il contrario? Ma il vortice del paradosso è capace di andare oltre assumendo influencer del mondo mediatico per ‘promuovere’ Botticelli o Caravaggio. Ma ci domandiamo se è questo il modo corretto e produttivo per ‘avvicinare i giovani’ con una pedagogia da marketing. Già si organizzano tour museali per una nota influencer con tanto di accessori firmati. Quella dei giovani e del grande pubblico è evidentemente una categoria unica che non è destinata ad emanciparsi dalla perenne età infantile, diversamente dalla indicazione kantiana del sapere aude. I musei non sono considerati come luogo di conoscenza e di elaborazione ma come percorsi mediatici, ambienti estetici per sollecitare emozioni prefabbricate, sensazioni immersive, e non esperienze cognitive. Come il teatro non è soltanto uno spazio, ma un luogo dove il ‘vedere’ è un atto di responsabilità (Muntadas 2003), anche il museo non è solo un contenitore, una custodia, una teca, un reliquiario, ma un ambiente sensoriale dove il materiale ‘dice’ dell’immateriale. La partecipazione immersiva condivide una esperienza di omologazione finalizzata al mercato. La feticizzazione mediatica delle architetture, la prevalenza dell’archistar sul progetto relazionale orientano il gusto del pubblico verso logiche di consumo e non di elaborazione di esperienze. Il museo viene concepito come brand che, nel nome, è garante di qualsiasi operazione, e le mostre come format capaci di omologare il gusto del pubblico finalizzato al consumo culturale, compreso l’indotto non indifferente, appaltato a privati, della oggettistica. In questa logica la didattica artistica compresa quella specifica museale, risulta di fatto delegittimata o funzionale al consumo immettendo il visitatore nella logica del consumatore. Si rileva l’impossibilità di aprire un processo e una sperimentazione didattica nel e per il museo per le Accademie, i Conservatori, l’Alta formazione artistica e le Università. Sarebbe stata una eccezionale opportunità la possibilità di sperimentare, pianificare e progettare una nuova relazione fra museo, gallerie, biblioteche, percorsi e contesti urbani, architettura, istituzioni culturali, siti archeologici e istituti di alta formazione artistica. La chiusura repentina e totale è stata invece considerata in relazione alla mancanza dei flussi turistici come unico parametro di funzionalità dei musei. Si è perduto il senso della formazione e della origine delle collezioni, del museo, dei percorsi, del rapporto fra tradizione e traduzione della prassi artistica alle origini della modernità dell’arte, come elaborazione di sguardi e di prassi, come sedimento di contenuti e come riconfigurazione possibile.
Tradizione e sguardo presente
Settis mette al centro il rapporto di tensione che si articola fra antico e contemporaneo, quel particolare rapporto di emozione, indagine, sguardo che genera il gusto, che separa il ‘sensazionalismo’ dalla conoscenza, quella consapevolezza che era stata posta al centro della nascita dell’Estetica come disciplina. Il percorso di ‘Incursioni’ permette di riconfigurare lo sguardo come percorso di gusto e di conoscenza. Alla ‘vita amministrata” di adorniana memoria, dalla articolazione mediatica, si contrappone l’elaborazione di processi di conoscenza nella libertà del gusto soggettivo e nella autonomia di giudizio. Il pubblico dovrà emanciparsi kantianamente dalla condizione infantile e dal vincolo pedagogico del marketing mediatico. Ripensare l’esperienza del museo e della didattica artistica presuppone un processo di liberazione dall’aggregazione prodotta dai riti mediatici, articolati dal processo di tribalizzazione dei social media, la riduzione a glamour presenzialista dell’esperienza artistica. Concordiamo con Settis nella urgenza di riappropriarci dell’etimo di tradizione come tradere, processo di passaggio di consegne, scambio relazionale, trading, trasmissione, transito, di cui l’istituzione museale e l’istituzione designata alla formazione sono parti costitutive e integrali. Tradizione e comunicazione partecipano di quel processo non trasmissivo in senso verticale ma partecipativo in senso orizzontale. La cultura non è qualcosa destinata al consumo, ma qualcosa che si produce e si condivide come cittadinanza, come appartenenza, come identità.
Con ‘Incursioni’ Settis porta a compimento riflessivo un lungo processo di elaborazione progettuale dei percorsi espositivi dei quali è stato autore e che hanno segnato alcuni dei momenti più significativi ricerca museologica conseguendo risultati di grande rilevanza, come dimostrato dalle mostre a Milano “Serial Portable Classic. Moltiplicare l’arte tra Grecia e Roma” del 2015 (v. una Galleria della mostra in Engramma) e a Roma con “I Marmi Torlonia. Collezionare capolavori” 2020-2021. La raccolta dei saggi contenuti in ‘Incursioni’ si articola nel contesto di una lettura warburghiana nel segno della Pathosformel come esperienza conoscitiva e di indagine, come lettura del senso più profondo dell’operatività artistica. I progetti espositivi curati da Settis sono una dimostrazione di come sia possibile realizzare eventi culturali di rilevanza, non solo quantitativa ma anche qualitativa, all’insegna della abitabilità della tradizione e del museo. Le incursioni del moderno nell’antico servono a disincagliare lo sguardo dalla teca del museo, a mobilitare lo sguardo, ad abitare un ambiente estetico, a ricombinare e riconfigurare percorsi liberi di emozioni capaci di offrire ancora pensiero libero da ogni tipo di feticismo vincolante e capace di riarticolare quel pensiero operativo che chiamiamo ancora ‘arte’.
Riferimenti bibliografici
- D’Angelo 2020
P. D’Angelo, La tirannia delle emozioni, Bologna 2020. - G. Di Giacomo, Arte e modernità. Una guida filosofica, Roma 2016.
- Evola 2018
D. Evola, La funzione moderna dell’arte. Estetica delle arti visive nella modernità, Milano 2018. - Garroni 1992
E. Garroni, Estetica. Uno sguardo-attraverso, Milano 1992. - Greco 2020a
C. Greco 2020, Curarsi con la cultura, “La Repubblica” 28.10.20. - Greco 2020b
C. Greco, La missione dei musei costruire relazioni sociali, “La Stampa” (31 dicembre 2020). - Greco 2021
C. Greco, I musei non sono solo per turisti, “La Repubblica” (5 febbraio 2021). - Malraux [1951] 1957
A. Malraux, Il museo dei musei [ed. or., Les voix du silence, Paris 1951], trad. it. L. Magrini, Milano 1957. - Marini Ciarelli
M.V. Marini Clarelli, Pezzi da museo. Perché alcuni oggetti durano per sempre, Roma 2017. - Michaud [1999] 2010
Y. Michaud, Insegnare l’arte? Analisi e riflessioni sull’insegnamento dell’arte nell’epoca postmoderna e contemporanea, [ed. or., Enseigner l’art? Analyses et réflexions sur les écoles d’art, II ed., Nîmes 1999], trad. it.L. Schettino, Roma 2010. - Montanari, Trione 2012
T. Montanari, V. Trione, Contro le mostre, Torino 2012. - Muntadas 2003
A. Muntadas, On translation, Barcelona 2003. - Pomian 2004
K. Pomian, Dalle sacre reliquie all’arte moderna. Venezia Chicago dal XVII al XX secolo, Milano 2004. - Settis 2004
S. Settis, Futuro del classico, Torino 2004.
Per citare questo articolo / To cite this article: D. Evola, Incursioni per abitare il museo come ambiente estetico, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 313-326 | PDF
Incursioni offre una straordinaria serie di spunti e suggerisce innumerevoli occasioni di riflessione. Ma vorrei discutere solamente di un segmento del capitolo iniziale (che serve però a sostenere l’architettura dell’intero volume), e vorrei farlo – per quanto possa sembrare stravagante – partendo da un vecchissimo carosello. I caroselli erano spot pubblicitari che, dagli anni ’50 in poi, andavano in onda dopo i telegiornali e in apertura dei programmi di prima serata. La serie che reclamizzava il formaggio Bel Paese Galbani, era un po’ il sequel del Viaggio nella valle del Po, la trasmissione condotta da Mario Soldati dal 1957. Uno di essi si svolge ad Arquà, in provincia di Padova: Soldati indica la località sulla cartina d’Italia che era impressa sulla confezione del formaggio, accanto al ritratto di Antonio Stoppani, l’autore appunto de Il Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze naturali la geologia e la geografia fisica d’Italia (1876).
Soldati si affaccia a una finestra della casa di Francesco Petrarca, recitando l’inizio del sonetto che Alfieri aveva dedicato alla dimora (“O cameretta, che già in te chiudesti …”) riprendendo, a sua volta, versi dello poeta trecentesco. L’antica casa, sottolinea Soldati, non andò in rovina anche grazie a questi versi di Alfieri. Un cenno al paesaggio dei Colli Euganei (e a quello di Valchiusa) e la scena si sposta all’esterno, accanto al sarcofago in pietra in cui è sepolto il poeta. Qui lo attende, chiavi in mano, il custode della casa-museo. Come fossero a scuola, Soldati lo interroga: come mai il poeta da Arezzo “È venuto fin qua?”. Era venuto a morire in questo paese perché c’era tanta quiete, “Non c’era nessuna moto, nessuna macchina… e a lui piaceva il vino buono”, risponde il custode. Soldati a questo punto lo abbandona, guarda in macchina e puntualizza: “Non so se il custode pensi che seicento anni fa c’erano già le moto, oppure che il Petrarca sia vissuto in un’epoca molto più vicina… comunque questo ci sembra, forse, l’omaggio più commovente alla gloria del Petrarca”.
Il carosello mostra, uno accanto all’altro, due approcci al passato che coincidono con due diverse posizioni sociali (a loro volta certificate dai rispettivi abiti): da una parte la cultura borghese di Soldati e la capacità di muoversi con agio tra le testimonianze artistiche e letterarie. Dall’altra i modi popolari del custode, che parla di Petrarca con rispetto, ma anche con una sorta di confidenza: riconduce il passato al proprio tempo senza troppe preoccupazioni storico-filologiche. Risponde a Soldati con deferenza, ma questi lo tratta come fanno gli insegnanti con gli allievi, con quell’aria di benevolo paternalismo che serve a far sorridere gli spettatori (del custode). Inutile dire che una scena come questa oggi non sarebbe immaginabile.
Da un lato Soldati (e i turisti che visitavano la casa e la tomba di Petrarca), dall’altro il custode (e buona parte del pubblico della televisione, da poco arrivata anche in Italia). Che valore hanno – per gli uni e per gli altri – la storia di un monumento antico (la casa di Arquà) e il lascito letterario del passato (i versi del Petrarca e di Alfieri)? Che cosa è per loro la “tradizione”? È questa una delle parole chiave del libro di Settis, tanto da comparire già nel sottotitolo, Arte contemporanea e tradizione.
Come un basso continuo, “tradizione” punteggia infatti quasi ogni pagina del libro. Le occorrenze più frequenti sono “tradizione artistica” e “tradizione culturale”, ma ci sono anche la “tradizione pittorica” (Incursioni, alla pagina 45), quella “di bottega” (alle pagine 290 e 293), la “tradizione disciplinare”. In parallelo non è minore il ricorso a “memoria”: memoria “culturale” e “sociale” prevalgono, ma si parla anche di “memoria visuale” (Incursioni, alla pagina 271) e “inconsapevole”, e di “cripto-memoria” (alla pagina 344). Al di là delle occorrenze dell’uno o dell’altro termine, è chiara l’opzione per “tradizione” (tanto più che anche all’interno del magnifico saggio su Rito di Ingmar Bergman il paragrafo più importante ha questo titolo).
L’idea è che vada ridiscusso il “paradigma della frattura” in nome di una sostanziale continuità tra passato e presente: “il filo della tradizione non si è spezzato ma si è consolidato, travestendosi in nuove forme e modalità che chiedono di essere riconosciute e chiamate per nome”. Quello di Settis è a tutti gli effetti uno sguardo da una posizione elevata, capace di dominare un arco di tempo vastissimo nello sforzo di individuare il “principio unificante” (Incursioni, alla pagina 17) che consenta di leggere anche l’arte contemporanea nella lunga storia della “pratica artistica”. La “tradizione artistica” appare così come una sorta di meccanismo di trasmissione i cui ingranaggi cambiano di volta in volta per adattarsi alle diverse condizioni storiche, ma finiscono per assicurare comunque il funzionamento dell’insieme. La visione da lontano e dall’alto proposta dallo studioso ha dunque l’efficacia di riannodare fasi ed esperienze che apparirebbero radicalmente estranee, spiegandone i legami non visibili in superficie.
Ma ha anche l’effetto di appannare differenze e contraddizioni. L’idea di tradizione, infatti, implica quella di consegna e porta con sé una catena di azioni conseguenti: affidamento, trasmissione, custodia, accettazione, condivisione. La produzione artistica del Novecento e della contemporaneità non si iscrivono facilmente in questa sequela. E non sono tanto i rifiuti espliciti – quello dei Futuristi, ad esempio – a indicarlo, quanto il numero degli artisti che non hanno né cercato, né scoperto parenti vicini o lontani. Sostanzialmente indifferenti ad allacciare un rapporto col passato, come gran parte del loro pubblico del resto – “Bisogna avere la tradizione dentro di sé per poterla odiare veramente e fino in fondo”, sosteneva Adorno.
“Tradizione” – sostiene Settis – [...] vuol dire ereditare qualcosa e impadronirsene per trasformarlo in qualcos’altro”. L’eredità è però una consegna, non semplicemente un agglomerato di materiali (di idee, di forme...) a disposizione: un conto è riappropriarmi di un oggetto che trovo in casa (per quanto modesto), un altro usarne uno comprato nel negozio di un antiquario. La tradizione – in quanto consegna – non è tanto l’insieme di cose che vengono date a qualcuno, ma la motivazione (a sua volta consistente in un insieme di ragioni, valori, idee) implicita o esplicita che accompagna questa cessione.
È fuori discussione che per secoli sia esistita una tradizione (artistica e culturale): Goethe aveva scritto che l’arte intera è dominata dal principio della filiazione, citando il legame tra Raffaello e l’Antichità. Ma persino nei casi studiati da Settis in cui è comprovato un nesso con iconografie antiche – quello della testa tagliata di Duchamp, ad esempio – è ben difficile parlare di filiazione (e quindi di tradizione in senso proprio).
Non c’è dubbio insomma che anche gli artisti delle avanguardie e quelli contemporanei abbiano guardato al passato (come sarebbe possibile non farlo?), ma basta questo per inserirli in una “tradizione”? Una cosa è recuperare un brano figurativo dal proprio (o altrui) taccuino, un’altra da una pubblicazione sfogliata a caso oppure (oggi) dal web: il taccuino comporta una selezione e sottintende un canone, il web (e la cultura di massa su cui si è innestato) implica una assenza di gerarchie di valori, perlomeno quelle tradizionali. Una cosa è disporre le proprie “figure interiori” entro un percorso riconosciuto e condiviso, un’altra pescare idee in un deposito sconfinato e brulicante, magari distorcendone il senso.
Finora abbiamo parlato di artisti. Torniamo un momento al custode del Petrarca. La sua idea di passato è più vicina a quella di Soldati di quanto dicano le apparenze: per lui ha una consistenza indiscutibile, è qualcosa di certo; egli riconduce una lontanissima esperienza al proprio presente. Ma la macchina della comunicazione industriale, alla fine degli anni ’50 era già in moto: con un’aria di piacevole svago culturale, il carosello scompaginava – nel suo piccolo – gerarchie consolidate, così che la promozione del formaggio metteva in riga – di fatto – Stoppani e il Belpaese, Soldati e il custode, Petrarca, la sua “cameretta” e Alfieri. Tutto veniva subordinato al prodotto (è il meccanismo di tutta la comunicazione pubblicitaria oggi come allora). Il “presentismo” che segna la nostra cultura deriva anche da questo: non è una presa di posizione, ma una condizione.
Il “paradigma della frattura”, nel suo schematismo, non basta certo a descrivere le trasformazioni accadute nella cultura e nell’arte da più di un secolo a questa parte. Ma qualcosa deve pure essere successo, e in profondità. Come spiegare altrimenti il tormentato rapporto tra il pubblico del Novecento e l’arte del suo tempo? In che misura il paradigma della tradizione fa i conti con il pubblico di oggi (ma anche di ieri l’altro)? Il “discorso sull’arte”, infatti, non appartiene solo agli addetti ai lavori (molti hanno una esperienza estetica e storica, ma non sanno descriverla). Stando a Bellori, anche Annibale Carracci la pensava così, se – a proposito delle opere di Domenichino e di Guido Reni nell’oratorio di Sant’Andrea a Roma – si affidava alle parole di una “vecchiarella”:
Vedi quel manigoldo con quanta furia inalza i flagelli? Vedi quell'altro, che minaccia rabbiosamente il santo col dito, e colui che con tanta forza stringe i nodi de' piedi? Vedi il santo stesso con quanta fede rimira il cielo?
Una persona del popolo si orientava senza fatica nel linguaggio di un grande pittore, sapeva cogliere tanto i momenti di grande trasporto emotivo, quanto quelli di quiete spirituale. Oggi c’è una “vecchiarella” anche per Kentridge?
Ma – alla fine – si potrebbe obiettare: come mai i saggi raccolti in Incursioni sono così compiuti e riusciti nonostante l’assunto teorico che sta alle spalle non sia altrettanto persuasivo? Il fatto è che una tradizione di certo esiste, quella che, innestandosi sulla linea warburghiana (così chiaramente riproposta da Settis), è ancora sostanzialmente una tradizione umanistica: ricomporre i frammenti, orientarsi tra i relitti del passato e del presente, riscoprire e rinnovare i fili che ci legano agli altri uomini.
Per citare questo articolo / To cite this article: C. Franzoni, Fragilità della tradizione, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 327-331 | PDF
Le ultimissime Incursioni dell’archeologo Salvatore Settis in una galleria ben selezionata dell’arte contemporanea non sono soltanto la raccolta di una serie di brillanti decrittazioni di modelli antichi, camuffati o stravolti dai loro interpreti moderni; o un’esemplificazione di come la tradizione iconografica della classicità possa riaffiorare da suoi percorsi carsici anche in suoli culturali impermeabili, all’apparenza, o addirittura programmaticamente ostili. Naturalmente l’aspetto antologico esiste e si dichiara con riferimenti puntuali alla storia editoriale di questi testi, e si potrebbe essere tentati di tracciare una distinzione tra i saggi più corposi e metodologicamente militanti – quelli dedicati a Duchamp, Guttuso, Bergman, Viola e Kentridge – e altri più svelti e occasionali; ma il capitolo introduttivo s’incarica subito di delineare, con la limpidezza argomentativa consueta all’Autore, un indirizzo di ricerca di piena consapevolezza e organicità. Si tratta, nella sostanza, di un ritorno a Warburg: ciò che non rappresenta una novità, beninteso, per Settis, ma qui si configura come ritorno diretto, senza mediazioni, accantonate le superfetazioni della scuola – in poco più di trecento pagine, se non sbaglio, Panofsky è citato solo una volta – e ripartendo dalle tavole del Bilderatlas Mnemosyne, disponibili on line, oltre che nella prima edizione digitale in Engramma, ora anche nelle tre versioni del 1928 e ’29, grazie al sito del Warburg Institute. Ciò significa spostare il focus della critica d’arte dall’esercizio esplorativo dei contenuti profondi delle immagini all’autentico Leitmotiv warburghiano, che è il grande tema storico-culturale della continuità dell’antico, messo alla prova nella cornice di una contemporaneità molto spesso negatrice della tradizione.
I fatti, d’altra parte, mostrano come le pretese di discontinuità nell’esperienza artistica siano asserzioni ideologiche o, nel migliore dei casi, utopie, fin dal tempo in cui, di uno scultore del calibro di Lisippo, la critica – cioè Duride – poteva negare l’esistenza di maestri: Plin., Nat. Hist. 34, 61: “Lysippum Sicyonium Duris negat ullius fuisse discipulum”.
Al celebre aforisma mahleriano citato da Settis – per cui da custodire sarebbe il fuoco della tradizione, non le sue ceneri – si oppone, se vogliamo restare nel campo dell’esemplificazione musicale, la discontinuità assoluta e ideologica della dodecafonia di Schoenberg, irrimediabilmente ingabbiata nella sua utopia autoreferenziale. Secondo Settis, invece, la tradizione artistica fornisce ai produttori d’arte quei Gedankenbilder, le immagini mentali dell’accezione di Schlosser, che appunto Aby Warburg risemantizzò e ridefinì come Pathosformeln o schemi emozionali. Da questo particolare punto di vista è estremamente interessante e meritevole di approfondimento l’ipotesi di una parentela inconsapevole tra il medesimo Warburg e il grande cineasta e teorico della cinematografia Sergei Ejzenštejn, dettata dal comune e indipendente interesse per l’espressionismo tedesco, ma ancor più da una condivisa matrice filosofica nietzschiana (sul binomio Warburg/Ejzenštejn, v. l’eccellente tesi di laurea di Camilla Balbi, discussa a Pavia: Balbi 2016).
Compito essenziale dello storico dell’arte è pertanto quello di alimentare mnemosyne (la memoria) attraverso una rete di confronti tra immagini, sempre più fitta col procedere del tempo, e di agnizioni da questi derivanti. In tal modo lo storico dell’arte concorre, insieme con l’artista e col suo committente, a dare significazione duratura all’opera, in una sorta di rivitalizzazione permanente. Il rapporto con la tradizione è dunque aspetto di cui lo storico è chiamato ad assumere consapevolezza, anche quando (e tanto più quando) l’autore stesso non riesca a rendersene interamente conto. Nelle arti visive la conoscenza storica consisterà dunque, in primissima battuta, in un’anamnesi comparativa, in quel game of recognitions che Susan Sontag ha attribuito al ‘conoscitore’, e Settis chiosa come “l’abilità di riconoscere in qualcosa che vediamo per la prima volta la traccia di qualcos’altro che sapevamo già, e che per questo aggancia la nostra memoria”.

Morte di Duncano, in Giuseppe Verdi, Macbeth, regia di Emma Dante, 2017.
Viene in mente, in proposito, l’accezione goethiana del verbo (sich) erinnern, utilizzato nell’episodio pestano dell’Italienische Reise per descrivere il processo mentale di recupero di una memoria storico-artistica (nel caso specifico winckelmanniana) atta a sanare lo sbalordimento di un’immagine inusitata. Esposto infatti all’imprevedibile difformità architettonica dei templi di Paestum, Goethe è inizialmente disorientato; ma è proprio la Kunstgeschichte, che gli si manifesta come prodotto di reminiscenza, a dargli la motivazione (cronologica) di quella difformità e dunque il modo di una pacificazione intellettuale. Lo stesso verbo (sich) erinnern avrebbe poi caratterizzato, nel sogno di Hans Castorp semiassiderato sullo Zauberberg, il riconoscimento, si osservi, puramente culturale di un paesaggio mediterraneo non ancora conosciuto per esperienza autoptica (sulla memoria umanistica come processo di reminiscenza, da Winckelmann a Goethe a Mann, rinvio a Harari 2018, 50-51).
Nella carrellata proposta da Settis, i games of recognitions più istruttivi investono, in sequenza di progressivo svelamento, il tableau vivant fotografico – e i relativi scatti di prova, poi scartati – del Doppio ritratto di Mary Reynolds e Marcel Duchamp (1937), la matita di Renato Guttuso intitolata La morte di Neruda (1973) – pure questa col corredo di sue varianti d’autore – e la sceneggiatura e il film di Ingmar Bergman, realizzato per la televisione svedese, Riten (Il rito, 1969). Sono tre contributi molto meditati e molto densi, non solo di vere scoperte iconografiche, ma anche d’implicazioni teoriche e metodologiche.
Del Doppio ritratto di Duchamp, Settis illustra con ricchezza di confronti convincenti la pertinenza tipologica alla serie numerosa di rappresentazioni di eroine “cacciatrici di teste”, Giuditte e Salomè, messe in posa accanto ai loro maschili, sanguinosi trofei; ma con occhio acuto di archeologo riconosce anche due chiarissimi attributi dionisiaci, uno seminascosto dall’orlo del panneggio indossato dalla Reynolds – la ghirlanda d’edera – l’altro presente in uno degli scatti poi scartati – il grande kantharos verniciato di nero. Sono dettagli decisivi a far slittare la situazione dalla sfera delle eroine bibliche a quella del thiasos di Dioniso, convertendo la donna in menade e l’uomo – lo stesso Duchamp: si tratta dunque di un autoritratto – in un Orfeo decapitato, con mutilazione metaforica dell’artista, ridotto a testa mozzata e però (si rammenti) profetica. Non escludo che anche il metro da sarto, involuto come una serpe – per cui Settis escogita una spiegazione acuta quanto complicata – possa alludere ai rettili che le menadi talora esibiscono attorcigliati alle braccia.
Il tema mitologico di Orfeo è del resto molto presente nella modernità novecentesca: senza compilare elenchi qui inutili, può essere forse il caso di segnalare che, pochi anni prima della foto di Duchamp, nel 1930, Jean Cocteau aveva realizzato il suo primo prodotto cinematografico, Le sang d’un poète, che con l’Orphée (1950) e Le Testament d’Orphée (1960) avrebbe poi composto la cosiddetta “trilogie orphique”. Nel Sang d’un poète è infatti centrale, sul piano visivo, la rappresentazione della donna come statua candidissima e mortifera: anche la Reynolds del Doppio ritratto appare sbiancata come un calco di gesso vivente. Musealizzata ma sempre pericolosa, combinando l’alterità di una statua antica con quella di una femminilità bacchica: intrigante la circostanza che così appare anche la donna-gesso del film di Cocteau, interpretata dalla modella e fotografa Elizabeth Lee Miller, allieva e amante di Man Ray, che fu spesso collaboratore di Duchamp in queste performances visive e viene anzi indicato da alcuni (ma, a quanto risulta, erroneamente) quale esecutore degli scatti del Doppio ritratto. Dunque l’artista, che cerca di governare queste e altre alterità potenzialmente distruttive, si autodecapita ironicamente, ma riesce a conservare il dono profetico ricevuto dal dio.
Nel disegno di Guttuso – raffigurante Pablo Neruda ormai cadavere sul letto di ospedale, la mano sinistra che afferra ancora e quasi esibisce il foglio di carta, dove ha appena vergato i nomi dei suoi simbolici assassini (Nixon, Frei e Pinochet), il braccio destro senza forza, che la gravità attrae pesantemente verso il basso, quantunque la penna impugnata dal poeta conservi emblematicamente la posizione di scrittura – Settis individua, dietro l’ovvia citazione de La mort de Marat di Jacques-Louis David, l’antica Pathosformel della debolezza mortale e quasi sempre irreparabile, che mette assieme, nella storia delle immagini, Patroclo con Meleagro con lo stesso Gesù Cristo. È lo schema iconografico greco che poteva esprimere la signoria del sonno e della morte – Hypnos e Thanatos, due fratelli così somiglianti – e altre umane spossatezze, incluse quelle indotte dall’eros e dal vino. Poiché il “braccio della morte” – eventualmente a sinistra anziché a destra – è anche dei Polifemi, resi inermi dall’ubriachezza smisurata, e degli Endimioni, visitati nel sonno dall’abbraccio di una dea. Nell’ecfrasi di Luciano il braccio della morte è il sinistro, e dalla mano sinistra appunto son scivolati via i dardi, arma del cacciatore, così come la penna è arma del poeta (Luc., Dial. Deor. 11). Estranea invece allo schema di David e Guttuso è la postura dell’altro braccio, piegato intorno e dietro il capo, che può ammettere una residuale presenza di vita e indicare infatti – come si verifica nell’iconografia di Arianna – non più l’irrimediabilità della morte, ma la profondità del sonno (Oddo 2014).
Sul Rito di Ingmar Bergman – unico della sua filmografia in cui compare lo stesso regista, nella parte altamente rappresentativa del Confessore – Settis riesce a lavorare in profondità di dettagli, disponendo della sceneggiatura (nell’edizione italiana: Bergman 1979, 177-228). Al di là del tema affrontato – una riflessione intorno al carattere radicalmente sovversivo dell’esperienza teatrale e alla conseguente percezione della sua oscenità strutturale e comunque irriducibile – questo film è singolarmente ricco di riferimenti, più o meno dissimulati, all’Antichità classica: dal cognome Winkelmann (sic) attribuito a uno dei personaggi, alla professione di archeologa menzionata per la moglie di un altro, al nome greco e un po’ mitologico (Thea) della protagonista femminile. Ma l’aspetto con maggior evidenza archeologico, sia pure senza concessione alcuna all’immaginario dell’archeologia, risiede precisamente nel disvelamento finale, pericoloso e distruttivo, dell’essenza rituale della performance. Quella specie di latenza dionisiaca, intorno a cui si era aggirato, nei primi capitoli del volume, l’Erinnern paziente di Settis, trova qui spazio e respiro al riverbero fiammeggiante del grande modello euripideo: le Baccanti, s’intende, che sono state fra le icone performative del Sessantotto, negli States come in Europa. Viene ricordato il Dionysus in ’69 di un De Palma non ancora trentenne, che ci conserva le immagini dell’esperimento teatrale nel performing garage di Richard Schechner; e, in Italia, potremmo citare la traduzione di Edoardo Sanguineti portata in scena da Luigi Squarzina a Genova proprio nel 1968.
Lo stesso Bergman affrontò l’inquietante capolavoro negli anni ’90, assecondando un progetto sedimentato per mezzo secolo, dapprincipio nella versione operistica (Backanterna) musicata da Daniel Börtz. Longue durée di gestazione del progetto e sfasatura cronologica della sua attuazione sottraggono il grande reazionario svedese a una sintonia sessantottesca (o post-sessantottesca) che sicuramente non gli apparteneva. Nel Rito, la sovversione dionisiaca non è infatti propriamente politica (o non solo politica), ma investe l’azione creativa (e le sue ricadute performative) come tali; e inoltre assume un’evidente connotazione paracristiana. Il bacile colmo di vino, sollevato da un Winkelmann (!) perché vi si specchi una Thea mascherata (!), conserva la memoria iconografica, come osserva giustamente Settis, di un dettaglio famoso del fregio della Villa dei Misteri; ma, nella formazione luterana di Bergman, ripropone anche il tema paolino della Prima lettera ai Corinzii (1 Cor. 13, 12: Videmus nunc per speculum in ænigmate: tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte: tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum), che aveva dato spunto (e titolo) al film del 1961, Såsom i en spegel (Come in uno specchio). Gli specchi sono strumenti di ambiguità, mostrano e nascondono: se Karin crede infine di riconoscere dio in un ragno mostruoso e si perde definitivamente nella sua follia, al cospetto della rivelazione dionisiaca il Giudice mormora “capisco” e muore. Ma già nello Smultronstället (Il posto delle fragole, 1957) era stata fondamentale, drammaturgicamente, la funzione dello specchio impugnato da Sara in uno dei sogni del vecchio prof. Borg. Del Rito bergmaniano si ricorderà probabilmente il Roman Polansky della Venus à la fourrure (2013), escogitando la sensazionale esibizione bacchica di Emmanuelle Seignier.
Prendendoci l’arbitrio di oltrepassare i capitoli dedicati a Mimmo Jodice, a Tullio Pericoli, a Giuseppe Penone e a Grisha Bruskin – di quest’ultimo, tuttavia, non posso non guardare con fascinazione, da habitué di etruscherie, alle statue frantumate a bella posta, sepolte (e pseudo-etruschizzate) in Toscana, con ribaltamento speculare dell’esplorazione stratigrafica e delle sue varie metafore (da Benjamin a Freud) – crediamo di riconoscere una delle incursioni criticamente più produttive nell’analisi delle videoinstallazioni di Bill Viola. Qui si attua un processo di sacralizzazione del quotidiano attraverso una sintassi che si modella sull’esempio di predelle e polittici; così come il perturbante affioramento (alla lettera!) del Cristo morto di Masolino nel video Emergence (2002) o le filigrane memoriali della Visitazione del Pontormo, evocata di traverso agli alitanti sottanoni veterosessantotteschi di The Greeting (1995), e dell’Assunta rosso-fiammeggiante di Tiziano illividita nel blu marino dell’Ascension d’Isolde (2005, riproposta anche in Italia, nel 2012-2013, nella stupenda mostra di Palazzo Fortuny a Venezia sul wagnerismo nelle arti visive), ci svelano una religiosità non confessionale, tutt’altro che estranea alla tradizione liturgica dei quadri viventi medievali. Non è forse inappropriato richiamare modi comparabili di (ri)costruzione di una sacralità latente in esperienze innovative della pratica registica di questi anni: in Italia viene da pensare soprattutto a Emma Dante, al suo Duncano magro ed esausto come un Cristo gotico, in chiusura del I atto del Macbeth verdiano, o all’irruzione improvvisa del tableau di Niccolò dell’Arca a stilizzare per sempre il lutto di Lucia e Santuzza, nel finale di Cavalleria (2017).
Un altro saggio ci porta ad accostare la gemellarità, se così si può dire, che apparenta paradossalmente l’occasione e l’eterno, ciò che forse intendevano gli antichi Greci con una parola un po’ misteriosa: kairos. Si tratta del colossale fregio dei Triumphs and Laments creato nel 2016 da William Kentridge, con incredibile tecnica d’idrorimozione della patina, su un muraglione del Lungotevere (già similmente utilizzato da Kristin Jones). Il gigantesco mural, destinato progressivamente a svanire e per di più esposto a vandalismi, racconta una storia di Roma per immagini, dalla Lupa di Romolo e Remo fino all’assassinio di Moro, e diventa, in certo qual modo, rivisitazione moderna dei racconti d’immagini delle Colonne coclidi, ma con due differenze cruciali: che la narrazione visiva non si proietta verso l’alto delle apoteosi, ma si svolge tutta in orizzontale, indirizzata e ritmata dal fluire continuo, indifferente (antieroico) del Tevere; e che questa è arte breve, all’atto di nascita già malata terminale, che ricapitola programmaticamente tutto il suo passato, lontano o recente, per esporlo alla precarietà e alla cancellazione.
Detto infine che, nella repulsiva Leda di Dana Schutz (The Visible World, 2018), l’icona camuffata è, molto più di altre, il Sogno del Douanier (1910) – altra non proprio facile recognition – sembra venuto il momento di azzardare qualche conclusione di carattere generale.
La categoria storico-culturale della cosiddetta fortuna dell’antico – articolata nelle varie declinazioni del dialogo, della recezione, del riuso, della complementarità di survival e revival e via discorrendo – espone forse al rischio di quella che si potrebbe dire una banalizzazione storicistica. Se infatti l’antico, nonostante certe sue ingannevoli intermittenze, non muore mai, e di puntualizzarne morti e rinascite – ce l’ha insegnato proprio Settis – abbiamo bisogno solo come di un espediente strutturale all’esercizio della narrazione storica, la relazione a tre, che abbiamo sopra descritto, fra l’artista, il committente e il critico d’arte, si costituisce nel tempo come un processo conoscitivo continuo e costantemente contemporaneo. L’atto di memoria, che pure è all’origine dello storicismo, finisce in verità per destrutturarlo o, più esattamente, per svelarne i connotati rassicuranti ma fragili di utopia.
Quando nel game of recognitions si consuma vertiginosamente una distanza temporale di secoli, i contesti di pertinenza originaria delle immagini d’arte si scolorano, e viene a crearsi un nuovo loro contesto, che è quello dell’Erinnern, per dirla con Goethe, o di Mnemosyne, per dirla con Warburg. L’esercizio agnitivo, dunque, non contestualizza, ma dis-contestualizza, cioè trasferisce l’oggetto di conoscenza, dal contesto in cui esso fu creato, a un nuovo contesto governato dalla memoria. Portare un reperto archeologico nella vetrina del museo è precisamente un’opera di discontestualizzazione, poiché qualunque museo – anche se ortodossamente rispettoso dell’evidenza di scavo e coerentemente progettato per restituirne l’immagine e il significato – rappresenta un contesto altro, dove il medesimo reperto inizia una nuova vita di relazioni conoscitive con gli studiosi e il pubblico.
Possiamo allora immaginarci un meraviglioso museo della memoria, museo degli anacronismi e delle discontestualizzazioni? Sarebbe un luogo prodigiosamente metamorfico, il nascondiglio perfetto per Dioniso.
Riferimenti bibliografici
- Balbi 2016
C. Balbi, Forme del pathos: l’estasi tra fuga e rivoluzione, tesi di laurea, relatori M. Harari e F. Villa, Università degli Studi di Pavia, A.A. 2015/2016. - Bergman 1979.
I. Bergman, Sei film, edizione e trad. it. G. Oreglia, Torino 1979. - Harari 2018
M. Harari, Memoria dell’ordine dorico nel sogno di Hans Castorp. Alcune divagazioni intorno al capitolo Schnee dello Zauberberg di Thomas Mann, in Dialoghi sull’Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo, II, Paestum, 28-30 giugno 2017, a cura di M. Cipriani, A. Pontrandolfo e M. Scafuro, Paestum 2018, 43-56. - Oddo 2014
M.E. Oddo, Appunti per un’analisi dello schema di Endimione in ambito greco-ellenistico, con una galleria iconografica, “La Rivista di Engramma” 122, dicembre 2014, 35-60.
Per citare questo articolo / To cite this article: M. Harari, Dioniso nascosto, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 332-340 | PDF
In una vivace definizione dell’antropologia Alfred Gell affermava nel suo capolavoro pubblicato nel 1998, Art and agency:
In parole povere, l’antropologia è capace di offrire analisi articolate di comportamenti, performance, esternazioni apparentemente irrazionali (il problema del tipo “mio fratello è un pappagallo verde” (Gell [1998] 2021, 17; sul testo di Gell vedi le importanti riflessioni di Pucci 2008).
Nonostante i continui rimproveri da parte di altre discipline, l’antropologia, pur a fasi alterne, è rimasta fedele alle sue origini, quelle che hanno prodotto Il ramo d’oro di Frazer, ma anche il saggio sul dono di Marcel Mauss. L’antropologo che dovrebbe essere fedele al suo lavoro di campo, attenersi al singolo gruppo umano di cui può rendere conto avendoci vissuto in mezzo, in realtà viene subito trascinato altrove. Per il fatto stesso che egli o ella viene da altrove è costretto e costretta a rimarcare le differenze e le similarità tra almeno due luoghi, quello che gli/le è abituale e quello che per mestiere sta vivendo. Questa contraddizione è stata più volte causa di blocchi e di critiche. Con che diritto l’antropologia pensa di poter trovare caratteri comuni in mondi così lontani? Come si permette di deviare da un sano relativismo per cui ogni gruppo umano ha le sue ragioni e invece si serve proprio di uno sguardo comparativo per tirare delle conclusioni? Se Lévi-Strauss non avesse avuto l’idea di paragonare tra loro le strutture della parentela avrebbe mai applicato lo stesso metodo alla mitologia amerindia? E che dire poi di quegli antropologi che addirittura paragonano la guerra nel Peloponneso alla guerra in Polinesia come si è permesso Marshall Sahlins, scavalcando gli steccati disciplinari e invadendo il campo degli storici con un immodesto comparativismo, Tucidide e le saghe tahitiane e hawaiane? Il comparativismo è imbarazzante. Marcel Detienne ha resistito a lungo ad accettarne le conseguenze e da bravo grecista ha sempre fatto prevalere la timidezza. È possibile paragonare il pantheon greco a quello induista? O peggio: è possibile paragonare gli dei della Grecia agli Orixas afro-caraibici? Tutto ciò per molti studiosi solleva lo spettro di un terribile ritorno al passato, agli albori delle “scienza delle religioni” e alle teorie diffusioniste, per cui gli indiani d’America erano i resti delle disperse tribù d’Israele. Eppure nel comparativismo c’è una istanza ‘ideale’ molto importante, quella della ricerca di aspetti universali nelle manifestazioni dell’animo umano. Salvatore Settis fa rimarcare che una delle grandi novità della critica d’arte oggi è stata l’avere messo da parte un certo provincialismo dell’arte contemporanea e avere compreso che l’arte è una manifestazione universale. Come rimarcava Gell:
L’arte delle culture non occidentali non è sostanzialmente diversa dalla nostra , perché viene prodotta da artisti che sono individui dotati di talento e di immaginazione e a cui dovrebbe essere riconosciuto lo stesso valore che viene riconosciuto agli artisti occidentali, invece di considerarli come puramente naturali, esseri istintivi che esprimono spontaneamente bisogni primitivi, o, in alternativa, passivi seguaci di un rigido stile tribale (Gell [1998] 2021, 4-5).
Salvatore Settis riprende il comparativismo impertinente di Aby Warburg, quel permettersi di accostare cose tra di loro diversissime, una pubblicità di saponette e la Venere di Milo. La sua operazione ha una dimensione iconoclasta di cui si è parlato troppo poco. Nel suo mettere accanto Warburg enhances, accresce il valore di certe immagini o di certe opere, ma allo stesso tempo ne distrugge l’aura. Al pari di Marcel Duchamp, sembra di volerlo fare per ragioni diverse, ma che convergono allo stesso fine:
Questo gesto iconoclasta è un modo per privare l’artista della sua aura, per sminuire il suo statuto all’interno della società (Roberts [1953] 1968, 62).
Accostare due opere, due immagini, foto, pubblicità, vita quotidiana e manifestazioni artistiche significa sottrarre alle opere quella ‘incertezza evocativa’, quel parlare di cose lontane, quella brezza, aura, che Benjamin definiva appunto come improvviso insorgere di una nostalgia del lontano e dell’altrove. Mettere accanto uno scudo Maori e un Botticelli significa inchiavardarli su un presente che è importante per chi cerca un parallelo, un effettivo richiamo, un ‘tenersi’ all’ora e qui delle manifestazioni umane. Aby Warburg è stato un grande rinnovatore della contemporaneità delle manifestazioni dell’arte, dell’artigianato, dei manufatti, delle performances, delle ritualità. Attraverso di lui il ponte che tiene unita Arte e Antropologia è diventato percorribile, pericolosamente, ma percorribile. Non è un caso che la sua visita agli indiani Hopi sia immediatamente non un recupero di un passato in via di sparizione, ma una attualizzazione dello stesso spirito Hopi:
Non sono certo souvenir di viaggio le foto che lo vedono ritratto insieme a un indiano pueblo e poi con indosso una maschera da pellerossa. Durante un’escursione tra gli indiani hopi del Nuovo Messico, Warburg si imbatté in un rito con il quale i nativi avevano imparato a domare i serpenti a sonagli affinché questi non li mordessero nel corso della cerimonia con rettili che durava un’intera settimana. […] Rispetto alla teoria delle maschere di Claude Lévi-Strauss, Warburg si distingue nell’ambito delle teorie culturali scaturite da un’esperienza etnografica diretta nel non prendere come presupposto la linguistica strutturale, bensi la teoria tutta espressiva degli schemi corporei, dei gesti, delle azioni (Bredekamp [2010] 2015, 239-240).
Quando Warburg arriva in mezzo agli indiani Pueblo, questi stanno vivendo una profonda trasformazione, una forma di risposta al mondo dei colonizzatori, la rielaborazione di una mitologia che consenta loro di contrastare alla invadenza dell’uomo bianco con una ritualità rinnovata. Warburg non arriva da accademico che ne ha studiato il passato, ma come qualcuno che vuole dall’osservazione del presente trarre una teoria delle emozioni Hopi.
Mediante i suoi elementi di reciprocità, Warburg fissò il pathos come reazione corporea, momentaneamente intensificata, di un’anima scossa nei confronti dell’ethos inteso come elemento caratteriale fondante, propenso a operare un controllo delle emozioni a mo’ di “formula” (Bredekamp [2010] 2015, 243).
Cosi la danza con i crotali degli Hopi – che sottintende una ritualità di superamento della paura – si riflette nella iconicità dell’arte classica e rinascimentale, ma anche nelle immagini ritagliate dai giornali che mostrano situazioni simili. Una teoria che attraversa la stilizzazione delle emozioni dalla gestualità alla storia delle immagini. È una impertinenza nei confronti sia dell’approccio antropologico che di quello della critica d’arte. Ma è anche ciò che Freedberg sta preparando nella sua analisi di ciò che ‘l’arte’ fa, quella dimensione dell’arte come affecting presence di cui negli Stati Uniti Armstrong sta trattando nei suoi corsi di estetica. Approfondiamo un attimo la questione dell’impertinenza. È impertinente chi si ‘distrae’ rispetto a un campo, chi prende la via del cavallo negli scacchi, chi si occupa di qualcosa che non c’entra. È impertinente ciò che esula dalle direttive spazio temporali. Nel caso di Warburg c’è una infrazione cumulativa, non solo impertinenza spaziale, geografica, culturale, ma impertinenza temporale, storica, epocale. Eppure questo è proprio l’approccio che accomuna artisti e antropologi. Entrambi operano in una dimensione che fa dell ‘esulare’ il proprio metodo. Gli artisti escono fuori dal campo seminato, gli antropologi vanno a fare campo nel campo altrui. Questa dimensione comparativa come metodo ci riporta all’intuizione di Salvatore Settis rispetto a Warburg. È una chiave che pone l’universalismo dell’arte come espressione umana al centro della propria ricerca. L’arte come affecting presence, fenomenologia delle emozioni, ricorrenza di come i corpi – umani, ma anche delle altre presenze nel mondo, animali, alberi, nuvole, pietre – rispondono alle emozioni. È per certi versi un superamento della dimensione estetica come posta dalla critica d’arte classica. Qui c’è una fenomenologia del fare e dello stare che prevalica. Non è l’occhio esterno che giudica ciò che è bello o meno, è il corpo che si esprime:
In questo gesto si esprime la volontà di fare scendere l’arte dalle sue vette eteree, di ricollocare la questione del gusto in un luogo diverso da quello in cui si è fisicamente e originariamente posta, vale a dire il corpo, luogo per eccellenza in cui si scontrano il bello e il brutto, il nobile e l’ignobile, lo sporco e il pulito … (Marcadé [2007] 2009, 181).
A questo punto però subentra un’altra dimensione. Guardiamo direttamente al gesto che fa Warburg quando attacca le immagini ritagliate da giornali, strappate a pagine di libri, fotografate, e le mette su una parete verticale. Pensate a quel gesto, di comporre, guardarsi intorno, spostare, affiancare, correggersi, affiancare diversamente. Non vi richiama il gesto di una cartomante, o meglio di un indovino, della Pizia che accosta le foglie per leggervi i segni, degli auguri cinesi che mettono accanto le ossa scaldate al fuoco su cui si sono formati dei segni? Michael Taussig – è sua l’intuizione in Mimesis and Alterity (Taussig 1993) – parla dello sciamano Cuna il quale dice che ogni comparativismo è una forma di divinazione. Anzi, richiamando Walter Benjamin, dice che ogni collezione è una forma di divinazione. Chi mette accanto francobolli, opere d’arte, porcellane (come Utz di Chatwin), referti criminali, farfalle, pietre (come Callois), poesie, nuvole, fa una operazione dove l’accostamento degli elementi ‘rivela’ qualcosa che era nascosto nei singoli componenti e che può solo sorgere dalla casualità degli accostamenti. C’è nelle collezioni un tirare le sorti che è fondamentale per ‘aggirare’ la ragione e rispondere alla frase “mio fratello è un pappagallo verde”. Per questo motivo l’impertinenza è il metodo più vicino alla scoperta. Non si possono tirare le sorti per deduzione o per induzione, ma per una forma di ‘abduzione’, è l’imprevisto che nasce dal mettere accanto cose che non c’entrano a essere il metodo dello sciamano, dell’augure, dell’indovina. È un modo di rimescolare le carte. Per cui chi cerca in Mnemosyne un percorso coerente ne rimane tradito. È la casualità, oltre che all’occhio geniale che pone accanto le pieghe delle vesti delle ninfe. Ma oltre il comparativismo il meglio viene quando l’occhio vi cade sull’immagine che avevate trascurato ma che è subito sotto di voi. Come quando si fa ricerca negli archivi la scoperta è nel cassettino sotto al quale state cercando, nel titolo che viene fuori perché le vostre dita hanno farfugliato tra i files.
Questo aspetto è una volta di più ciò che lega artisti e antropologi. Sul campo l’antropologo scopre che le cose a cui aveva meno fatto attenzione sono proprio quelle che gli danno la chiave per capire il senso dei movimenti, dei canti, delle relazioni. Scopre nei propri diari di campo cose che non aveva percepito, oppure scopre nella dichiarazione dell’amico informatore con cui aveva appena danzato e che dice “Ora che abbiamo danzato siamo amici e quindi ti posso uccidere”, la cosmologia di predatore/preda che regge il mondo amazzonico. Ugualmente nella ricerca dell’artista non è quello che vi lega al già fatto, non è la cornice delle opere altrui, non è il mondo dell’arte a voi contemporaneo ed è tutto questo insieme, che assortito, rimescolato, scompaginato, perduto e ritrovato vi apre all’opera che diventa il vostro presente.
Riferimenti bibliografici
- Bredekamp [2010] 2015
H. Bredekamp, Immagini che ci guardano, Teoria dell’atto iconico [ed. or. Theorie des Bildakts; Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2007, Berlin 2010], trad. it. S. Buttazzi, a cura di F. Vercellone, Milano 2015. - Gell [1998] 2021
A. Gell, Arte e agency. Una teoria antropologica [ed. or.: Art and Agency. An Anthropological Theory, Oxford 1998], trad. it. G. Policastro, Milano 2021. - Marcadé [2007] 2009
B. Marcadé, Marcel Duchamp, La vita a credito [ed. or.: Marcel Duchamp: la vie à crédit, Paris 2007], tr it. X. Rodriguez, Milano 2009. - Pucci 2008
G. Pucci, Agency, oggetto, immagine. L’antropologia dell’arte di Alfred Gell e l’Antichità classica. Una riflessione critica sulla teoria dello studioso inglese applicata all’arte greca e romana, “Ricerche di Storia dell’Arte” 94 (2008), 35-40. - Roberts [1953] 1968
F. Roberts, I propose to Strain the Laws of Physics, Interview with Marcel Duchamp [1953], “Art News” 67/8, December 1968, 46-47, 62-64. - Taussig 1993
M. Taussig, Mimesis and Alterity. A Particular History of the Senses, New York, London, 1993.
Per citare questo articolo / To cite this article: F. La Cecla, A. Castelli, Impertinenza dei comparativisti, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 341-346 | PDF
Con il volume Incursioni. Arte contemporanea e tradizione, Salvatore Settis propone un viaggio avvincente sotto la guida di Mnemosyne, la madre delle Muse che ha dato anche il nome al celebre atlante warburghiano; si delinea in questo itinerario una “perpetua tensione” (Incursioni, alla pagina 11) tra il contemporaneo e una tradizione figurativa e culturale che si dipana dagli Antichi fino a noi, e che noi stessi contribuiamo a dipanare nel tempo. In questo intervento, ripercorrendo il penultimo capitolo “William Kentridge: la memoria e la città”, incentrato sull’opera Triumphs and Laments, intendo proporre alcune considerazioni sulla composizione e la lettura di immagini narrative tra antico e contemporaneo. Nello specifico, farò riferimento ad aspetti di opere del Mediterraneo antico che, alla luce delle osservazioni di Settis su Kentridge, acquistano una particolare valenza.
Triumphs and Laments è un fregio monumentale [Fig. 1]: si tratta di una banda figurata continua di andamento marcatamente orizzontale lunga circa 500 m. È una sfilata di personaggi, monumenti e momenti della storia e della memoria collettiva di Roma (e d’Italia), realizzata a Roma nel 2016 tramite idropulitura del muraglione in travertino lungo il Tevere, tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini, e destinata a scomparire progressivamente.

1 | William Kentridge, Triumphs and Laments (nell’ambito del progetto promosso e ideato dall’Associazione Tevereterno Onlus), 2016, Roma. (Photo © Marcello Leotta.)
L’artista si ispira al genere artistico delle rappresentazioni storiche, che veniva utilizzato nell’antica Roma per raffigurare i cortei dei trionfi militari: il murale di Kentridge sembra rappresentare proprio uno di questi eventi in corso di svolgimento, poiché alcune delle immagini sono raffigurate su carri; si possono richiamare a questo proposito gli apparati mobili con rappresentazioni di guerra che sfilarono durante il trionfo sui Giudei di Vespasiano e Tito nel 71 d.C. (J. BJ VII 139-147). È come se le immagini di Triumphs and Laments, estrapolate dai loro diversi ‘passati’, avanzassero lentamente in processione su quella stessa passeggiata che Jep Gambardella percorre in un piano-sequenza de La grande bellezza (a 33’ 12”). Un elemento – quello della finzione della parata – che evoca la “proiezione performativa” concepita originariamente da Kentridge per lo spazio sul Tevere e che ritorna nella processione delle ombre con cui fu inaugurata l’opera (Basualdo, Kentridge 2017, 73, 88).
Nella sfilata di Triumphs and Laments i tanti passati di Roma si materializzano davanti agli occhi dell’osservatore – l’Antichità, il Medioevo, l’Età moderna, il Novecento – in un gioco di sintesi temporale che Settis analizza nel dettaglio (Incursioni, alle pagine 300-302). In antico, l’articolazione temporale in un campo figurato esteso poteva trovare espressione nel succedersi di episodi legati a un singolo personaggio; ne è un esempio il Fregio di Telefo dell’Altare di Pergamo, che narrava le vicende dell'eroe secondo una meditata sequenza temporale. Invece, nell’opera di Kentridge è come se tutto diventasse presente in una rappresentazione simultanea (e per questo significante) di episodi temporalmente distinti. Questo approccio può richiamare una delle numerose interpretazioni del Fregio del Partenone, secondo la quale sul fregio orientale sarebbero rappresentati simultaneamente momenti diversi della storia di Atene (Connelly 1996).
Questa libertà nel combinare orizzonti temporali diversi si accompagna a un aspetto ugualmente significativo di Triumphs and Laments sottolineato da Settis: il modo in cui l’artista traspone questa parata di immagini iconiche, ben sedimentate nella nostra memoria, in una dimensione narrativa inedita, che punta a una riflessione critica sulla storia. L’artista, per esempio, intende creare nel fregio un segmento dedicato alle vicende del popolo ebraico, ponendo in sequenza il trionfo nella guerra giudaica sull’arco di Tito [Fig. 2] e altre immagini di persecuzione attraverso i secoli. Ne deriva pertanto una dimensione transcronologica che, inducendo a riflettere sulla storia secolare del popolo ebraico, rovescia il punto di vista dell’immagine trionfale dell’antica Roma. Infatti, l’assunto per così dire programmatico dell’artista, alla base della realizzazione del fregio e del titolo stesso dell’opera, è il seguente: “Per ogni storia che finisce bene, ce n’è sempre un’altra drammatica” (Pappalardo 2015).

2 | Roma, Arco di Tito, Corteo del trionfo giudaico, ca. 81-90 d.C., pannello a rilievo. (Foto: Egisto Sani. Su concessione del Ministero della cultura – Parco Archeologico del Colosseo.)
L’uso flessibile di modelli iconografici in diversi contesti figurativi fa parte di una lunghissima tradizione di pratiche di bottega profondamente legate ai ‘ferri del mestiere’ dell’artista (modelli, disegni, patroni), che garantiscono la lunga vita di schemi come le Pathosformeln (Settis 2012). Cito qui un caso pertinente a una cosiddetta area di contatto, dove l’uso flessibile di modelli suggerisce lo sforzo da parte degli artisti di adattarsi a uno specifico contesto culturale e alle richieste della committenza. All’inizio del IV sec. a.C. scultori di formazione ellenica realizzarono a Trysa, nell’antica regione della Licia (Anatolia sud-occidentale, odierna Turchia), una tomba dinastica ricca di fregi con scene tratte dalla vita del dinasta e immagini ispirate al mito greco.

3 | Fregio della mnesterofonia di Trysa: Penelope con le serve (sx); Odisseo con Telemaco (dx), 380-370 ca., Vienna, Kunsthistorisches Museum, disegno da O. Benndorf, G. Niemann, Das Heroon von Gjölbaschi-Trysa, Wien 1889, tav. VII.
Tra queste compariva la mnesterofonia, l’uccisione dei pretendenti di Penelope, composta da due scene [Fig. 3]: la rappresentazione di Odisseo e Telemaco, che uccidono i proci nella sala del banchetto del palazzo di Itaca, ha come pendant, in maniera inconsueta rispetto alla tradizione iconografica, Penelope con le serve. Qui, per la consorte di Odisseo non viene utilizzata la ben nota iconografia di Penelope seduta e pensierosa, ma è impiegato uno schema diverso, riconducibile in altri contesti a Era, consorte di Zeus. La Licia aveva un sistema politico basato su dinastie locali, nella cui ideologia il circolo familiare aveva molta importanza nella gestione e trasmissione del potere; per questo, in Licia la rappresentazione delle coppie dinastiche nei programmi figurativi funerari rivestiva particolare rilevanza. Il processo di bricolage artistico in azione a Trysa riflette dunque l’esigenza di un adattamento al contesto locale: l’artista sceglie nell’ambito del proprio patrimonio figurativo lo schema iconografico più idoneo alla necessità di rappresentare Penelope, in quanto consorte regale, nel pieno esercizio del suo potere sulla casa (Poggio 2007).
Il procedimento di bricolage adottato in Triumphs and Laments è diverso rispetto al caso licio: Kentridge vuole che l’osservatore riconosca le immagini di partenza in quanto parte della memoria collettiva; prendendo le mosse da quel bagaglio culturale consolidato, punta poi a risemantizzarle, manipolandole o associandole attraverso un particolare meccanismo narrativo. Ci soffermiamo su questo secondo metodo. Come afferma Settis a proposito delle diverse unità del fregio, “la loro stessa contiguità ne riattiva le potenzialità espressive, il nucleo di pathos, la capacità di narrare, di scontrarsi fra loro, di convergere in un nuovo racconto” (Incursioni, alla pagina 323). Non è questo un procedimento del tutto estraneo a complessi figurativi antichi: si pensi per esempio alla lettura a pendant proposta per alcune case pompeiane (Brilliant [1984] 1987, 53-90) oppure alle corrispondenze verticali della Colonna Traiana (Settis 1988, 202-219), strategie che si basano sull’associazione – come su diversi assi cartesiani – di immagini o segmenti per progettare la composizione e costruire percorsi di lettura.
Nell’opera di Kentridge il procedimento agglutinante e associativo lungo lo sviluppo orizzontale del fregio ha però uno scopo diverso: disinnescare il pericolo di una lettura univoca della storia e moltiplicare i punti di vista, come nel caso del segmento del popolo ebraico. Questa esigenza trova un’importante risonanza nel vivace dibattito contemporaneo riguardo ai monumenti pubblici che commemorano personalità controverse. Così, per esempio, Dawn Foster commenta la complessa vicenda di una statua di Margareth Thatcher:
Statues are only one way to tell us about history, and not even a good one. Murals, plaques marking important events, and public photographic exhibitions are more informative. History deserves to be in the public space and debated in the public realm. Growing up, I learned much about local history from murals commemorating the Chartist uprising and immediate murderous suppression of protestors in Newport, and a huge amount from almost every gable wall in Belfast. A statue of a prime minister has never taught me anything, bar the fact that too many of these people looked the same (Foster 2019).
In queste righe si esprime una preferenza per forme di commemorazione di carattere informativo rispetto a immagini iconiche di celebrazione che tramandano effigi di personaggi storici senza fornire elementi utili a contestualizzarne le azioni.
È indubbio che immagini iconiche e immagini narrative, seguendo codici specifici, offrano diverse potenzialità espressive. Se si torna alla Colonna Traiana, il monumento unisce la tipologia della colonna onoraria, originariamente con la statua di Traiano in cima, e la tradizione del rilievo narrativo. Queste due modalità – iconica e narrativa – convivevano nello stesso monumento in maniera complementare, poiché entrambe concorrevano alla gloria dell’imperatore Traiano. Più avanti nei secoli, ritroviamo nel sistema della pala d’altare l’associazione tra linguaggio iconico e narrativo, ma con una gerarchia più netta: come sottolinea Settis nelle pagine di Incursioni su Bill Viola, la predella è “come un esergo o commento narrativo” della pala d’appartenenza (Incursioni, alla pagina 243). Kentridge, dunque, sfrutta questa tensione tra linguaggio iconico e narrativo: associando le immagini iconiche lungo il fregio, riesce a mutarne il messaggio e il significato di partenza proiettandole in una dimensione narrativa.
Come ho detto in precedenza, la scelta delle diverse unità che compongono Triumphs and Laments e la loro disposizione è funzionale all’idea che trionfi e lamenti siano due aspetti complementari. Kentridge si ispira alle antiche rappresentazioni di trionfo, ma Settis rileva una sostanziale differenza rispetto a quella tradizione, che si basava su una “tacita regola del gioco, esaltare vittorie e successi nascondendo sconfitte e sofferenze” (Incursioni, alla pagina 275) e, in riferimento a Roma, rimarca che “gli imperatori trionfano solo e sempre, e così i loro eserciti … i soldati romani non muoiono mai” (Incursioni, alla pagina 279). Enumerare immagini di trionfatori nell’Antichità richiederebbe una rassegna tale da abbracciare un arco cronologico molto ampio e contesti geografici disparati. Vorrei invece citare un caso antico in cui, nonostante la rappresentazione di un fallimento, la “regola del gioco” menzionata da Settis non è intaccata.
Sul cosiddetto Sarcofago del Satrapo della Necropoli Reale di Sidone (antica Fenicia, nell’odierno Libano), opera in marmo dell’ultimo quarto del V secolo a.C., il dinasta locale è impegnato in una caccia [Fig. 4]: lasciatosi alle spalle un cervide ormai accasciato, è concentrato su una preda più pericolosa, una pantera, coadiuvato da un altro cacciatore a cavallo. A destra, invece, uno dei membri dell’entourage, disarcionato, ma aggrappato alle redini del proprio cavallo, viene trascinato via. Gli incidenti sono un topos dei racconti mitici di cacce, ma in questo caso l’incidente non ha alcun carattere eroico, poiché mette in luce la difficoltà di controllare il cavallo imbizzarrito senza mostrare un confronto diretto con la fiera. La presenza di questo episodio di fallimento in una scena che mira a celebrare le gesta del cacciatore principale ha destato perplessità, ancor più perché nel corpus dei Sarcofagi di Sidone il ruolo dell’attività venatoria nell’ideologia regale appare particolarmente importante. In realtà, in questo e altri casi coevi di scene di caccia dinastica del Mediterraneo orientale, il fallimento è sì contemplato sotto forma di incidenti, ma viene riferito all’entourage, piuttosto che al dinasta stesso, per non comprometterne la celebrazione in un’immagine fissata per sempre: in tal modo, l’incidente riflette su un personaggio secondario le difficoltà dell’impresa affrontate dal committente, trasformandosi in un amplificatore della sua gloria (Poggio 2011).

4 | Scena di caccia del c.d. Sarcofago del Satrapo da Sidone, ultimo quarto del V sec. a.C., Istanbul, Museo Archeologico, inv. 367. D-DAI-IST-70/42. (Foto: W. Schiele.)
Corollario della “regola del gioco” evocata da Settis è il “‘buco nero’” (Incursioni, alla pagina 294), corredato dalla scritta “QUELLO CHE NON RICORDO”, che Kentridge inserisce nel fregio bicolore sul Tevere. Oltre alla lettura che ne dà l’artista stesso – “una più intima perdita di memoria” (Basualdo, Kentridge 2017, 77) – possiamo interpretarlo come un ammonimento: è l’artista ad avere selezionato le immagini, operando scelte consce su ciò che andava incluso o escluso, ma anche inconsce, a seconda di quel che gli veniva in mente (in questo caso, poi, bisogna precisare che una selezione preliminare era stata operata per Kentridge da altre persone). Questo caveat può essere applicato anche a opere del passato: la convenzione di ignorare sconfitte e sofferenze si basa infatti su una necessaria selezione da parte di artisti, committenti e consiglieri in una dinamica ben codificata (Settis 2010).
Come è stato detto, caratteristico di Triumphs and Laments è combinare rappresentazioni tradizionalmente associate al trionfo con immagini iconiche che richiamano momenti dolorosi; un aspetto particolare è l’evocazione di episodi traumatici vicini nel tempo, ancora vividi nella memoria collettiva, come il rinvenimento del corpo di Aldo Moro. Anche questo modo di procedere è consono alla sensibilità contemporanea. In antico, rievocare eventi dolorosi vicini nel tempo era problematico, come dimostra una testimonianza a proposito di Atene. Erodoto racconta come Frinico, nei primi anni del V secolo a.C., ponesse al centro del suo dramma La presa di Mileto un evento avvenuto poco tempo prima, nel 494 a.C.: la caduta di Mileto, città ionica sull’opposta sponda dell’Egeo, per mano dei Persiani. Lo storico greco racconta che di fronte alla messa in scena il teatro scoppiò in lacrime: Atene si sentiva legata a Mileto per comunanza di stirpe, per questo Frinico fu multato con l’accusa di aver richiamato alla memoria sciagure familiari (ὡς ἀναμνήσαντα οἰκήια κακά) e il dramma fu vietato (Hdt. VI 21).
La scelta del tema storico da parte di Frinico appare inconsueta alla luce di tutta la produzione tragica ateniese, dato che i soggetti mitologici risultano di gran lunga i favoriti. Il soggetto di Frinico, tuttavia, era coerente con il clima di fermento nell’Atene di quegli anni: basti pensare alla realizzazione del gruppo dei Tirannicidi di Antenore dopo il 510 a.C., razziato dai Persiani e poi ricreato nel 477/6 a.C. da Crizio e Nesiote (Hölscher 1973, 85-88). Questo gruppo scultoreo evocava un evento reale di pochi anni prima, l’agguato mortale a Ipparco, uno dei due figli di Pisistrato, da parte di Armodio e Aristogitone. Nell’opera spicca l’atteggiamento eroico degli aggressori e, significativamente, manca la vittima: fu quello un episodio traumatico, che però fu celebrato nella memoria collettiva come snodo decisivo del passaggio dalla fase tirannica di Atene a quella democratica. La rappresentazione teatrale della presa di Mileto, invece, richiamava alla memoria un evento drammatico che non rivestiva alcun ruolo positivo nel discorso collettivo; tale rievocazione avrebbe assunto addirittura un carattere di denuncia poiché il soccorso di Atene alla città ionica fu inefficace (Amm. Marc. XXVIII 1 3-4). Nella sua opera Kentridge sembra seguire il modello (fallimentare nell’Antichità) di Frinico: non esita a ricordare quegli οἰκήια κακά di cui parla Erodoto, momenti drammatici che non solo sono estranei a qualsiasi logica celebrativa, ma, anzi, sono parte di una riflessione critica nella comunità a cui è destinata l’opera.
Queste considerazioni, non esaustive né sistematiche, fanno comprendere quanto la lettura di Incursioni sia stimolante sotto diversi punti di vista. Settis, infatti, non intende ‘riscuotere’ i debiti che gli artisti degli ultimi decenni hanno cumulato nei confronti dei loro predecessori, in un mero catalogo di riprese e di modelli; egli compone, invece, un prezioso dossier d’inchiesta su quanto l’arte contemporanea, in maniera più o meno consapevole, sia nutrita dalla tradizione precedente, esplorando la dimensione culturale di questi meccanismi. Pertanto, nel percorso proposto in Incursioni il passato non viene semplicemente prima del presente, ma è parte del presente; come afferma Jean-Pierre Vernant, a proposito della memoria in Esiodo, “il ‘passato’ è parte integrante del cosmo; esplorarlo significa scoprire ciò che si dissimula nelle profondità dell’essere” (Vernant [1965] 2001, 101).
Lo sguardo ampio adottato da Salvatore Settis permette così di cogliere aspetti complessi dell’arte contemporanea, ma anche di comprendere fenomeni attuali come gli attacchi recenti a monumenti pubblici. Non da ultimo, l’analisi di Settis del contemporaneo alla luce della tradizione favorisce un rapporto più immediato con l’antico e consente di coglierne al meglio le specificità.
Riferimenti bibliografici
- Basualdo, Kentridge 2017
C. Basualdo, W. Kentridge, In People’s Memory. Carlos Basualdo in Conversation with William Kentridge / Nei ricordi della gente. Carlos Basualdo intervista William Kentridge, in W. Kentridge, Triumphs and Laments, edited by C. Basualdo, Köln 2017, 49-72, 73-96. - Brilliant [1984] 1987
R. Brilliant, Narrare per immagini. Racconti di storie nell’arte etrusca e romana [ed. or.: Visual Narratives. Storytelling in Etruscan and Roman Art, Ithaca 1984], trad. it. B. Draghi, Firenze 1987. - Connelly 1996
J.B. Connelly, Parthenon and Parthenoi: A Mythological Interpretation of the Parthenon Frieze, “American Journal of Archaeology” 100 (1996), 53-80. - Foster 2019
D. Foster, A statue of Margaret Thatcher? No plinth will be too high for the vandals, “The Guardian” (5th February 2019). - Hölscher 1973
T. Hölscher, Griechische Historienbilder des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr., Würzburg 1973. - Pappalardo 2015
D. Pappalardo, Via libera a Kentridge. “Il mio omaggio a Roma dai Cesari a Fellini”, “La Repubblica” (16 settembre 2015), 48. - Poggio 2007
A. Poggio, Il fregio della mnesterofonia a Trysa, in F. de Angelis (a cura di), Lo sguardo archeologico. I normalisti per Paul Zanker, Pisa 2007, 63-76, 303-306. - Poggio 2011
A. Poggio, Incidents in dynastic hunts in Lycia and Phoenicia, in K. Duistermaat, I. Regulski (eds.), Intercultural Contacts in the Ancient Mediterranean, Proceedings of the International Conference at the Netherlands-Flemish Institute in Cairo, 25th to 29th October 2008, Leuven, Paris, Walpole, MA 2011, 479-493. - Settis 1988
S. Settis, La Colonna, in S. Settis, A. La Regina, G. Agosti, V. Farinella, La Colonna Traiana, a cura di S. Settis, Torino 1988, 45-255. - Settis 2010
S. Settis, Artisti e committenti fra Quattro e Cinquecento, Torino 2010. - Settis 2012
S. Settis, Aby Warburg, il demone della forma. Antropologia, storia, memoria, “La Rivista di Engramma” 100 (settembre/ottobre 2012), 271-289. - Vernant [1965] 2001
J.-P. Vernant, Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica [ed. or.: Mythe et pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique, Paris 1965], trad. it. M. Romano e B. Bravo, Torino 2001.
Per citare questo articolo / To cite this article: A. Poggio, Immagini narrative tra antico e contemporaneo: alcune riflessioni, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 347-357 | PDF
Il fregio disarticolato di William Kentridge. Dalla memoria di antichi trionfi ai lamenti sopiti della storia di Roma
Valentina Porcheddu

William Kentridge, Morte di Remo, 2016, Roma, Lungotevere.
“Decorazioni effimere che imitano l’eterno, in una città dove l’eterno è rovina”, scrive Salvatore Settis (Incursioni, alla pagina 422) riferendosi ad “archi trionfali, decorazioni di ponti, edicole e padiglioni, colonne, obelischi e guglie, castelli e trofei, fontane, carri e carrozze, palchi e teatri, facciate posticce” ovvero a quella scenografia del trionfo che dall’Antichità al Medioevo vide sfilare per le strade di Roma imperatori e papi. Tuttavia, questo paradigma ben si adatta anche a Triumphs and Laments, l’opera alla quale, nel volume edito da Feltrinelli, Settis dedica il denso capitolo intitolato William Kentridge: la memoria e la città. Il fregio realizzato nel 2016 dall’artista sudafricano sul Lungotevere può infatti definirsi una decorazione ‘fuggitiva’ che, nel rievocare storia e storie di Roma, si dissolve nell’imperituro orizzonte delle rovine – materiali e metaforiche – della Città eterna. Di questo considerevole progetto di arte pubblica e urbana venuto a scuotere un fiume fecondo eppure immobile, Settis descrive la genesi e il lascito, confrontandosi con i chiaroscuri di un popolo millenario narrato ‘per via di levare’ nel muraglione di travertino tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini. La memoria collettiva, concetto ostico – dai confini labili e a tratti dolorosi – che arriva a toccare il suo contrario, l’oblio, è qui analizzata attraverso lo sguardo raffinato e aguzzo dello studioso di rango, la cui prospettiva non elude un approccio antropologico e sociale alla ricezione dell’arte e ai suoi sovvertimenti. In questo capitolo del libro, Settis carpisce le dinamiche beffarde di un artista engagé qual è Kentridge trascinando il lettore/spettatore nell’esplorazione estetica ed estatica di un’opera in cui la solida pietra che servì a costruire l’Anfiteatro Flavio diviene fragile tela per un teatro d’ombre evanescenti. Kentridge muove dal desiderio di riscattare le troppe sofferenze che i trionfi celebrati a Roma hanno nascosto dietro a traboccanti fasti.
Nell’arte romana nemmeno gli imperatori uccisi muoiono mentre carri ricolmi di bottino, prigionieri spogliati del sé e teste coronate d’alloro abitano fonti letterarie e colonne coclidi. Persino Andrea Mantegna, nei Trionfi di Cesare dipinti per i Gonzaga di Mantova dal 1485 in poi, non ha che elogi per la guerra fatta di insegne e di trofei. Al contrario, Triumphs and Laments è – come spiega Settis – “una sequenza che mescola l’alto e il basso, la gloria e l’abiezione, la gioia dell’arte e i tormenti della morte” (Settis, Incursioni, alla pagina 424). Germogliato nello studio di Kentridge a Johannesburg, il progetto ha avuto un lungo processo creativo. I disegni a carboncino su carta – perlopiù riutilizzata da registri contabili – sono stati fotografati e proiettati su fogli bianchi, per poi mutare nuovamente in disegni, di dimensioni leggermente maggiori, a inchiostro di china. Fotografate in bianco e nero e poi convertite in files digitali, le figure tagliate, ricomposte e capovolte di Kentridge sono state trasformate a Roma in grandi stencils di plastica bianca di altezza variabile (fino a dodici metri). Calati singolarmente dall’alto del parapetto del Lungotevere, gli stencils di Kentridge sono stati quindi appoggiati al muraglione nel luogo prescelto. La fase successiva ha comportato l’intervento di alcuni operai che, servendosi delle sagome come guida, hanno rimosso con violenti getti d’acqua una parte della patina nerastra che copriva i blocchi di travertino. Il nero dello smog che abitualmente s’impossessa delle rovine urbane è stato risparmiato dagli idropulitori mentre i vuoti degli stencils hanno propiziato lo svelamento del bianco che caratterizza l’arcaica pietra di ‘Piazza Tevere’. La raccolta dei ‘cartoni’ da visionare per la selezione dei soggetti è stata approntata da Kristin Jones e Lila Yawn, in collaborazione con gli studenti della John Cabot University di Roma, partendo dalle origini mitiche dell’Urbe. La stratificazione della memoria – che è perno del lavoro di Kentridge – si manifesta nel fregio attraverso un repertorio di temi, figure e posture proprie dell’Antichità, ai quali vengono sovrapposte, con una pertinenza per nulla ideologica e invece profondamente empatica, simboliche presenze di epoche lontane. Così, in una processione trionfale ricalcata sul ritmo della Colonna Traiana, Kentridge accosta il cadavere di Remo – ucciso, secondo la tradizione, nel 753 a.C. dal fratello Romolo – a quello di Pierpaolo Pasolini, assassinato il 2 novembre 1975 in sordide e controverse circostanze. Le fonti iconografiche che l’artista sudafricano utilizza sono per Remo una celebre illustrazione dal volume Figures de l’histoire de la République romaine, accompagnées d’un précis historique (1799-1800) e, per Pasolini, una foto di cronaca. Al corpo rivolto al cielo di Remo si uniscono le spoglie supine dello scrittore e regista nato a Bologna ma romano di (travagliata) adozione. La ‘disobbedienza’ di Remo si colloca nello stesso solco di empietà di Pasolini e, allo spazio desacralizzato del pomerio e dell’idroscalo di Ostia, si aggiunge un terzo ‘quadro’ situato nell’invisibile Via Caetani. Anche qui Kentridge cita un’immagine tristemente iconica ovvero la famosa foto che mostra il cadavere di Aldo Moro rannicchiato nel bagagliaio di una Renault rossa. A questa istantanea del 9 maggio 1978 si fonde una composizione assai singolare che ingloba una scena ispirata al Grande sarcofago Ludovisi (metà III secolo d.C.) con barbari morenti o sul punto di essere trafitti, sormontata dalla Santa Teresa in estasi di Gian Lorenzo Bernini che ha qui la funzione di una Vergine dolente.
Il collage, di non immediata interpretazione ma di sicuro effetto, consente a Settis di spiegare il procedimento dell’‘anacronismo’ che in Kentridge non indica qualcosa ‘fuori posto’ ma piuttosto, secondo la connotazione che gli diede nel Seicento Giovanni Bellori, “la compresenza, entro un unico spazio pittorico, di momenti o figure storiche lontane nel tempo l’una dall’altra” (Settis, Incursioni, alla pagina 463). Anche nell’antica Roma, rammenta Settis, non mancavano composizioni anacronistiche e collage, come l’Arco di Costantino in cui nel 315 d.C. vennero inseriti non solo rilievi scolpiti ad hoc ma anche sculture di imperatori più antichi – Traiano, Adriano, Marco Aurelio – sostituendone la testa con quella di Constatino. Ma Settis si spinge ancora più in là, attribuendo al grembo di Roma la nascita di un altro potente anacronismo: il Museo, istituzione che lega all’arbitraria giustapposizione di frammenti memoriali la sua ragion d’essere. Si deve tuttavia sottolineare che in Kentridge, il collage non appare né artificio politico né sopruso quanto reminiscenza mossa dal pathos, che trascende le epoche per riportarle a un lamento, sopito nella culla del Tevere, che grida all’universalità atemporale della violenza. Ma se l’artista sudafricano insiste sulla memoria e sui suoi rovesci – emblematica la figura di Mussolini a cavallo, ripresa da un affresco di Giovanni Brancaccio alla Mostra d’Oltremare di Napoli (1940), al quale viene amputato il braccio teso nel saluto fascista – nondimeno denuncia, in una delle pochissime scritte di Triumphs and Laments, ciò che non viene ricordato. Ad essere inghiottito nell’oblio non è solo il passato colonialista dell’Italia rappresentato nel fregio dal carro su cui sfila il re etiope Hailé Selassié ma anche un evento quale la piena del Tevere del 17 dicembre 1937 che costrinse un gruppo di romani a rifugiarsi su una barca. Nell’opera di Kentridge, alla rievocazione di quest’avvenimento tratta da una foto d’epoca fa da controcanto l’immagine che riproduce un instabile barcone di migranti, a sua volta sovrapposto alla nave romana ideata dal pittore spagnolo Ulpiano Checa (1894) per magnificare la naumachia voluta da Cesare in occasione del suo trionfo del 46 a.C.
L’attualità che qui ritorna quasi come un prodotto della street-art accresce dunque pesantemente l’onta della dimenticanza e insegna che non ci può essere memoria senza una coscienza civica costantemente rigenerata. Ed è questo che Salvatore Settis ha evidenziato nel capitolo consacrato, con dovizia di particolari e riflessioni, a un fregio contemporaneo, fatto non per durare ma per porre la comunità dei cittadini davanti al dolo della rimozione.
Per citare questo articolo / To cite this article: V. Porcheddu, Il fregio disarticolato di William Kentridge. Dalla memoria di antichi trionfi ai lamenti sopiti della storia di Roma, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 358-361 | PDF
La sensazione di fondo, nel procedere con la lettura di Incursioni. Arte contemporanea e tradizione, è di profonda familiarità. Il tema del rapporto tra arte contemporanea e tradizione – tradizione classica, tradizione artistica – può essere d’altronde considerata, non solo la premessa da cui ha preso le mosse l’avventura di Engramma, ma anche l’orizzonte entro il quale continua oggi ad orientarsi. Non a caso, a inaugurare i primi passi della rivista ha contribuito in modo determinante proprio una lezione di Salvatore Settis, il 24 febbraio 2000, presso un’auletta dell’allora Dipartimento di Storia dell’arte dell’Università Ca’ Foscari, dove la rivista, solo pochi giorni dopo, ha preso le mosse (v. l’Editoriale di Engramma n. 100, Centanni 2012). Il seme di Warburg – si trattava infatti di un seminario sull’Atlante Mnemosyne – una volta piantato ha messo radici profonde e dato vita a molteplici frutti. Il desiderio di comprendere la sua opera ne ha alimentato nel tempo lo studio, e il modello del Bilderatlas, con le sue tavole e le sue categorie, è ancora uno strumento euristico inesauribile, come lo è stato per Settis in Incursioni per la decrittazione di alcune opere di artisti contemporanei.
È questo sentirsi a casa, questa familiarità con l’impostazione del volume, che mi inducono a preferire un tono interlocutorio, a rivolgermi idealmente a Salvatore Settis per porre delle domande, che faccio anzitutto a me stessa e rilancio a un Maestro. Senza entrare nello specifico dei vari artisti e delle opere che sono affrontate nei diversi capitoli, preferisco indugiare nell’Introduzione, lì dove sono affrontate le questioni di fondo: gli obiettivi, i metodi, le discipline, i significati chiave messi poi in pratica nello sviluppo esemplificativo della trattazione.
I confini, i limiti e la possibilità di attraversarli sono il tema centrale nelle pagine introduttive. Steccati disciplinari anzitutto, tra storia dell’arte antica e storia dell’arte contemporanea, confini che invocano le competenze proprie della filologia, o la definizione esatta di tradizione classica, nel suo scarto o assimilazione a quella di tradizione artistica. Ma anche i limiti temporali, tra passato e presente, la frattura, la discontinuità, la tensione tra ‘antico’ e ‘contemporaneo’. La valicabilità o meno del confine pone il tema della barriera, l’interdizione al suo scavalcamento, o la forzatura per abbatterla. Sappiamo bene quanto Warburg abbia contribuito a forgiare una scienza interdisciplinare capace di valicare i confini, sappiamo quanto non temesse “i divieti delle polizie di frontiera” e, al contempo, riconosciamo quanto acuto fosse il suo approccio filologico, iper-attento al dettaglio, al contesto – culturale, politico, sociale – entro cui di volta in volta prendeva in considerazione una forma artistica. E sappiamo quanto abile fosse a decrittare soprattutto le trasformazioni e trasfigurazioni delle forme; aveva un fiuto formidabile per scovare in una forma inevitabilmente camuffata, risemantizzata rispetto al contesto di provenienza, il suo aspetto originario, celato ma non per questo meno riconoscibile.
Il senso della parola ‘incursioni’, scelta a titolo del volume, si comprende proprio in relazione ai confini, alle barriere. Non rivendicando un “campo” proprio, Settis afferma di compiere delle incursioni “ora in una direzione e ora in un’altra”. Campi che solitamente tengono alti gli steccati, e incursioni che si compiono “da un avamposto all’altro”. “Le incursioni – aggiunge Settis – dovrebbero farsi partendo da un luogo familiare e sicuro”, per tornarvi di tanto in tanto. Il guadagno di queste azioni è di sentirsi “straniero in ogni luogo, con tante insicurezze ma anche, ogni volta, con molta curiosità”. Il linguaggio militare tradisce la forza che bisogna usare in questi sconfinamenti di campo, quando a segnare i limiti sono per l’appunto alti steccati difficilmente valicabili, sorvegliati dalla “polizia di frontiera”, o quando le azioni sono condotte a scopo di furto o rapina.
Ma se devo associare oggi la parola ‘incursione’, con tutto il suo portato ‘marziale’ e trasgressivo, a un’azione che si collochi nel contesto artistico contemporaneo mi vengono in mente certe forme di attivismo. Penso ad esempio all’attivista politico congolese Emery Mwazulu Diyabanza, fondatore del collettivo panafricano Yanka Nku (Unité, Dignité, Courage – UDC) e del FMAS – Front Multiculturel Anti-Spoliation. Le ‘incursioni’ di cui è protagonista sono atti di riappropriazione di oggetti d’arte provenienti dall’Africa esposti nei musei europei, con la finalità di restituirli ai legittimi proprietari. Sono vere e proprie irruzioni che il militante africano compie nei musei, a volto scoperto, facendosi filmare da colleghi, e condividendo i video in streaming nei suoi canali social.
Non si tratta di furti – rivendica Mwazulu Diyabanza – ma riappropriazioni, letterali e metaforiche, di oggetti appartenenti alla cultura africana che, durante il periodo coloniale, sono stati razziati come bottini di guerra, per diventare poi parte di collezioni museali. Sono atti che denunciano l’oppressione storicamente subita dai paesi dominati, il colonialismo e razzismo che ne hanno guidato l’appropriazione da parte dei paesi occidentali. Azioni che rivendicano un diritto al recupero del patrimonio culturale, spirituale, per permetterne la ricostruzione identitaria. Atti sovversivi, indubbiamente, ma in realtà allineati con una tendenza sempre più condivisa anche da diverse nazioni a livello istituzionale: la questione della restituzione delle opere d’arte – che fino a un po’di anni fa poteva sembrare solo una provocazione – sta diventando lentamente, ma sembrerebbe inesorabilmente, un doveroso programma di cambiamento di paradigma da parte dei più importanti musei del mondo.
In questo caso, lo spaesamento ci viene dal subire le incursioni. Ma se lo spaesamento, l’insicurezza sono lo stimolo per alimentare la curiosità, la fame di ricerca, forse, dovremmo pensare che queste incursioni ci possano portare qualcosa di buono. La prima domanda è allora se oggi il problema della valicabilità dei confini non debba piuttosto uscire dalle dispute interne a uno stesso orizzonte culturale per rivolgersi al confronto – questa volta da pari a pari – con l’altro della cultura occidentale, aprendo le questioni squisitamente estetiche a problematiche etiche. Rispetto a questo cambio di prospettiva, non si caricherebbero forse di un peso differente i vocaboli chiamati in causa da Settis perché occultano la parola tradizione? Quali: ‘allusione’, ‘appropriazione’, ‘citazione’, ‘influenza’, ‘ispirazione’, ‘manipolazione’, ‘pastiche’, ‘prestito’, ‘riferimento’, ‘uso’; ma anche ‘confronto’, ‘furto’, ‘spolium’, ‘omaggio’, ‘parafrasi’, ‘prelievo’, ‘ripresa’, ‘traslazione’. Vocaboli rei di occultare inconfessabili debiti dell’arte contemporanea rispetto all’arte antica, o peggio, azioni di ‘assoggettamento’ dell’arte antica da parte di quella contemporanea.
Le forme dell’arte, ci insegnano Schlosser e Warburg – i due numi tutelari che guidano la riflessione di Settis – si trasformano nel corso delle epoche e degli artisti generate da “processi simpatetici di immedesimazione o empatia”. La relazione con l’altro – nella varietà delle sue implicazioni, che includono anche l’impossessamento, la prevaricazione, il dominio, l’alienazione – è imprescindibile per la creazione, trasmissione, rivitalizzazione della forma artistica, per la costituzione della sua identità. Ma quando l’identità, e i rapporti di potere che soggiacciono a essa, diventano il perno della questione, che ne è dei “passaggi di mano che non comportano la piena identità fra chi dà e chi riceve”? E che fanno il continuum della tradizione? Tradizione “vuol dire ereditare qualcosa e impadronirsene e trasformarlo in qualcos’altro”: possiamo tradere e ‘tradire’ tutto? Possiamo pensare a un continuum tra tradizioni di diversa provenienza?
Con Warburg abbiamo compreso che i meccanismi della tradizione, ammettendo salti, vuoti, cortocircuiti, anacronismi, hanno messo profondamente in crisi il modello evoluzionistico proprio della cultura occidentale. Lo stesso modello che alimenta il presupposto secondo cui l’arte contemporanea sia distante dall’arte antica e non riconducibile a essa. Ma la crepa che la tradizione così intesa mostra al modello occidentale europeo non è forse stato uno dei guadagni dell’affacciarsi di questo occidente a culture altre? A culture per cui la scansione temporale, ad esempio, non è concepita secondo un paradigma lineare e progressivo? L’elaborazione di questa nuovo modo di concepire la tradizione va di pari passo con quello che De Martino ha definito il “nuovo umanesimo”. La “scoperta delle genti transoceaniche che ha posto in primo piano una nuova modalità di rapporto con l’umano: la modalità dell’incontro sincronico con umanità aliene rispetto alla storia dell’occidente, e quindi anche la modalità dello scandalo e della sfida di tale alienità” (De Martino [1977] 2016, 324-325). Per l’antropologo questo nascente umanesimo introduceva potenzialmente a una “nuova dimensione valutativa”. Allora, lungi dall’alimentare, come ha fatto l’opera di conquista che è subito seguita alla scoperta, una prospettiva imperialista, la nuova dimensione valutativa non dovrebbe essere una revisione critica delle categorie che hanno puntellato i paradigmi dominanti della cultura occidentale?
Non è forse verso questo ‘incontro sincronico’ che andava Warburg quando nel 1895 intraprendeva il viaggio verso il Nuovo Mondo, verso quella che è stata rubricata come la scoperta della sopravvivenza dell'umanità primitiva nella cultura degli indiani Hopi dell'America del Nord? Una tra le vicende più, verrebbe da dire, ‘irrisolte’, della sua vita. Conosciamo il veto che Warburg aveva posto alla pubblicazione della “Conferenza sul rituale del Serpente” – quella che riteneva frutto dell’“orrida convulsione di una rana decapitata” (così Warburg a Saxl, nella lettera del 26 aprile 1923) – tenuta esclusivamente per guadagnare il lasciapassare per l’uscita da Kreuzlingen. Sappiamo anche quanto questa conferenza sia stata paradossalmente il suo primo testo più tradotto e letto. Sappiamo della ricca collezione etnografica che durante questo viaggio Warburg ha raccolto e portato con sé in Germania, per poi sbarazzarsene cedendola al Völkerkunde Museum di Amburgo. Warburg inoltre avrebbe voluto tornare in Nord America, ma le condizioni di salute degli ultimi anni della sua vita non glielo permisero (oltre al noto saggio di D. Freedberg, Pathos a Orabi, ciò che Warburg non vide (2004), per un recente rinnovato sguardo sul viaggio di Warburg si rimanda a Gualtieri 2021, 81-138: una presentazione in questo stesso numero di Engramma).
Tra l’altro nel 2014, presso Boudler, nel Museo d’arte dell’Università del Colorado, un tentativo di allestire una esposizione su questo viaggio con materiali raccolti dal Warburg Institute non ha avuto seguito perché alcuni docenti all’Università, appartenenti alle tribù indiane locali, hanno giudicato problematica l’esposizione di quanto ritenuto ancora legato a una visione colonialista e lesiva nei confronti agli eredi degli indigeni di un secolo fa.
Si è notato anche che, in quella mastodontica raccolta di immagini che è il Bilderatlas Mnemosyne, non appare alcuna immagine riconducibile a questo viaggio o alla cultura Hopi. Anche rispetto a questa omissione, non si conferma forse l’idea dell’Atlante come l’“osservatorio sismografico, dove l’ago-sensore che capta le onde e le registra è lo stesso Warburg”, che troviamo ribadita da Settis? (Incursioni, alla pagina 27).
L’obiettivo di Warburg, infatti, oltre a scandagliare le emozioni, gesti, ragioni dello stile delle forme artistiche nel contesto dello specifico periodo storico in cui erano osservate, era di “diagnosticare la crisi che attanaglia(va) l’Europa e il mondo”. Come specifica Settis la sua intensa sensibilità era tutta “per processi storici ma anche per la natura e la temperatura del proprio tempo”. È dunque la temperatura del nostro tempo che dobbiamo misurare, soprattutto quando questa si alza in concomitanza di crisi, conflitti, offendo indizi in forma di sintomi tutti da auscultare.
Un sintomo interessante a mio avviso si palesa evidente nell’ultimo capitolo che chiude il volume Incursioni, lì dove l’indagine di Settis si concentra sulla più giovane artista presa in considerazione, Dana Schutz. La riflessione si rivolge al quadro The Visible World (2018) che mostra, in un complesso di vari elementi, una donna nuda, stesa su una roccia in riva al mare, con un uccellaccio appollaiato sulle gambe, per ricondurlo all’antecedente antico della figura mitologica di Leda, accompagnata al Cigno/Zeus. Ma l’oggetto della riflessione è preceduto dal riferimento, direi sintomatico per la temperatura della nostra epoca, a un’altra opera di Schutz, la più famosa per le critiche che le sono piovute addosso: Open Casket (2016). Settis, pur non entrando nella questione, la riferisce per dovere di cronaca.
La controversia di Open Casket esplosa in occasione della sua esposizione presso la Whitney Biennal del 2017 di New York riguarda l’accusa di illegittimità fatta all’artista nel rappresentare un episodio cruento accaduto nel 1955 nel Mississippi alla comunità afroamericana, e divenuto storicamente un evento cruciale nella battaglia per la conquista dei diritti civili e la consapevolezza del razzismo negli Stati Uniti. Si tratta dell’uccisione cruenta a sfondo razziale di Emmett Till, un quattordicenne afroamericano da parte di due bianchi, mai peraltro condannati per tale linciaggio. ‘Open casket’ si riferisce alla bara, lasciata espressamente aperta per volontà della madre del ragazzo, durante i suoi funerali, perché fosse visibile a tutti la brutalità con la quale gli assassini ne avevano sfigurato il volto. L’intenzione di Schutz di rappresentare il volto del ragazzo, rimasto immortalato nelle fotografie dell’epoca, nella sua opera è profondamente osteggiata da chi l’accusa di non avere il diritto di appropriarsi di un dolore che appartiene alla comunità nera, con l’esito di spettacolarizzarlo. La polemica è articolata e ha avuto complessi sviluppi, ma basti riportare qui solo due aspetti tra i tanti interessanti: il fatto che la stessa opera esposta un anno prima in una galleria di Berlino non avesse suscitato alcuna critica e il fatto che, negli Stati Uniti, attorno a quest’opera si siano generate altre opere, come ad esempio quella attivista performativa dell’artista afroamericano Parker Bright. Quest’ultimo infatti si appostava davanti al dipinto di Schutz fissandolo fino a quattro ore di seguito, ostacolandone così la vista al pubblico, e indossando una maglietta con scritto davanti “Lynch Mob” e dietro “Black Death Spectacle”. E in questa postura, lo stesso si è ritratto in un dipinto che ha intitolato Confronting my own Possible Death (2018). Ecco un’altra ‘incursione’ nella forma della protesta attiva, agita e performata per rispondere politicamente a un caso foriero di questioni etiche, e in un contesto dove la dislocazione spazio-temporale dell’opera in questione fa problema e fa la differenza.
Allora, la domanda posta da Settis è certo pertinente per la riflessione tutta interna alla tradizione: “Ma possiamo usare categorie come queste anche per l’arte del nostro tempo, profondamente condizionata da una crescente ‘globalizzazione’ della cultura e del mercato artistico e da una drammatica accelerazione tecnologica?”. Ma sembra essere oggi ancora più cogente se la si rivolge a forme d’arte in cui è cruciale il contatto, il confronto, lo scontro con altre culture, tradizioni, non eurocentriche e storicamente dominate.
Riferimenti bibliografici
- M. Centanni 2012
M. Centanni, Editoriale da 0 a 100, “La Rivista di Engramma” 100 (settembre/ottobre 2012), 5-8. - De Martino [1977] 2016
E. De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali (1977), Nuova edizione a cura di G. Charuty, D. Fabre e M. Massenzio, Milano 2016. - Freedberg 2004
D. Freedberg, Phatos a Orabi. Ciò che Warburg non vide, in Lo sguardo di Giano, a cura di C. Cieri Via e P. Montani, Torino 2004, 569-611. - Gualtieri 2021
M. Gualtieri, Resartus. Viaggi scoperte e visioni di Aby M. Warburg, Prefazione di G. Bocchi. Postfazione di S. Inglese, Catanzaro 2021.
Per citare questo articolo / To cite this article: D. Sacco, Riappropriazioni. Incursioni verso dove?, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 362-368 | PDF
Ordini e incursioni del tempo
Antonella Sbrilli
“Time: the Familiar Stranger”
Julius T. Fraser, 1987
Paradossi e cortocircuiti della percezione temporale, eventi che accadono su scale diverse, lunghe durate, tempi locali, memoria, tracce: sono concetti che si affacciano – in contesti vertiginosamente differenti – in due libri: L’ordine del tempo del fisico teorico Carlo Rovelli e Incursioni. Arte contemporanea e tradizione dell’archeologo Salvatore Settis. I contesti sono davvero distanti, ma ogni tanto si sfiorano, nei punti dove l’analisi del fisico approda alla prospettiva umana (e si trova a citare Orazio, Agostino, Proust, Heidegger) e dove l’analisi dell’archeologo chiama in causa i processi entropici e le informazioni trasmesse nelle materie, o i tanti livelli di temporalità inestricabili che lo storico si trova a dover affrontare.
Partiamo dall’Ordine del tempo: dopo aver smontato le qualità del tempo come sono trapassate dalla fisica classica al linguaggio corrente (e cioè il tempo come qualcosa di uniforme che scorre dal passato al futuro, il presente come uno stato comune a tutto l’universo, l’ordine causale degli accadimenti), dopo essersi affacciato nel “mondo senza tempo” descritto dalla fisica attuale, Carlo Rovelli arriva a considerarlo dalla parte dell’essere umano, che è in qualche modo l’inventore del tempo, poiché è solo dalla prospettiva umana che il tempo è quello che è: “la sorgente della nostra identità”, “la forma con cui noi esseri il cui cervello è fatto essenzialmente di memoria e previsione interagiamo con il mondo” (Rovelli 2017, 161). Nell’attività del cervello, nelle cui sinapsi tracce di passato permangono e si modificano senza pausa, il tempo rivela per noi (e per i nostri limiti) il suo ordine, riversandolo nella nicchia biochimica dominata da ritmi circadiani, nel nostro punto di osservazione locale sul cosmo, nella nostra capacità innata di ricordare (e dimenticare) e nella nostra invenzione del linguaggio narrativo e artistico.
E arriviamo così alle Incursioni: il tempo del libro di Salvatore Settis si manifesta a questi livelli, dove entrano in gioco l’orientamento nel mondo, la perizia artigianale e l’invenzione creativa, la narrazione e la trasmissione di forme e complessi di significati. Il libro, con i suoi dieci capitoli dedicati ad altrettante opere di artisti del Novecento (di cui sette ancora attivi in questo XXI secolo), scandaglia i meccanismi della tradizione. Meccanismi che a volte sono diretti, a volte obliqui, ma sempre operanti, anche nel caso delle arti contemporanee, nate per lo più all’insegna dell’azzeramento e della frattura, o almeno della “squisita indifferenza” alle norme appunto tradizionali.
La definizione di “squisita indifferenza” (“fine disregard”) è di Kirk Varnedoe (1946-2003), che dalla sua esperienza di storico e curatore al Moma ha cercato di scalfire il topos dell’arte moderna come rifiuto secco della tradizione, insistendo sul fatto che Degas, Gauguin, Van Gogh, Picasso ecc. hanno manipolato dall’interno il corpus di norme rappresentative, combinando in nuove regole elementi sedimentati (Varnedoe [1990] 2016). La tradizione permane e agisce anche nelle discontinuità delle avanguardie, negli stravolgimenti concettuali, nelle innovazioni linguistiche portate dalle novità tecniche e tecnologiche. Come si legge in Incursioni: “Tradizione, insomma, vuol dire ereditare qualcosa e impadronirsene per trasformarlo in qualcos’altro” (Incursioni, alla pagina 13). Sin dall’inizio Settis espone in primo piano le figure che hanno indirizzato questi suoi attraversamenti diagonali dell’arte contemporanea: gli studi documentari di Schlosser sulla trasmissione delle pratiche artistiche e soprattutto il potente dispositivo dell’Atlante Mnemosyne di Warburg, che l’autore mette alla prova viva del presente, come “strumento euristico”.
E poi, alle spalle dei saggi, rammenta che ci sono i dialoghi personali con alcuni degli artisti raccontati in queste pagine, Bill Viola, Tullio Pericoli, Grisha Bruskin, Mimmo Jodice, William Kentridge, Giuseppe Penone e, indietro negli anni, anche Renato Guttuso. Possiamo immaginare i percorsi dello sguardo dell’archeologo – Wanderer sulle opere di questi autori, in cerca non di iconografie tout court, ma di processi profondi di passaggio, in cui le formule di pathos si presentano imbozzolate, o camuffate, ma in qualche modo riconoscibili, malgrado, o forse grazie anche alle mutazioni e alle contaminazioni incontrate nel viaggio. Anche dove i segnali del passato si captano con un certo agio, per esempio nella foto in cui la testa di Marcel Duchamp sembra tagliata e appoggiata su un tavolo, accanto alla moglie drappeggiata all’antica (1937), nel disegno di Guttuso per la morte di Neruda (1973), nella donna-Leda (2018) dell’artista americana Dana Schutz, nelle scene rinascimentali animate di Bill Viola, il discorso allestito da Settis procede sempre in modo da non ricorrere a uno schema di causa-effetto: l’autore accosta pezzi che aiutano a ricostruire tanti interi diversi, tutti attraversati dalla presenza in prospettiva di fonti, espressioni, gesti, pacchetti di informazione arrivati fino al presente, che chi legge deve spacchettare e ricomporre ergodicamente attraversando una rete di temporalità sovrapposte e interagenti fra loro.
Lo stesso sguardo diagonale e la bussola warburghiana consentono a Settis di avvicinare i paesaggi marchigiani di Tullio Pericoli alle centuriazioni romane, di individuare la presenza sotterranea di Dioniso nel film Il rito (1967-68) di Ingmar Bergman, di valutare la procedura archeologica come tecnica del contemporaneo in Bruskin, mentre nelle fotografie di Mimmo Jodice, dove il rapporto col classico è “autoevidente”, la tradizione diventa essa stessa materia prima del linguaggio creativo dell’artista.
Ritorniamo al tempo: nel libro, sono poche le pagine in cui il termine, o un lemma a esso collegato, non si affacci. Il settimo capitolo, dedicato a Giuseppe Penone, lo racchiude proprio nel titolo: “Giuseppe Penone: scolpire il tempo”. Il pensiero corre di lato a un testo di Marguerite Yourcenar (Le Temps, ce grand sculpteur, 1954), che dà il titolo a una raccolta della scrittrice del 1983 e che – a sua volta – è mutuato da un verso della poesia di Victor Hugo sull’Arco di Trionfo, tanto per restare nel movimento incessante delle formule. Un movimento lento è quello che Settis ripercorre parlando dell’artista piemontese, dei suoi interventi nei boschi, degli scavi interni al legno dei tronchi o della duplicazione di pietre con pietre e alberi con metalli. Qui la tradizione sprofonda nella dimensione mitica dei regni naturali e trova il suo faro in Ovidio, la cui poesia metamorfica coglie “l’incessante fluire delle forme e delle specie insistendo sui momenti di trapasso […] per suggerire che la mutazione non è solo il momento chiave del suo racconto, ma il cuore stesso della struttura del mondo” (Incursioni, alla pagina 193). Insieme al pensiero classico, la lettura di Penone è condotta con affacci su visioni ecocritiche attuali, e prende rilievo il tema dell’interconnessione dei fenomeni, che siano naturali o artefatti, inclusi noi stessi osservatori e osservatrici. Discutendo degli alberi bronzei di Penone, Settis chiama esplicitamente in causa le tre diverse temporalità che si intersecano in questa tipologia di opere: la lunga durata naturale, il lavoro minuzioso dell’artista e poi la percezione che ne hanno le persone, che a sua volta implica due dimensioni spazio-temporali; prima lo sguardo da lontano e poi il contatto tattile da vicino. A quel punto, l’inganno è svelato e l’osservatore è incluso per sempre nella vita della materia sfiorata e nella rete di informazioni elaborate.
Infine, una delle incursioni più dense è dedicata all’opera romana di William Kentridge, Triumphs and Laments, il lungo fregio sui muraglioni del Tevere, ottenuto togliendo la patina dal travertino, e che – dopo poco appena cinque anni dalla sua realizzazione – sta ormai svanendo. L’opera monumentale dell’artista sudafricano consente a Settis di tirare molte fila dei suoi interessi archeologici, storici, artistici e politici, offrendo un montaggio di forme e format che percorrono vichianamente la storia di Roma. Anche nell’attraversamento del fregio di Kentridge, definito un “gigantesco dispositivo memoriale”, Settis rintraccia l’impalcatura di Mnemosyne, per la stessa oscillazione, nel titolo, “fra trionfi e lamenti, che Warburg avrebbe chiamato ‘polarizzazione’ (Polarisierung)”, per la “mescolanza di alto e basso” nella scelta delle fonti citate, per “l’anacronismo degli accostamenti analogici tra le figure” (Incursioni, alla pagina 325).
La tessitura dei rimandi al passato è talmente fitta e il movimento nel tempo si fa tanto intricato che Settis ricorre anche a degli schemi visuali per fare emergere la stratificazione dei livelli cronologici che si intersecano in molti punti del fregio: il livello dell’evento rappresentato, quello dell’immagine scelta come fonte, quello definito dall’adiacenza ad altre figure. Sono schemi che a loro volta innestano catene di cortocircuiti temporali e anacronismi, intesi non come ‘fuori posto’, ma come compresenze di figure e accadimenti sotto un unico sguardo sinottico. Pur svolgendosi in orizzontale lungo una linea di mezzo chilometro, la linearità è estranea a quest’opera, che parla la lingua aggregante della memoria, con i suoi ingorghi, le zone nere e vuote, i camuffamenti e i ritorni. E pur essendo un’opera statica, si muove con chi la guarda camminando. E la nona incursione di Settis cerca di restituire su pagina sia la non linearità sia la mobilità storica e figurativa, simbolica e tecnica dei Trionfi e Lamenti di Kentridge.
William Kentridge, Refusal of Time Metronome, music Philip Miller.
Del resto, Kentridge è stato l’autore di un’altra impresa colossale, The Refusal of Time, una formidabile installazione multimediale, uno spettacolo, una ricerca sulla temporalità, a cui ha collaborato lo storico della fisica e filosofo della scienza Peter Galison. Presentata alla documenta di Kassel nel 2012, trasformata anche in un libro sui generis, l’opera mette chi partecipa in mezzo a una congerie di stimoli visivi, sonori e ritmici che generano una percezione del tempo multipla e discontinua. Il tempo ‘rifiutato’ è quello della standardizzazione oraria ‘capitalistico-coloniale’, decisa politicamente ed esportata via via in tutto il mondo, il tempo delle sincronie e delle cronologie diritte e progressive. A questa rappresentazione, l’arte è in grado di opporre tecniche e linguaggi che sovrappongono stati temporali e moltiplicano punti di vista. Sono gli scarti, le scomparse e i ritorni, le illusioni e i lampi che si producono nella memoria personale e condivisa, e nei suoi passaggi da un’epoca all’altra, da un emisfero all’altro. Inseguirli e raccontarli in una forma non lineare è la sfida contemporanea.
Riferimenti bibliografici
- Fraser 1987
J.T. Fraser, Time: the Familiar Stranger, The University of Massachusetts Press, Amherts 1987, ed. it. Il tempo: una presenza sconosciuta, tr. di L. Cornalba, Milano 1991 - Kentridge 2012
W. Kentridge, The Refusal of Time, texts by Peter Galison and William Kentridge. Conversations between William Kentridge, Peter Galison, Philip Miller, Catherine Meyburgh, Paris 2012. - Rovelli 2017
C. Rovelli, L’ordine del tempo, Milano 2017. - Varnedoe [1990] 2016
K. Varnedoe,Una squisita indifferenza. Perché l’arte moderna è moderna [ed. or.: A Fine Disregard. What Makes Modern Art Modern, New York 1990], trad. it. M.P. Ottieri, Milano 2016.
Per citare questo articolo / To cite this article: A. Sbrilli, Ordini e incursioni del tempo, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 369-374 | PDF
“Etimologicamente ‘confine’ non vuol dire barriera, ma l’opposto: un fine comune, condiviso” (Nizzo, Pizzo 2018, 17); scegliere come guida questa breve, fulminante osservazione di Pino Pucci, nella cui memoria è caro proseguire un dialogo a partire dal quale anche queste note sono state concepite, mi sembra il modo migliore per cercare di delineare quasi di scorcio la sfida non comune che Salvatore Settis con il suo nuovo Incursioni pone alla ricerca contemporanea. Non è solo la ricerca e la conquista di un terreno condiviso dell’antico e del contemporaneo – e di un metodo per l’attraversamento di tale terreno e per la leggibilità delle stratigrafie che lo compongono – ad essere qui in gioco, ma in modo non meno intenso l’individuazione di una rete di indici tematici che animano tale terreno e tale metodo, e insieme la scelta (supremamente autoriale qual è quella di uno dei maestri del nostro tempo) di una serie di immagini, nomi, eventi elettivi posti come pietre miliari lungo questo confine condiviso.
Proverò, nelle brevi osservazioni che seguono, a indicare uno dei possibili intrecci di questa rete avendo come mira essenziale una questione tematica saliente qual è quella del nesso fra la memoria e il vissuto, cercando così allo stesso tempo di seguire quella configurazione del metodo consegnata al discorso della morfologia, intesa come quel peculiare sapere che proprio nella vita dell’immagine, nella sua capacità di organizzare il proprio campo di significazione (penso a Bredekamp 2010), trova la sua strada maestra.
Tutt’altro che scontata e data per risolta, la relazione fra l’antico e il contemporaneo emerge viceversa nelle parole di Settis solo a costo del delinearsi di un terreno di scontro irto di cesure e di vuoti apparentemente non colmabili: Settis parla di una “onda d’urto dell’arte contemporanea” che appare aver realizzato una “drastica rottura” con il passato, così da comportare un “divorzio definitivo dai tempi lunghi della storia in nome di un presente che sempre si rinnova”, ma che appunto in tal senso appare immemore, “un perpetuo ‘oggi’ senza ‘ieri’” (Incursioni, alla pagina 9).
A fronte di questa cesura, è proprio nel riattivare una tensione laddove apparentemente la presa di distanza sembra aver annullato il gioco relazionale dei tempi e degli assetti tematici, che il discorso di Settis mette in gioco la propria ricchissima strumentazione metodica e ci offre preziose chiavi diagnostiche. Ed è in prima approssimazione attorno al significato stesso del concetto di tradizione che ruota la riflessione di Settis, mostrandoci come essa, nell’intreccio fra accezione filologica ed accezione giuridico-istituzionale, implichi sempre la consapevolezza di una “scansione temporale” e l’esclusione di una “piena identità fra chi dà e chi riceve”. E dunque, come diceva Mahler, tradizione non è adorare la cenere, ma custodire il fuoco – alimentandolo, chiosa Settis, “con la legna che noi stessi avremo raccolto ogni giorno”.
Se il detto mahleriano a sua volta è verosimilmente pensato quasi in risposta alla diagnosi nichilistica di Stefan George (“Tuffaste nelle ceneri / voi le pallide dita […] / Lasciate il focolare / è tarda già l’ora”, George [1897] 19903, 113), può risultare per noi chiarificatore distenderne ancora la vicenda metaforica sino alla ripresa – ancora qui intesa in funzione critica nei confronti del George-Kreis – operata da parte di Walter Benjamin nel grande saggio sulle Affinità elettive di Goethe: “Il critico cerca la verità la cui fiamma vivente continua ad ardere sui ceppi pesanti del passato e sulla cenere lieve del vissuto” (Benjamin [1924-25, 1955] 1982, 164). Se, in altre parole, il circuito di una trasmissione ininterrotta della tradizione risulta definitivamente spezzato, è proprio installandosi nel meccanismo di tale interruzione che la critica può istituire una forma di sapere in cui la memoria storica e il vissuto siano nuovamente in grado di dialogare, di fungere da sismografo del tempo presente, di progettare uno spazio possibile per l’innovazione culturale.
Lo spazio memoriale individuato in tal modo da Benjamin rivela nell’analisi di Settis un’affinità profonda con il Denkraum elaborato da Warburg nel corso di tutta la sua riflessione e in modo peculiare nell’approdo conclusivo al progetto di Mnemosyne, nonché con l’incessante teorizzazione condotta da Ejzenštejn intorno al montaggio nell’indagarne la potenza estatico-trasformativa non disgiunta dall’intrinseca natura patetica (Ejzenštejn 2020). Di più, proprio a condizione di non risolverlo vitalisticamente in una pura e semplice combustione del passato funzionale al presente, l’intero ambito di movimento del discorso benjaminiano si ritrova nella lettura che Settis propone della Pathosformel warburghiana:
Formel è la scorza, la ‘fredda’ convenzione espressiva e formale che si perpetua nel tempo; Pathos è l’ardente nucleo vitale che vi è contenuto, sempre pronto a esplodere, a generare incessantemente nuove forme (Incursioni, alla pagina 19).
Occorre intendersi: questa incessante produzione di nuove forme non ha nulla dell’energetica funzionalistica pronta a travolgere le ‘vecchie’ forme in nome di una inesauribile, e in ultima analisi cieca, produttività; si tratta piuttosto della generazione di forme di confine, forme che si attestano sul confine condiviso non solo fra passato e presente, fra tradizione e contemporaneità, ma in modo assai più impegnativo si pongono giusto nello iato temporale e formale fra l’‘onda d’urto’ dell’oggi e i tempi lunghi della storia, nella selva tuttora da indagare delle relazioni trasformative fra vissuto, memoria, storia, narrazione, neutralizzazione della memoria e oblio.
Letteralmente a tali ‘forme di confine’ è dedicato il più lungo e uno dei più impegnativi lavori che compongono il volume. Dedicato a William Kentridge e ai suoi Triumphs and Laments, concepiti come gigantesco fregio lungo le rive del Tevere, il saggio ci mostra in opera appunto tale funzione ‘di confine’ dell’immagine. Confine fra la città e il fiume, fra la forma storica e una (de)figurazione risolutamente inedita, fra composizione urbana e spazio residuale, e così via; confine – soprattutto – fra la memoria e la sua stessa scomparsa, fra l’iscrizione di una traccia frutto di un elaborato montaggio immaginativo e la sua inevitabile cancellazione, già iscritta nel fare dell’opera e prossima al suo compimento: “Il fregio va consumandosi e svanendo, trasformando la sua potente evocazione di persone e di eventi in un sommesso lamento su se stesso” (Incursioni, alla pagina 292).
È in questa sede impossibile, e probabilmente non necessario, provare a seguire la complessa trama delle significazioni e degli spessori storici e iconografici chiamati in causa da Settis; accontentiamoci invece di osservare, proseguendo i nostri accenni a Pathosformeln e discorso memoriale, come a giudizio di Settis la dinamica gestuale consegnata alle figure articoli “un circuito che può esser letto nei due sensi: secondo un processo di progressiva ‘cristallizzazione’ del linguaggio gestuale, o (nell’altro senso) di progressiva ‘liberazione’ degli schemi figurativi dal loro uso convenzionale” (Incursioni, alla pagina 293).
Non solo la narrazione distendendosi nei due sensi di marcia possibili del percorrimento del fregio implica insieme i differenti atteggiamenti della memoria storica sino all’oblio (ed ecco il riferimento di Settis al grande riquadro uniformemente nero occupato dalla scritta “QUELLO CHE NON RICORDO”, che “richiama la potenza e la vastità dell’oblio e implica la mise en abyme di tutto quel che vien ricordato e rappresentato nel fregio”, Incursioni, alle pagine 294-295), ma il fuoco del pathos si alimenta appunto delle osmosi di confine fra cristallizzazione e liberazione, e l’intenzione figurativa, nella sua stessa pressure for meaning (Kentridge 2008, 39), porta il segno della neutralizzazione della memoria ormai iscritta nella valenza ancipite che la caratterizza. Va aggiunto che tale processo di neutralizzazione costituisce forse l’unico possibile – ma proprio per questo anche ineludibile – punto di equilibrio di ogni processo di polarizzazione delle immagini.
Mi sembra insomma di poter dire che qui la sovranità dell’artista (Kantorowicz [1961] 1995, citato da Settis ancora a proposito di Kentridge) venga bensì riaffermata in proprio, ma in quanto essa in modo paradossale può agire come criterio d’ordine – come “voce della tradizione” – soltanto secondo un corto-circuito in base al quale essa si manifesta appunto nel sottolineare le asincronie del decorso storico e le cesure dei processi di identificazione nella trasmissione storica e memoriale del patrimonio immaginativo. Come scrive ancora Settis:
Ma la memoria umana non archivia né restituisce (come quella di un computer) intatte sequenze di eventi; al contrario, ne spezza il ricordo, ne digerisce i frantumi, li elabora, interpreta e riusa. Li scarta, li dimentica e li ritrova. Proprio come può fare un artista (questo artista) con il suo repertorio (Incursioni, alla pagina 325).
Ci troviamo qui in un ambito eminentemente politico di costruzione della memoria e della stessa identità autoriale; un ambito intensamente frequentato dalla riflessione artistica contemporanea, non solo in ambito figurativo, ma ad esempio anche in ambito critico e poetico, con risultati di straordinario rilievo in figure salienti del nostro tempo, come Winfried Georg Sebald e oggi Marija Stepanova. Nel loro declinare la questione della memoria anzitutto come costruzione di una identità autoriale molteplice e instabile, il lavoro letterario di questi autori, osserva Ilya Kukulin, giunge all’enucleazione di corpi finzionali dell’autorialità:
Questi corpi sono in qualche modo intermediari fra la coscienza autoriale e il mondo; al tempo stesso, sono personaggi che interpretano drammi simbolici che esprimono differenti caratteristiche generali del mondo (Кукулин 2001).
Ma per ritornare ancora – qui per noi conclusivamente – a Kentridge e alla lettura di Salvatore Settis, potremmo dire che è lo spazio urbano il luogo elettivo di questi corpi finzionali e della loro “agency” politica; lo spazio dunque di un’arte pubblica (così secondo le conclusioni del saggio di Settis su Kentridge, ma si veda anche Vercellone 2017, 80-85), certo integralmente da ripensare e da riaprire, anche qui nel segno della migliore tradizione morfologica, secondo una inesauribile economia trasformativa delle forme viventi.
Riferimenti bibliografici
- Benjamin [1924-25, 1955] 1982
W. Benjamin, Le Affinità eletttive, in Angelus novus. Saggi e frammenti [ed. or.: Goethes Wahlverwandschften, in Schriften], trad. it. R. Solmi, Torino 1982. - Bredekamp 2010
H. Bredekamp, Theorie des Bildakts, Frankfurt am Main 2010. - Ejzenštejn 2020
S.M. Ejzenštejn, Il metodo, vol. I, a cura di A. Cervini, Venezia 2020. - George [1897] 19903
S. George, in S. George, Poesie [ed. or.: Das Jahr der Seele, Berlin 1897], trad. it. L. Traverso, Firenze 1990. - Kantorowicz [1961] 1995
E.H. Kantorowicz, La sovranità dell’artista. Mito e immagine fra Medioevo e Rinascimento, [ed. or.: The Sovereignty of the Artist: A Note on Legal Maxims and Renaissance Theories of Art, New York 1961], trad. it. M. Balli, Venezia 1995. - Kentridge 2008
W. Kentridge, I Am Not Me, The Horse Is Not Mine / William Kentridge, Johannesburg 2008. - Кукулин 2001
И. Кукулин, Прорыв к невозможной связи, “Новое литературное обозрение” 50 (2001). - Nizzo, Pizzo 2018
V. Nizzo, A. Pizzo, Antico e non antico. Scritti multidisciplinari offerti a Giuseppe Pucci, Milano 2018. - Vercellone 2017
F. Vercellone, Il futuro dell’immagine, Bologna 2017.
English abstract
Salvatore Settis's recent book, Incursioni. Contemporary art and tradition (Feltrinelli 2020) intercrosses the boundaries of the history of art, contemporary and beyond, of philology and antiquity, of philology and of the history of the classical tradition, of philology and anthropology. Therefore, Monica Centanni and Giuseppe Pucci invited archaeologists, art historians, philologists, anthropologists and philosophers to compose a choral reading about Settis' work, corresponding to the various solicitations that the book provokes. All scholars who have participated to the collective reading – Anna Anguissola, Maurizio Bettini, Marilena Caciorgna, Maria Luisa Catoni, Monica Centanni, Maria Grazia Ciani, Claudia Cieri Via, Gabriella De Marco, Giuseppe Di Giacomo, Elisabetta Di Stefano, Eva Di Stefano, Roberto Diodato, Dario Evola, Claudio Franzoni, Maurizio Harari, Franco La Cecla e Anna Castelli, Alessandro Poggio, Valentina Porcheddu, Daniela Sacco, Antonella Sbrilli, Salvatore Tedesco – have responded, in the style of each author, with a plurality of form, such as short essay, with bibliography and images, general analysis of Settis’s volume, in-depth studies on one of the themes, reflections on tradition and contemporaneity.
keywords | contemporary art; classical tradition; Salvatore Settis.
Per citare questo articolo / To cite this article: S. Tedesco, La cenere e il fuoco, “La Rivista di Engramma” n. 180, marzo/aprile 2021, pp. 375-380 | PDF